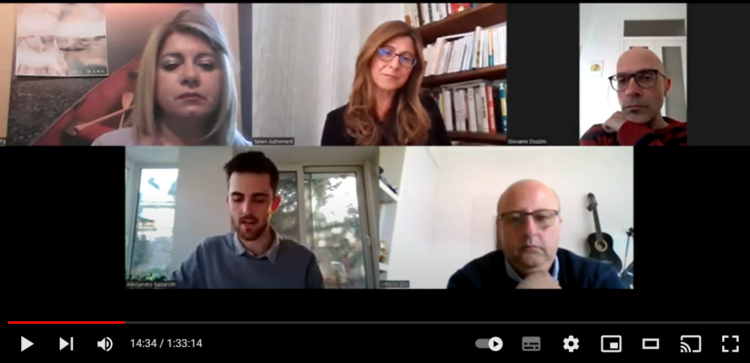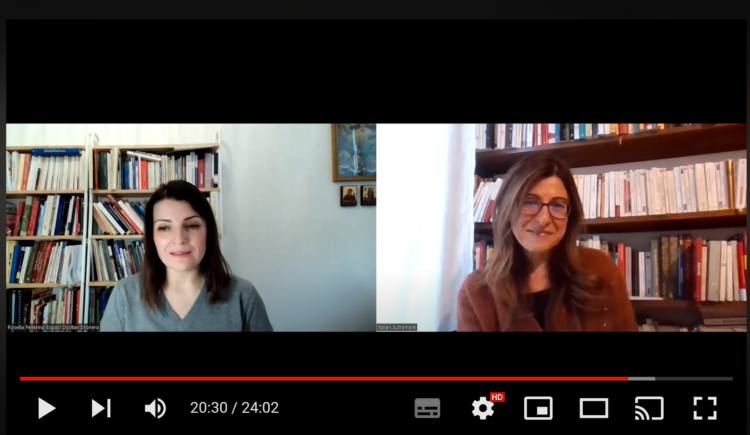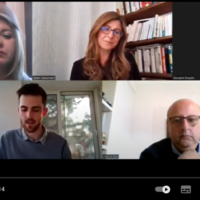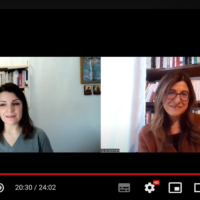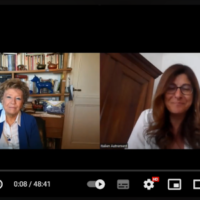La terra ci appartiene, è luogo di riferimento, è casa, è vita, è la persona che siamo oggi, ma anche quello che siamo stati ieri. I suoi frutti sono relazioni affettuose, danno un senso ai luoghi che abitiamo perché ciascun territorio è una narrazione e ha qualcosa da raccontarci. In questo legame così forte ci riconosciamo. È ciò che troviamo in Poesie vegetali /Green Poems di Lino Angiuli, collaboratore dei servizi culturali della Rai e di quotidiani, condirettore della rivista letteraria “Incroci”, tra i massimi poeti italiani.
Si tratta di un’opera antologica bilingue scritta in italiano e in inglese per le edizioni di Pagina a cura di Maria Rosaria Cesareo che ha selezionato una parte simbolica del lavoro poetico di Angiuli fin dai suoi esordi per quindici raccolte e di Barbara Carle che ha lavorato con grande maestria alla non facile traduzione, trasportando così la poesia del nostro autore dall’altra parte dell’oceano, sino ad arrivare negli States, con un bastimento carico di memorie, di visioni e di nostalgie di un intero percorso esistenziale. “Un’immersione nella madreterra, una vera e propria dichiarazione d’amore e d’intenti”, scrive la Cesareo nell’introduzione.
Come un menestrello dalla voce di allodola e dal corpo di ulivo, Angiuli canta la terra della luce e delle pietre parlanti, dialogando con un carciofo o con un cappero, dichiarando che in un tempo di smarrimento come il nostro, forse il basilico ci salverà: “Lo chiederò dunque al ruvido carciofo introverso/al carciofo che verso dicembre/se ne andiriviene a testa alta/lungo il carattere ansioso del penultimo adriatico/[…]al carciofo che mi implora di essere narrato/tra tirchi spezzoni di acca due o/tra qualche decapitato parente di trullo/tra certi ripostigli di noia estiva/costruiti con teschi di masserie defunte/[…]al carciofo inseguito dal sale/dal mio bisogno di parlargli”.
Il bisogno di parlare, feroce, insistente. È lontano l’Angiuli stilnovista e provenzale di Amar clus. L’autore ci mette ora davanti a una riflessione sospesa, perché mancano le parole per raccontare lo stupore e il tremendo, rimane solo un quesito aperto: “? perché non provi a metterti nel pianto/nei panni di un albero/che da tempo non trova più figli/tra le rughe del ventre zitto/[…]e la notte non chiude mai occhio/a sentire il suo cuore di legno/rinchiuso in una stanza di silenzio vegetale/e fuori magari c’è anche la neve/un albero analfabeta/che vuole parlare del verde del giallo/e non ha che sei foglie per farlo”.
La poetica di Angiuli è stata spesso definita “Umanesimo vegetale” per l’immersione nella flora mediterranea di cui la Puglia è sovrana. Così tra il disincanto e l’incanto, tra le trame di un tessuto linguistico immaginifico, esuberante, ricco di neologismi, quasi un gramelot, ti ritrovi tra una “melissa officinalis” e una “menta piperita”, tra un “coram populo” e un “orate frates” o tra le sentenze salutari della scuola medica salernitana di federiciana memoria: “foglie di prugne rinfrescanti/profittevoli e purganti […]del finocchio le sementi/fanno uscir dell’ano i venti[…] cara melissa officinalis/che cerchi con la menta piperita/di ostacolare l’irracidirsi della vita/osannando l’utero della natura/proprio all’imbocco della fognatura/anche se può sembrarti brutto assai/voglio cantare ruttando più che mai”.
A tutte queste “parole che non vogliono essere eppure lo sono”, non può bastare una lingua unica e omogenea. Il poeta così mette in campo una sperimentazione plurilinguistica valorizzando il lessico con forme dialettali, con latinismi, con inglesismi, con lemmi popolari, con espressioni colte ed elevate, e dunque, dantescamente parlando, questo lavoro va definito come un’operazione universale, un’opera totale: “A sud l’universo confina con la storia del cardo/il cardo che continuamente si rimette in tasca/l’ipotesi di luce che gli torna in gola/[…]questo strapuntino di terra timbrata/dallo stesso parallelo che ci fu cordone/e che qualcuno ancora intende usare per legaccio/ignorando il profumo dell’asparago/io credo nel dio del vento che significa/nel dio del vento che parla al futuro”.
Credere nel dio del vento significa credere nella visione, quasi a volere esorcizzare una paura atavica. Per Lino Angiuli è necessario, anzi è vitale lasciare traccia di sé in un testamento poetico-spirituale che metterà radice nel tempo che verrà, perché quel “gelso sprovvisto di futuro” finalmente ne abbia uno: “Ma il levante eterno adolescente/lui rimane dalla parte del sangue/spingendo il cappero alla conquista dei castelli/di origano c’inonda di pasque e di limoni/convince il fico a riaprire il dolce sesso/l’aglio ad essere soprattutto se stesso”.
Forse, il senso primo di questo lavoro è tutto concentrato nell’avere cura di noi. Siamo l’eterna insicurezza: un po’ andiamo avanti, un po’ ci fermiamo. Angiuli ci esorta, invece, a fermare lo sguardo e la nostra attenzione sulla madre terra con la parola-luce, con l’apertura e la veggenza che solo la poesia ha. L’autore ci urla che in questo presente è importante la cura e ciò che ci tiene in vita sono esclusivamente l’aria, l’acqua, le piante. Siamo fatti di questi elementi ed è nostro dovere riconoscere l’identità tra noi e la terra. Imparare dal fiore, dall’albero, dall’humus perché siamo di terra e di spirito: “Almeno una volta vorrei nascere albero da frutto/mungendo il succo dai verbi che stanno sottoterra/lo vado dicendo a chiunque ha pane per gli orecchi/che voglio abituare il cervello ad abitare caposotto[…] per intanto voglio morire di vita e vivere di morte/come un albero da frutto che conosce la sua sorte”.
Apparteniamo all’universo, siamo un tutt’uno, siamo una piccola parte di esso. Francesco d’Assisi lo aveva già interamente avvertito. Ci sono dei vegetali che sono molto più antichi di noi che, pensandoci bene, abitiamo solo da poco tempo la terra. E allora chi siamo? Per questo l’autore ci avvisa che non c’è più tempo, non c’è più durata se continuiamo a non vedere, a non avere orecchi, a non volere ritornare alla terra: “Quando morirò/fatemi morire in un giorno d’inverno/lasciate che il vento bestemmi/che il cielo s’ingrugni/che i cani piangano/quando morirò/avrò bisogno/di sentirmi meno vivo./Datemi un po’ di terra/senza sole/sepolta nell’ombra/e un fiore patito/sul mio cuore di morto/quando morirò/avrò bisogno/di sentirmi a casa mia”.
Anita Piscazzi
« Tutto lo mondo si mantien per flora », Sonetto XXV o VII, Bonagiunta Orbicciani(1220-1296)
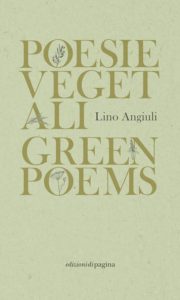
POESIE VEGETALI /GREEN POEMS
Lino Angiuli
A cura di Maria Rosaria Cesareo e Barbara Carle
Edizioni di Pagina, Bari 2021,pp.143.