Il trenta agosto del 1939 sette detenuti del campo di concentramento di Sachsenhausen, località a nord di Berlino, furono trasferiti nottetempo a Buchenwald, a sud della capitale. Quel viaggio, di circa trecento chilometri, era stato compiuto in senso contrario da uno dei prigionieri, un polacco di nome Ivo Nikolic, due anni prima, nel 1937, insieme a altri internati – fra i primissimi a essere trasferiti nella succursale di Oranienburg, in quanto appartenenti a gruppi dichiarati razzialmente e biologicamente inferiori. Nella nuova residenza Nikolic fu fatto oggetto delle attenzioni, che dovette giudicare perverse, della sorvegliante Ilse Köhler, segretaria presso il centro. I lineamenti dell’uomo, tipicamente slavi – fronte spaziosa, viso affilato, capelli chiari, occhi vividi e fissi –, avevano attirato l’interesse della donna, volto soprattutto agli esperimenti medici avviati sui detenuti dall’ufficiale delle SS Karl Otto Koch, comandante del campo di Buchenwald, riservato ai prigionieri politici. Nell’intento di rendere più efficace l’organizzazione e il controllo degli esperimenti, ne era stata mutata la sede, preferendo quella più vicina a Berlino. Durante le procedure di trasferimento dei detenuti coinvolti come cavie, Ilse Köhler conobbe suo marito. Dopo aver preso il cognome Koch, Ilse nel 1937 seguì il consorte a Buchenwald, rinunciando forzatamente al suo interesse per il prigioniero polacco. Non dimenticò il suo tzigano; ne ricordava bene il tatuaggio disegnato sulla schiena: un Cristo in croce dalle cui mani sgorgavano gocce di sangue, riversandosi dalle scapole sui fianchi. Il suo interesse per quell’immagine, a ragione ritenuta sacrilega, attendeva di trovare soddisfazione. Il motivo per cui il detenuto era stato trasferito a Buchenwald, insieme a altri sei prigionieri, tutti piuttosto simili nei tratti del volto e nella corporatura, non aveva però nulla a che fare con i desideri morbosi della Fraülein Ilse. Lo stesso giorno erano arrivate al campo anche alcune casse il cui contenuto era noto solo a suo marito e ai suoi più stretti collaboratori, fra i quali il capo maggiore delle SS Hermann Pister. La donna evitò di domandare chiarimenti; a Buchenwald, del resto, non occupava formalmente alcuna carica. Il comandante Koch aveva messo al corrente sua moglie solo delle informazioni strettamente necessarie: «Sette prigionieri arriveranno stanotte da Sachsenhausen. Saranno posti in isolamento». A quella notizia la donna aveva tradito un moto di piacere: una luce inequivocabile si era accesa nei suoi occhi. Il ricordo di Ivo, come un alberello cresciuto storto, si piegò fino a sfiorare il sorriso di Ilse – per troppo poco tempo quell’uomo aveva goduto del privilegio delle sue cure particolari. Il marito conosceva le inclinazioni della donna che aveva sposato; la informò: «Ivo è fra i prigionieri», la bocca di Ilse s’illuminò per la seconda volta, quel giorno, «Ma non potrai concentrarti su di lui. Forse rivederlo. È destinato, con i suoi compagni, ad altri scopi». La donna assentì, non pose domande né fece commenti – non le sarebbe stato concesso conoscere altri particolari.
Quella notte Ilse la trascorse in attesa. Il trambusto di automezzi in manovra oltre il grosso cancello d’ingresso la colse assorta. L’orologio del blocco di avvistamento segnava circa le due – dalla sua postazione non poteva vederlo. Lo scorsero gli uomini fatti scendere dal furgone parcheggiato fuori dal campo e rapidamente avviati dal maggiore Pister e da alcuni sorveglianti verso una porta laterale comunicante con i primi uffici di Buchenwald. Furono fatti rapidamente passare attraverso il piazzale fino al blocco dove erano state allestite le loro celle. Durante quel breve tratto Ilse sperava di rivedere il suo uomo. Non si era coricata. Non voleva carpire segreti spartiti fra soldati impegnati a intessere trame di una gravosa guerra; intuiva sarebbe stato impossibile incontrare il suo uomo. Ivo, attraversando lo spiazzo, in fila dietro i compagni, com’erano abituati a spostarsi in simili frangenti, privo di catene e per la prima volta, da anni, vestito con semplici abiti da civile, alzò il capo verso il cielo di silice di quel mattino del trenta agosto. La temperatura era mite e il cielo ancora sgombro da nuvole. Ivo sapeva che Ilse doveva trovarsi da qualche parte in quell’edificio: la notizia del suo matrimonio e del suo conseguente trasferimento a Buchenwald era nota. Non poteva sospettarla, in quel momento, dietro i vetri della finestra illuminata affacciata sul cortile nel quale loro si muovevano spediti. Dietro il suo forzoso trasferimento intuiva, con orrore, i desideri cupi di quella donna. Neppure lei individuò il suo uomo nel gruppo; era troppo buio: si scorgevano solo indistinte figure muoversi sul terreno.
Non appena il gruppo di prigionieri e di sorveglianti giunse nel blocco 8, i sette detenuti furono fatti sedere intorno a un tavolo. Il maggiore Pister scambiò un secco botta e risposta con il caporale di turno, poi sparì dietro una porta, avviandosi per un corridoio poco illuminato.
Nikolic e i suoi compagni si guardavano, la loro rassegnazione era pure tempestata da domande. Pochi minuti; dalla stessa porta dalla quale il maggiore si era allontanato, fecero ingresso due uomini in uniforme con dei vassoi. Veniva loro offerto di che rifocillarsi: carne, patate, cetrioli, pane nero e della birra. Ivo ne fu rallegrato; quel cibo lo confortava per due ragioni: la fame, e d’altra parte era convinto, una volta a Buchenwald, sarebbe stato sottoposto a una dieta più ferrea di quella a cui era abituato a Sachsenhausen. Si faceva largo in lui un’idea odiosa, emersa già dopo il primo incontro avvenuto con Ilse Köhler anni prima: tornava a chiedersi se il suo tatuaggio aveva a che fare col trasferimento, imprevisto e frettoloso, a Buchenwald, dove mai avrebbe creduto di dover ritornare. Aveva davanti a sé un piatto fumante e c’era dell’altro a confortarlo: tre dei suoi compagni non avevano tatuaggi. Se l’era fatto confidare durante il viaggio di ritorno – a buon diritto poteva chiamarlo a quel modo.
Il comandante Karl Otto Koch portava occhiali scuri; la cortina densa del fumo della sigaretta salì a lambirgli i vetri neri delle lenti animando il suo volto. La luce rossastra delle lampade dava alle forme una morbidezza insufficiente a mitigare l’asprezza del luogo e della situazione. Karl non diede il benvenuto ai nuovi arrivati né si sedette. «È la fortuna a condurvi qui», il tono frettoloso più che freddo. «Le nostre truppe sono impegnate da mesi in esercitazioni al confine con la Polonia; prenderete parte al programma.» Nessuno dei prigionieri osò pronunciare una parola né porre domande. Tenevano la testa e gli occhi bassi, evitando quelli del comandante. Qualcuno, stando bene attento a non compiere movimenti bruschi, di tanto in tanto si volgeva verso uno dei sorveglianti, per ricadere immediatamente con lo sguardo nel piatto davanti a sé. Chi non era riuscito a finire il suo pasto si guardava bene dal masticare o ingurgitare cibo in presenza dell’ufficiale di campo. Uno di loro, un ucraino di nome Taras, si pulì la bocca col dorso della mano; restò un momento sospeso, non sapendo cosa fare delle dita unte. Poggiò la mano pulita sull’altra e si immobilizzò, gli occhi fissi sul tavolo. In quel momento il maggiore Pister ricomparve dalla porta lasciata aperta dal suo superiore. Il comandante non aveva intenzione di spaventarli, neppure sembrare rassicurante. I prigionieri erano troppo abituati ai modi spicci dei carcerieri; ogni accenno a una qual pur minima benevolenza avrebbe finito per destare sospetto. «Farete parte del programma di addestramento. Domani sera è prevista una missione ai confini con la Polonia. Indosserete delle uniformi.» Indicò una cassa poggiata su una panca, contro il muro sul lato opposto dello stanzone; uno dei sorveglianti andò ad aprirla. «Avrete anche armi d’ordinanza.» Indugiò, come per uno scrupolo – in una diversa circostanza avrebbe potuto tradirsi –, poi si avvicinò al tavolo, spense il mozzicone nel piatto di uno dei prigionieri e disse: «Scariche», si riferiva alle armi. Prese una pausa soffiando dalla bocca quel che restava del fumo della sigaretta. Un soldato aveva aperto la cassa e ordinatamente ne stava tirando fuori uniformi dell’esercito regolare polacco. Giacche corte di sacco – alla spalla sinistra, ricamata in canottiglia, l’insegna della Sirena del Drugi Korpus. Più in alto una toppa rossa su cui spiccava la scritta POLAND. «Simulerete un attacco a una stazione radio.» Il comandante ebbe un sussulto, la sua voce si sciolse in un effluvio. «Truppe tedesche in addestramento sono state allertate. Si aspettano un’irruzione; non sanno a quale postazione né quando avverrà.» I prigionieri ascoltavano in silenzio; attendevano delucidazioni non osando chiederle. Si stavano ancora domandando il motivo della loro presenza in quel campo conosciuto da Ivo assai bene anni prima. Dovevano credere a quelle parole pronunciate con tanta superflua precisione? Nikolic, rincuorato – dunque la signora Koch non c’entrava in tutta quella faccenda –, dosando bene il suo ingresso in quel discorso fatto di molti silenzi e del suono di una sola voce, disse, pausando le sue parole, fermandosi più a lungo dopo il primo «Saremo», poi continuò, guardando dal basso il comandante Karl Otto Koch, «Saremo fatti prigionieri», il tono della voce sospeso fra l’affermativo e l’interrogativo. L’ufficiale lo guardò, poi, distrattamente, agli altri prigionieri: «Parteciperete a diverse operazioni di addestramento nei prossimi mesi, e usufruirete di condizioni meno pesanti di quelle a cui eravate sottoposti a Sachsenhausen.» Si poteva pretendere una migliore risposta?, porre altre domande? C’era di che rallegrarsi, invece. Il respiro dei detenuti si fece più calmo; i muscoli, rilassandosi, provocarono un coro spontaneo. I prigionieri si guardarono per richiamarsi al silenzio. Il comandante Koch rivolse un saluto al suo vice, il maggiore Pister, e lasciò la sala. L’ufficiale parlò ai sorveglianti; i prigionieri furono accompagnati nelle celle. Dormirono qualche ora, alle sei furono svegliati; bevvero del caffè tiepido nel quale inzupparono pane di segale. Il tempo di indossare le uniformi e furono caricati su un camion. Iniziò così il loro viaggio verso il confine polacco.
Il furgone sobbalzava sul terreno sconnesso; per quegli uomini altrettanto dolce come essere cullati. I prigionieri, e ora soldati, erano avvezzi alle uniformi e ai gradi. Tra le giubbe, tutte militarescamente uguali, risaltava la casacca di Nikolic, più ricca di decori. «Sei tu il comandante», gli fece in tono di scherno uno dei compagni, «Ci dirai tu cosa fare.» La voce dell’uomo aveva provato a essere gioviale, a somigliare a qualcosa da scambiare con l’allegria; un surrogato, come tutto ciò a cui si erano abituati in quegli anni: il cibo, le vesti, le loro esistenza di ombre. Quel giorno sembrava destinato a finire. Dopo ce ne sarebbe stato un altro. Potevano fingere di credere a questa nuova illusione, farla somigliare a una speranza. Ricominciare a intrattenere se stessi e attendere il compimento dell’illusione più grande – e insieme la sola certezza in grado di farli diversi da tutti gli altri uomini, come se quel destino, comune a tutta l’umanità dall’origine, incombesse solo sulle loro esistenze. Non avrebbe mancato al suo appuntamento; sarebbe arrivata in anticipo anche sul tempo concesso loro dal destino: prima della fine. Da tempo i loro giorni da prigionieri consistevano nel sostituire una speranza con un’altra. Era sufficiente che il giorno iniziato sembrando dovesse essere l’ultimo, potesse arrivare a finire. Sarebbero morti? Avrebbero avuto di che sfamarsi? Già solo poterselo domandare.
La tensione non si allentava; da un intero giorno un morso teneva unito un lembo di stomaco a un grumo di cervello. Il poco sonno loro concesso aveva nascosto alla coscienza i tormenti senza farli svanire dal corpo. Sogni erano venuti a visitarli; non si erano fissati nella memoria ma in ferite profonde della carne – a rinsaldare l’angoscia –, immagini di volti i cui tratti incerti avevano la consistenza di segni neri tracciati sull’acqua.
Il convoglio, composto da due auto e da un camion, giunse nei pressi di Gleiwitz, al confine con la Polonia, il pomeriggio del trentuno agosto. Gli uomini furono lasciati sul mezzo ad attendere, sorvegliati da un drappello di soldati; diedero loro, a turno, il permesso di scendere, sgranchirsi le gambe e soddisfare i bisogni. Poco più distante, in un campo allestito per l’occasione, gli ufficiali sembravano intenti a manovre di guerra. Doveva essere poco più di un gioco, eppure avevano espressioni serie, compenetrate. All’imbrunire ai prigionieri furono iniettate anfetamine sotto forma di benzedrina. Neppure stavolta osarono porre domande. Dopo un breve riepilogo del comandante del convoglio, il sottufficiale Dietmar Winkler, la pattuglia di sette soldati polacchi fu invitata a raggiungere la stazione della radio locale, un lungo e basso edificio scuro a due piani con tetto spiovente posto fra due tralicci dell’alta tensione. «L’obiettivo è raggiungere la stazione radio prima di essere individuati e fermati.» Ascoltavano; il loro vero interesse era rivolto agli sguardi di chi parlava, a indagare il tono della voce. «Farete irruzione gridando slogan antitedeschi», suggerì, ridendo malignamente, il sergente Winkler. Eppure quella risata, per quanto forzosa, riuscì a mettere di buon umore i prigionieri.
Appena ricevuto un chiaro cenno dal sergente si avviarono in fretta per la radura, la sola via possibile per raggiungere il casermone lontano ma ben visibile fra i tralicci. Intorno, nessun segno di presenza umana. Il silenzio in cui avanzavano sembrava tornire anche le nuvole. Taras, l’ucraino, chiese agli altri se pensavano che fosse una trappola. Uno degli uomini rispose che tutti quei fastidi solo per accoppare sette dannati prigionieri slavi era troppo anche per dei tedeschi. Ivo rise a quella battuta, e con lui, di nuovo, risero i suoi compagni. La voglia di mettere da parte ogni pensiero, adesso, era più forte del tremore, più urgente della stessa paura acquattata dentro di loro a rivestire braccia, gambe, ogni muscolo, come una patina di sudore maleodorante – non sarebbe stato mai più possibile lavarla via.
Adesso vedevano bene il casermone, era lì a poche centinaia di metri. Non avevano incontrato nessuno né scorto postazioni di soldati o posti di blocco. Che razza di esercitazione era quella? Strinsero ancora più forte le mani intorno ai fucili, benché non potessero servire loro che da bastoni, e si avviarono per un tratto di terreno. Gli alberi erano distanti; non potevano sapere con certezza se nascondessero soldati in appostamento. Raggiunsero l’obiettivo percorrendo gli ultimi metri di corsa. Davanti alla porta rimasero per lunghi secondi in attesa: il pericolo, sospettavano, non poteva venire se non dall’esterno di quel casermone. Cosa li rassicurò, quale segnale scorsero fra gli alberi distanti? Tenendo fede al suo ruolo di capitano, Ivo Nikolic aprì la porta dell’edificio e uno alla volta fecero ingresso nello stanzone al grido di “Nazistowskie Niemcy, śmierć”, in un gioco liberatorio e autorizzato, capace di animare l’ombra in cui da tempo erano costretti a vivere.
Ivo fu il primo a cadere sotto il fuoco che per bizzarria della sorte potremmo definire “amico”. A sparare era stato il maggiore Pister; si era messo in viaggio per Gleiwitz con i suoi uomini alcune ore prima del convoglio dei prigionieri. Seguirono altri colpi sparati dalle SS. Taras, l’ultimo a entrare, fece a tempo a fare dietro front e lasciato cadere in terra il fucile, si mise a correre verso la radura. Non sperava, una volta raggiunto il bosco, di trovare fra gli alberi un rifugio in grado di difenderlo a lungo. Il suo corpo non fece altro che correre, null’altro, quasi neppure respirare. Non fece neppure in tempo a pensare alla morte; cadde riverso, l’erba umida gl’impregnò il viso col freddo distacco di lacrime indifferenti. In pochi secondi i corpi di sette soldati dell’esercito regolare polacco giacevano sul pavimento della stazione radio.
La notizia dell’attacco alla Germania fu data dal Führer in persona. Le grida del drappello d’invasori e gli spari furono fatti ascoltare a tutta l’Europa. Il primo settembre le truppe tedesche già allertate e ammassate al confine, iniziavano la loro avanzata in terra polacca. L’operazione Himmler si era svolta con successo. La prima vittima della guerra si chiamava Ivo Nikolic. Nessuno avrebbe mai conosciuto il suo nome; i corpi esposti perché giornalisti e commentatori stranieri potessero prenderne visione e avere conferma della provocazione polacca alla Germania di Hitler, erano solo sei. Il corpo di Ivo fu trasportato a Buchenwald immediatamente dopo la conclusione delle operazioni, il cadavere affidato alle cure premurose della moglie del comandante Koch – un omaggio di suo marito.
— foto: Buchenwald, 16 avril 1945 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buchenwald-J-Rouard-01.jpg)


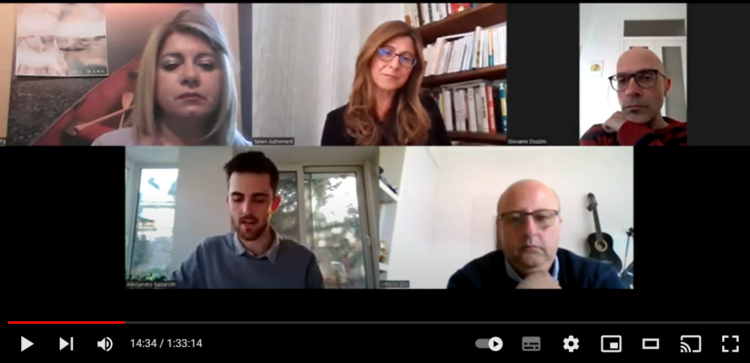

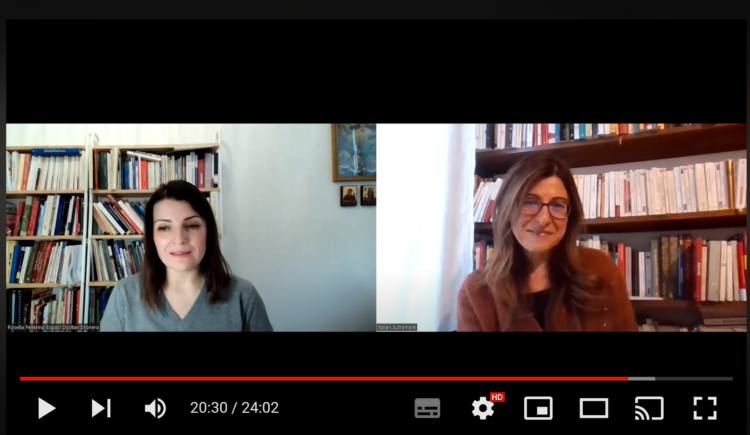
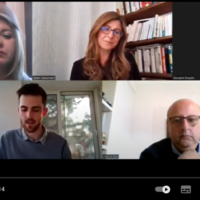

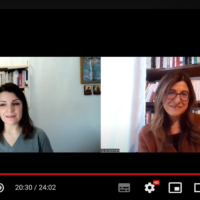

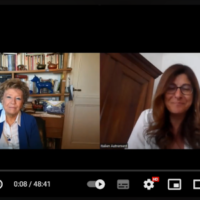








Comments
Ciro Caliendo
Ho colto ritmi sia nel susseguirsi delle parole e dei periodi che nelle tensioni e risoluzioni psicologiche. Bravo . Abbracci
roberto lombardi
to Ciro Caliendo
Signor Caliendo, cogliere il ritmo, nella scrittura, non è da tutti, ancor più negli aspetti psicologici; grazie. Anche per gli abbracci che ricambio.
ileana
grigio-triste eppure leggero da leggere
roberto lombardi
to ileana
Signora Ilena, come autore, le sue parole mi fanno particolarmente piacere. La ringrazio.
roberto lombardi
La perdita di memoria che si trasforma in alterazione psichica, come lei indica, è davvero un male dei nostri tempi. Non il solo. La ringrazio.
Emiddio
Oggi, dopo il 2020, e con questo 2021 in corso ha la sensazione che molti possano avere una sorta di ecmenesia. Per chi ha vissuto quegli […] Read MoreOggi, dopo il 2020, e con questo 2021 in corso ha la sensazione che molti possano avere una sorta di ecmenesia. Per chi ha vissuto quegli anni o gli strascichi ed oggi vede, in maniera, diversa la morte in faccia. Viceversa chi è completamente fuori dal tempo e dimentica che questo periodo non è uno di quelli da ricordare con nostalgia come è stato per l'olocausto. È un parallelo forte ma per certi versi ci sta. Opere come quella di Roberto Lombardi servono non solo a ricordare ed a prendere atto di scempi ma anche, in qualche maniera, per dire sveglia! IMHO Read Less