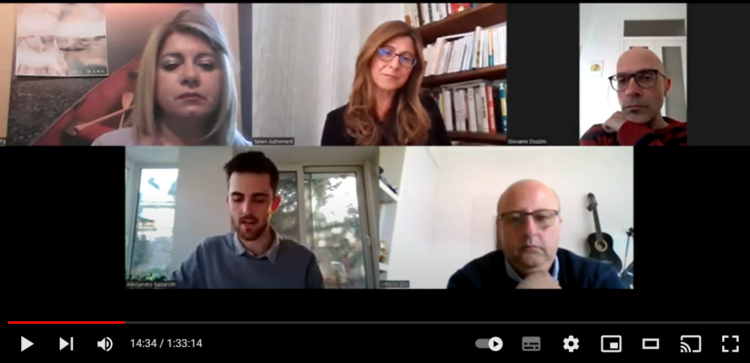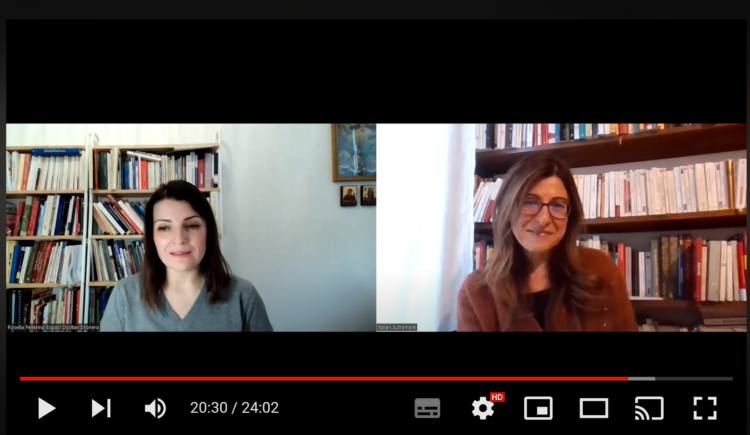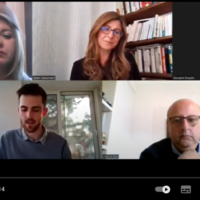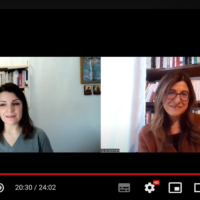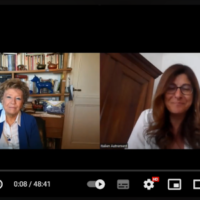Il toponimo è eloquente: Pilastri. Un luogo di passaggio, un confine, testimoniato dai nomi dei paesi vicini, Finale Emilia, due Gavello (molto probabilmente perché vi si chiedeva la gabella), una località chiamata Dogana. Ora il confine è semplicemente tra Emilia-Romagna e Lombardia, mentre in passato divideva gli Estensi dai Gonzaga e in seguito il Papa dal Regno Lombardo-Veneto. Se la giornata non è ventosa, quindi non si vedono l’Appennino a Sud e le Prealpi a Nord, si ha l’impressione di trovarsi in una pianura immensa, sensazione accentuata dalla scarsa urbanizzazione della zona. Ci si percepisce lontani dal resto del mondo, pura campagna al centro di se stessa concentrata sulle proprie attività, e un tempo doveva essere così; appena oltre il confine lombardo ci si imbatte nel villaggio dal trasparente nome di Porcara e nel giro di pochi chilometri si incontrano ben due frazioni chiamate Malcantone, oltre che Poggio Rusco (alluderebbe a una pianta, ma in alcuni dialetti della regione suona “Mucchio di Spazzatura”). Evidentemente gli abitanti di quelle campagne sono da sempre consapevoli di vivere in paesaggi, aromi e climi diversi da Portofino o Taormina; non tutta l’Italia è fatta di Bellagio o Bellosguardo.
Non si pensi, però, a un postaccio invivibile, lontano dai consorzi civili. Pilastri, nel suo piccolo, ospita diverse realtà industriali, tra cui un’azienda produttrice di macchine agricole, leader mondiale nel settore, che una ventina d’anni fa finanziò persino l’incisione di un cd di musica classica; a un quarto d’ora di strade di campagna si incontra il secondo distretto biomedicale del pianeta, quello di Mirandola. Salami e arpeggi romantici, porcelli ed export tecnologico; a Pilastri e dintorni, insomma, qualcuno abita sui confini per provare il piacere di varcarli e proiettarsi nel mondo. Questo oggi, ma la storia che vogliamo raccontare risale a oltre mezzo secolo fa, quando il benessere economico e le comunicazioni di massa avevano da poco lambito la zona.
Dopo essere usciti dalla guerra e dalla miseria, emigrando nelle città industriali o iniziando a progettare piccole fortune in loco, i pilastresi cominciavano timidamente a pensare di far studiare i figli, almeno quelli che apparivano più dotati e motivati. Tra questi giovani brillanti c’era anche il rampollo di uno dei personaggi più originali del paese, da tutti conosciuto come “Patàca” (nei dialetti dell’Emilia e della Romagna non è proprio un complimento, sta tra lo scemo e lo sbruffone). “Patàca”, che all’anagrafe faceva “Mattia” le sparava grosse e quasi mai per scherzo. Quando d’estate lavorava come facchino nel vicino zuccherificio di Bondeno, era convinto che i manometri misurassero la dolcezza dello zucchero e di ciò voleva convincere gli operai, che lo liquidavano con un “Va’ là, Patàca, lavora!”. Dichiarava di aver trovato la formula del moto perpetuo e l’aveva diligentemente aggiunta a penna sul volume dell’Enciclopedia Treccani conservato nella biblioteca comunale di Bondeno. Amava prodursi in sentenze filosofiche e poesie ermetiche – nella memoria del paese ne è rimasta una: “L’uomo / un verme / il verme / verme” – ma la sua più grande soddisfazione era quel figlio bravo negli studi. Correvano i primi anni Sessanta del secolo scorso e, oltre gli orizzonti nebbiosi, tutta l’Italia e il mondo apparivano come promesse a portata di mano; chissà cosa avrebbe realizzato quel figlio geniale se avesse potuto proseguire gli studi all’università di Ferrara (con il metro di allora, poco meno che se un pastore dell’Asia centrale avesse tentato il concorso per rettore ad Harvard).
Con la determinazione e lo spirito di sacrificio che i campagnoli di allora sapevano sfoderare, l’erede di Matia si iscrisse al biennio di Ingegneria, superato il quale avrebbe dovuto frequentare il triennio a Bologna o Padova (a Ferrara il ciclo venne completato molti anni più tardi). Questo significava inforcare la bicicletta in piena notte per arrivare a Bondeno (15 km), prendere il treno (altri 17 km) e, una volta sceso a Ferrara, a piedi o in autobus raggiungere la facoltà, che allora aveva sede dalla parte opposta della città rispetto alla stazione ferroviaria. Dopo qualche mese, tra un aforisma e diverse misurazioni della dolcezza dello zucchero, Mattia si lamentò con gli amici della vitaccia che doveva sopportare il figlio per frequentare l’università, tutto il tempo speso nel tragitto a scapito della concentrazione sui libri. In questo ragionamento era lucidissimo, ma presto il demone “Patàca” si impadronì di lui e gli fece sentenziare: “C’è un’unica soluzione: aprire un’università a Pilastri”. I testimoni, pur abituati ad anni di “patacate” senza freni, non riuscirono ad ostentare indifferenza, anzi tentarono di riportarlo alla ragione; questo atteggiamento però fu linfa vitale per il “Patàca”, il quale rilanciò dicendo che avrebbe pensato lui a realizzare il progetto. Lo spettacolo pirotecnico di pernacchie, ululati, cachinni e offese in dialetto che ne seguì fu il propellente definitivo per il giuramento del secolo: “Se andrò da qualcuno che conta, nessuno mi fermerà. Sono disposto a parlarne anche con Kennedy!”.
Occorre ricordare che il nome del presidente americano, il cui pur breve mandato lasciò il segno, riusciva a mettere d’accordo filoamericani e comunisti filosovietici, che allora abbondavano nella Bassa Padana: JFK era l’uomo del presente e dell’avvenire, il più roseo che si potesse immaginare, la palingenesi del mondo moderno seduta alla Casa Bianca. Se per gli ascoltatori dell’ultima follia del “Patàca” l’allusione al presidente americano rappresentava il sigillo di garanzia dell’instabilità neuronale del compaesano, Mattia restò dritto con maschio piè a vedere in lontananza la realizzazione del proprio progetto. Fatto sta che un giorno partì e, in barba alle difficoltà anche economiche che allora comportavano i viaggi, riuscì ad arrivare a Roma e ad imbarcarsi su un aereo per New York. Lui, che aveva varcato i pilastri dello scetticismo dei compaesani, si infranse però su quello del personale a bordo. Una volta imbarcato, infatti, passò dallo stadio “Patàca” a quello di “Superpatàca” e così si fece riconoscere: invitato dalle hostess a sedersi, declinò l’invito, sostenendo che avrebbe viaggiato in piedi per controllare dal finestrino che una scorta di caccia lo accompagnasse in missione, i cui scopi e dettagli prontamente espose all’incredulo personale. Venne subito sbarcato, con l’ipocrita gentilezza che si deve ai tipi originali di paese, e in qualche modo tornò a Pilastri, dove morì diversi anni dopo. Si guadagnò l’onore di un trafiletto sui giornali e il figlio si rassegnò a laurearsi brillantemente a Bologna.
Se questa storia fosse successa ai nostri giorni, con gli appelli social, i crowdfunding in rete e tutti gli svitati che sostengono le campagne più bizzarre e lanciano appelli per salvare il mondo dalle forze del Male in agguato, magari la missione del Mattia Varca-Pilastri avrebbe trovato un gruppo di followers e dei finanziatori; se ne trovano per scopi ben più strani. A noi piace immaginare, immerso nelle campagne tra Ferrara, Modena e Mantova, l’imponente edificio della “John Kennedy International University” a dominare le nebbie e a infrangere gli olezzi suinicoli. Chissà se in quel caso la postuma gratitudine civica avrebbe aggiunto a Roncole Verdi, Grizzana Morandi e San Mauro Pascoli il paese di “Pilastri Patàca”.
Michele Borsatti