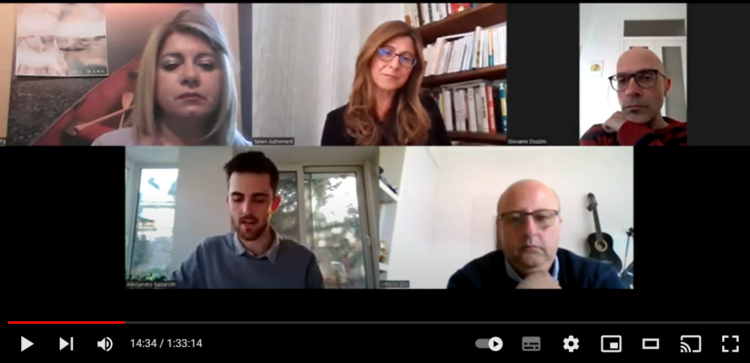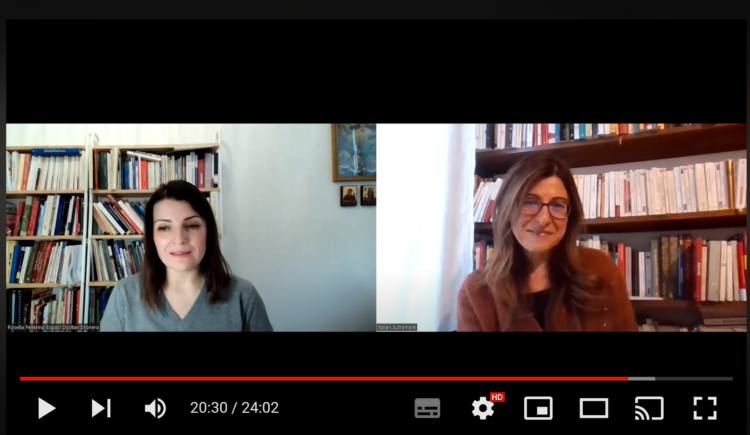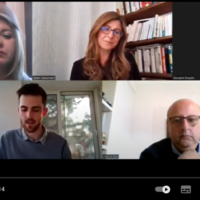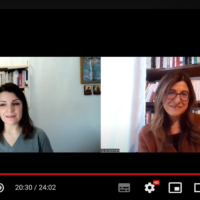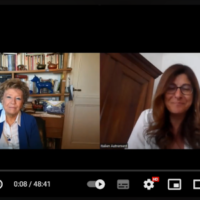A più o meno un terzo di Città sommersa di Marta Barone (che uscirà in francese nel 2022 per l’editore Grasset), la narratrice autobiografica ci offre la chiave, o una delle chiavi, per entrare nel mondo che affiora a tratti sulla superficie della pagina e che somiglia a una delle città invisibili di Italo Calvino: la favolosa Kitež, “a nord del Volga”, inabissatasi nel lago davanti agli occhi dei tartari conquistatori e che, secondo la leggenda, continua ad esistere “sott’acqua, segreta, con tutti i suoi abitanti” (p. 104). La città di Kitež è un’allegoria dell’essere umano, della memoria e dei luoghi ad essa inestricabilmente connessi che però all’improvviso possono svanire senza lasciare traccia. Ci offre un’immagine della casa perduta, delle stanze della memoria alle quali la narratrice vuole accedere. La chiave della porta d’ingresso però è un’altra. Il lettore avveduto l’afferra dalle mani di Valerie, scrittrice francese che il soggetto narrante, scrittrice a sua volta, incontra ad un festival letterario dopo la morte di suo padre, il leggendario L.B.: “In un certo senso tutta la nostra esistenza è una traduzione tra quello che cerchiamo di dire e quello che poi riusciamo a dire davvero” (p. 109).

Le due donne hanno parlato in francese dei rispettivi progetti creativi e Marta ha appena confessato all’amica il suo imbarazzo perché non trova la parola giusta, nella lingua straniera, per esprimere un concetto altrimenti a lei familiare. Ma è davvero solo una questione linguistica? Quanta parte del processo di traduzione è ostacolato dall’opacità dell’oggetto o dalle competenze culturali ed emotive del traduttore?
Di chi è la responsabilità se il profilo luccicante della cupola di Kitež, dalle profondità del lago, non mostra la via ai “viandanti fortunati”?
“Il y a deux semaines, mon père est mort” rivela la narratrice a Valerie che è riuscita a scrutarla dentro, a tradurre il suo stato d’animo, nonostante l’amica addolorata si sforzi di apparire indifferente. Torna alla mente l’incipit di L’Étranger (1942) di Albert Camus: “Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas”.
E se il protagonista de L’Étranger non fa che replicare, con la sua impassibile reazione al lutto, un’indifferenza che è nelle cose stesse, nel mondo che lo circonda, Marta Barone non si arrende davanti all’apparente vuoto che le si spalanca davanti, ma interroga gli oggetti, i luoghi, le strade, la fabbrica – con la stessa determinazione con cui fissa i verbali del processo per “partecipazione a banda armata” contro suo padre L.B. – per dare un senso all’assenza di un uomo di cui conosce una “versione più povera”, semplificata e scarna.
Ossessionata dal bisogno di ricostruire il percorso politico di un padre arrestato cinque anni prima della sua nascita, ma consapevole anche – proprio perché ha “studiato letteratura” – che ciò che troverà non saranno mai “i nudi fatti” bensì dei frammenti di verità per “riempire i buchi della memoria difensiva” e disegnare “una flebile traccia comune” (pp. 49-50), la figlia si aggira per la città reale, la Milano in cui si è appena trasferita e la Torino in cui è cresciuta. Lascia che i luoghi le parlino e ricompongano, traccia dopo traccia, l’identità del genitore, così come emerge anche da fotografie, racconti di amici e nemici, militanti di Prima Linea, Servire il Popolo, e altre organizzazioni di estrema sinistra in cui L.B. era stato coinvolto.
Marta Barone traduce, dunque, ma soprattutto interpreta e scrive “spezzoni confusi, scollegati tra di loro” di “una storia evanescente e imprecisa come una terra che vediamo da una nave nella notte, di cui possiamo intuire solo la sagoma scura prima che si allontani” (p. 83). E anche l’andamento della narrazione sfida ogni linearità cronologica, aggancia elementi di verità documentaria a momenti di ostentata finzionalità metanarrativa, quando ad esempio si appella esplicitamente ad un lettore raffinato, più smaliziato del narratore stesso, affinché utilizzi i trucchi del mestiere – “il fucile appeso alla parete nel primo atto del dramma” (p. 34) – che la protagonista flaneur trascura, sperando che sia l’altro umano e non-umano, coacervo natural-culturale, a venirle incontro e colmare il vuoto: “le visioni fugaci di androni dai portoni aperti”, i palazzi, gli alberi, “i nomi delle strade” (p. 35).
Quando finalmente la figlia di L.B. riesce a reperire qualcosa di concreto che dia sostanza alla sagoma sfuggente del continente paterno, si imbatte in un testo che, come tutte le altre tracce di Città sommersa, ha bisogno di traduzione perché è un documento storico scritto in un linguaggio fortemente ideologico, quello della sinistra extraparlamentare, ma per la narratrice (e per noi lettori) è profondamente vivo: l’unico corpo disponibile del padre scomparso. Si tratta di un volantino in cui L.B. sostiene il bisogno di mettere fine alla logica binaria del sistema capitalista, alla scissione schizofrenica di corpo e testa ereditata dai militanti comunisti della sinistra marxista-leninista: “Bisognava salvarli, quegli esseri umani, trasformarli in corpi-con-la-testa, diversificare la realtà, ascoltare le voci, “i suoni”, le “microrotture”, […] cercare invece chiavi diverse, progetti diversi, una trasmissione di linguaggi e di conoscenze molteplici era il futuro più stimolante e più vivo” (p. 231).
Dare voce all’altro, nella cura quotidiana e senza pose da intellettuale organico, invocare il diritto all’espressione del corpo per opporsi al controllo totalitario dei sostenitori, capitalisti e marxisti, del pensiero unico: questa pare essere la missione di L.B. che ricorda da vicino certe riflessioni pasoliniane della seconda metà degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta, fra denuncia dell’alienazione borghese delle ‘teste senza corpo’ nella produzione teatrale da Calderòn a Porcile, al trionfo dei ‘corpi senza testa’ nei film della Trilogia della vita.
Città sommersa è però anche il libro di una ragazza che cerca il padre, si rende conto, quando ormai è troppo tardi per fare ammenda, di non averlo conosciuto davvero e di provare perciò una “singolare nostalgia: più che del passato, di cose mai successe, di cose non ancora successe, di cose che forse avrebbero potuto succedere. Una nostalgia al futuro anteriore. Una nostalgia del non-più-possibile. Forse un giorno saremmo riusciti a parlarci. Forse, almeno una volta, avrei potuto fargli una carezza” (p. 289).
Da questo punto di vista, con la “nostalgia al futuro anteriore” possono identificarsi tante donne nate nel mondo occidentale prima degli anni Novanta del Novecento, quando l’idea di paternità si calibrava ancora su certe concezioni di genere, essenzialistiche e patriarcali, in base alle quali gli uomini partecipavano poco e niente alla gestione familiare, soprattutto delle figlie femmine. Ma nonostante l’assenza paterna, come recentemente messo a fuoco dalla studiosa Ursula Fanning, “la centralità e l’intensità del legame tra padre e figlia” svolgono un ruolo fondamentale nelle narrazioni autobiografiche italiane che descrivono la formazione dell’identità femminile, da Sibilla Aleramo a Grazia Deledda, da Anna Banti a Fabrizia Ramondino, da Natalia Ginzburg a Lalla Romano (U. Fanning, Italian Women’s Autobiographical Writings in the Twentieth Century, 2017, pp. 1-29).
Trovare il padre per trovare se stesse vuol dire dunque, da un lato, costeggiare una zona d’ombra, riempire un’assenza o anche, letteralmente, inseguire un fantasma, come accade alla narratrice di Addio Fantasmi (Einaudi, 2018) di Nadia Terranova; dall’altro, significa dare corpo al padre sostituendosi a lui, percorrendo fisicamente i luoghi che a lui sono appartenuti e ne conservano traccia: tropo importante, come si è detto, di Città sommersa (già declinato al maschile nel magistrale Via Gemito [2000] di Domenico Starnone), presente anche nel romanzo di Terranova, in cui la protagonista si aggira in lungo e in largo per una Messina impregnata di mito, o nel recente libro di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti (E/O, 2019), in cui la figlia esplora la metà “proibita” della città di Napoli, rinnegata dal padre bugiardo. Camminano i narratori e le narratrici che cercano il padre, compiono un’azione di pedinamento dei luoghi e degli affetti che rinvia, in parte, al flâneur simbolista e modernista, ma anche al nomadismo esistenziale e postumanista di scrittori come Gianni Celati o di scrittrici dimenticate come Marina Jarre del cui raffinato capolavoro autobiografico, I padri lontani (1987), ci ha parlato recentemente proprio Marta Barone, nell’introduzione alla nuova edizione Bompiani del volume (2021).
Romanzo d’esordio di grande maturità, vincitore del premio Vittorini 2020 nonché finalista al premio Elsa Morante 2020 e al Premio Strega 2021, Città sommersa ricostruisce con grande raffinatezza e squarci di violenza inaudita (penso al delitto dell’Angelo Azzurro e alle sevizie di Villa Azzurra, ad esempio) un periodo della nostra storia la cui voce è troppo spesso affidata alle logiche binarie delle narrazioni storiche ufficiali o delle cronache militanti e in cui alle vittime viene sottratto il corpo perché svolgano il ruolo di simbolo. A questo trattamento spersonalizzante e straniante che uccide la memoria personale in nome di un astratto processo di canonizzazione o demonizzazione collettiva si oppone la scrittrice. Ne parla a proposito di Roberto Crescenzio, vittima innocente del delitto dell’Angelo Azzurro, ma le sue parole potrebbero anche costituire una giusta epigrafe per la storia di suo padre Leonardo Barone: “Roberto Crescenzio divenne un simbolo: e penso a quanto sia atroce che a una persona, a qualsiasi essere umano, debba toccare la sorte di simbolo, e che Roberto Crescenzio aveva un corpo suo, e un cervello, e una vita oscura e normale, e invece è dovuto diventare la carcassa martoriata sul crocevia degli altri, un povero martire senza alcuna volontà di esserlo, il mostro delle foto, la colpa di una città. […] No, il rogo di Roberto Crescenzio non servì a niente, non fu simbolo di niente: io mi rifiuto” (pp. 238-239).
Enrica Maria Ferrara