“Ehi! Africa!” Cominciano sempre così le telefonate del padrone. “Africa, allungati di là… Africa, vai su fino a…”. L’apparecchio, solo ricevente, è appeso al soffitto della cabina dell’“Iveco Turbostar” vecchio di quindici anni e con tanti chilometri sulle ruote da fare il giro del mondo. Un “bilico”, come lo chiamano i colleghi italiani, anche se quel nome lo fa ridere ogni volta che lo sente. Kenenisa conosce almeno quindici definizioni di camion imparate nella babele degli autogrill o a mangiare in quei posti alla buona col menù a prezzo fisso, ma “bilico” gli pare la più ridicola. Anche adesso che il telefono squilla di nuovo e Catia, la segretaria del padrone, con quella voce di flauto che ogni volta glielo fa diventare duro, gli dice: “Ken, sei in bilico?”
Se non altro è l’unica che lo chiama per nome.
“Ken” esordisce Catia “Robuschi dice che siccome vai a Padova potresti allungarti a Bologna, all’Interporto, per caricare una decina di bancali di lamierino per una ditta di Ravenna”.
“Sono già in ritardo: ho trovato coda a Fidenza”.
“Robuschi dice così” insiste Catia col tono disarmato e vagamente minaccioso delle segretarie che eseguono ordini.
“Robuschi dice così”. E’ sempre questa la conclusione. Esigere spiegazioni o tentare di mediare sarebbe peggio. Catia, a quel punto, taglierebbe corto: “Bisogna che ti passi Robuschi”. E il padrone si metterebbe a sbraitare nell’apparecchio: “Africa, la smetti di fare il cacacazzi! Se ti dico che devi andare, devi andare, mi hai capito!” Fine delle trasmissioni.
Non ne aveva voglia di discutere. La ramanzina se la sarebbe presa il giorno dopo, quando il destinatario della consegna avrebbe protestato per il ritardo. Tanto, per il padrone, quelli che guidano sono solo degli scansafatiche. Io, perdipiù, sono anche nero, figuriamoci. Per fortuna pure lui ha le spalle al muro: o prende noi della legione straniera, o i suoi camion restano sul piazzale. Vai a trovare gli italiani che hanno ancora voglia di cuocersi il culo sul sedile per quindici ore. Alla faccia del tachigrafo!
Proprio per questo, quando Catia mi chiede se “sono in bilico”, vorrei dirle che ci sto da sempre. Prima la fame, poi la guerra, quindi la clandestinità e adesso questa vita di merda perennemente in giro come la palla del flipper. In bilico, appunto. Tra l’inferno e la sopravvivenza. Ma a ben vedere non so se ci sia poi tanta differenza. Se sia meglio perdere il lavoro ripiombando negli espedienti della clandestinità, oppure questa infinita marcia forzata in cui si confondono il giorno e la notte, il sonno e la veglia, la colazione e la cena e il mondo mi appare come un’incessante striscia d’asfalto dove tutti fuggono via. Se resisto è per Joanna e Michel: mia moglie e mio figlio. Vivono a Lodi in un mini appartamento in affitto. Ho le loro foto sul cruscotto, nel posto dove i colleghi tengono la Madonna, i Santi e le donne nude. Li guardo mentre guido e coltivo la speranza di mettere da parte un po’ di soldi e cambiare ‘sta menata di vita.
Però è dura. La paga non è granché. Tra l’affitto, il bimbo che va a scuola e tutto quanto, non riesco a mettere via che poche decine di euro al mese. Se ti capita una sfiga il salvadanaio si svuota e ricominci da zero. Inoltre, il padrone ci ha messo del suo. Quando mi ha assunto era per tutt’altro lavoro. L’annuncio sul “Corriere della sera” diceva: Cercasi autista per consegne in zona Milano-Lombardia. Pensavo: viaggio tutto il giorno e alla sera torno a casa. Solo dopo ho imparato che non bisogna mai prendere alla lettera gli annunci. Il primo viaggio l’ho fatto a Trento. Poi mi hanno spedito a Torino e da lì in Emilia. Ho pensato: hanno allungato un po’ il giro, ma posso pur sempre tornare a casa la sera. Invece, un giorno mi chiama Robuschi e mi dice che il mio collega bulgaro s’è licenziato e che loro hanno bisogno di sostituirlo. Insomma, ci voleva qualcuno che si prendesse la briga dei lunghi tragitti. Magari nel meridione o all’estero. “E la famiglia?” dico io.
“Torni a casa quando puoi” mi ha detto il padrone. “Questa è la vita che fanno tutti. E poi” ha aggiunto strizzandomi l’occhio “lungo la strada puoi sempre toglierti qualche capriccio, no?”
Non sono ipocrita, qualche volta ci ho pensato vedendo tutte quelle ragazze che se non stai attento ti vengono sotto le ruote con le tette fuori e tutto quanto. Ma a me basta Joanna, sempre che me la facciano vedere.
“Senti” mi dice Robuschi in ufficio “sai cosa facciamo per le trasferte?”
Lo guardo incuriosito e guardingo. “Un patto tra galantuomini, ti va? Anziché prenderti la briga di trovarti una pensione per dormire, posso concederti il camion. Facciamo un prezzo ragionevole e ci guadagniamo tutt’e due: tu risparmi sull’albergo e io sulla trasferta. Ci puoi anche portare tua moglie se vuoi”.
Ho fatto segno che non avevo capito. Allora Catia mi ha spiegato, mentre il padrone rispondeva a una telefonata. Lui mi affittava la cuccetta e l’uso della cabina come roulotte. Potevo dormirci, farci da mangiare e quant’altro avessi bisogno. In pratica, il camion sarebbe diventato la mia casa viaggiante.
“Per la paga” ha ripreso il padrone dopo aver riattaccato “ti metto quella base in busta e il resto te lo do in contanti così hai meno tasse e più soldi in tasca. Ho scoperto solo più tardi che non era vero, ma lì per lì ci sono cascato. Per noi che abbiamo conosciuto la povertà più nera, i soldi in mano danno un senso di conquista e di sicurezza a cui non sappiamo resistere. E’ così che ci fregano.
Insomma, ho cominciato a viaggiare lontano: Napoli, la Sicilia, Bari, Matera, Benevento… Le mie ruote hanno girato ovunque e io con loro. Dopo un po’ di mesi di questa vita ti sembra di non vivere più. Non sei più tu a guidare il camion, ma è lui che ti ha assorbito, ingurgitato come un organo meccanico tipo lo sterzo, il cambio o il filtro dell’olio. E di fianco a te quell’apparecchio appeso in cabina che ogni volta dispone del tuo tempo e della tua vita come un tiranno.
“Africa, fai un giro più largo… Africa, vai per Pescara che c’è un cliente…” Sempre lui, il padrone, a disporre seduto sulla sua poltrona di pelle e l’aria condizionata. La mia cabina mica ce l’ha. I colleghi sì, invece. Quelli tedeschi e francesi hanno camion nuovi che sibilano appena quando partono. Il mio fa un fumo e un baccano che la gente smette di parlare quando passo. Anche fra camionisti c’è chi è ricco e chi ha le pezze al culo. E i ricchi, mica si mischiano a quelli come me. Prima guardano il camion vecchio e ammaccato, poi osservano me che sono nero e il gioco è fatto. So anche che non si fidano di un autista nero. Dicono che noi africani non abbiamo il senso della guida perché siamo cresciuti in Paesi senza macchine e camion. Persino quelli dell’est che pur si ubriacano come le scimmie, la pensano così. E sono duri, sprezzanti. Una volta ho inavvertitamente tagliato la strada a un lettone mentre facevo manovra nell’area di servizio e lui mi ha gridato di andare a guidare i cammelli. Credono di essere capaci solo loro.
A parte questo, c’ho un altro cruccio: quello del tachigrafo. L’apparecchio è manomesso in modo che io possa staccarlo e fare le ore di guida che voglio. La legge dice che dopo un certo tempo devi fermarti a riposare, ma in Italia le leggi non le rispetta nessuno, figuriamoci il mio padrone. Dice che sono tutte menate e che quando faceva il camionista lui si guidava per giorni e notti senza riposare e con il volante che ti stracciava le braccia dalle spalle perché allora mica c’era il servosterzo.
Be’, dopo un paio di settimane sempre in giro con quella rumba, non ti sembra nemmeno più di essere al mondo. Adesso capisco perché tanti colleghi finiscono per ribaltarsi in un fosso, piombare giù da un viadotto o schiantarsi contro la spalletta di una galleria. Ti casca la faccia sul volante dopo giorni così. Hai voglia di caffè! Neanche se sniffassi! Se ti fermi e ti butti sul lettino in cabina, finisce che sei così agitato dai pensieri di consegnare e di correre, che ti svegli dopo poche decine di minuti in preda all’ansia. Così ricomincia l’agonia del sonno e ti prende a poco a poco quel senso di stordimento, quel dolore alle tempie e agli occhi che si stabilizza in un insidioso malessere da vomito. Alla fine non hai più voglia di niente e tutto ti infastidisce. Vorresti solo chiudere gli occhi e non vedere più la strada e tutto quanto.
Persino alla sera, al telefono con la tua donna, diventi insopportabile e cominci a questionare.
“Kenenisa, questa vita ti sta rovinando” dice Joanna.
Una volta, in un momento di debolezza, per poco non scoppio a piangere. Allora lei ha detto che sarebbe venuta a trovarmi col treno e con Michel ovunque fossi. L’ha promesso con tanto affetto che ho pianto davvero, silenziosamente, questa volta commosso. Così, la mattina che dovevo partire da Roma per Varese sarei passato da Lodi. Forse potevamo vederci e pranzare assieme allo Spizzico, sulla via Emilia a due passi da casa, che magari anche Michel si sarebbe trovato bene. Forse potevo anche fare un salto e stendermi sul letto per mezz’ora. Purtroppo, per via del solito traffico, sono arrivato alle due. Michel frignava da un pezzo, Joanna, di conseguenza, era nervosa. Io afflitto dalla solita fretta di consegnare la merce. Fatto sta che abbiamo litigato per tutto il tempo. Mi aspettavo grandi feste e ho trovato solo musi. Loro, forse, avrebbero voluto un marito e un padre diversi.
Anche quando mi sono concessi alcuni giorni di riposo, non riesco a essere rilassato. Il primo lo passo a letto dormendo. Gli altri li vivo in uno stato di sospensione e di spaesamento da fuso orario. L’ultimo, invece, è solo angoscia. L’angoscia di tornare sulla strada adesso che sta arrivando l’inverno e il camion ha le gomme quasi lisce. Robuschi le ha volute osservare personalmente e ha sentenziato che c’era battistrada ancora per un paio di mesi. Non gli basta aver fatto montare gomme ricoperte sul semirimorchio che già m’è capitato che si squamassero come un serpente in piena autostrada. Non è mica piacevole. Senti il camion che comincia a ondeggiare come se strisciasse là dietro. Poi a scodinzolare più decisamente e allora guardi negli specchietti e vedi i fuochi di artificio di gomma fusa. Il più delle volte, però, trovi un collega che si attacca al clacson e ti avverte. Sei fortunato se non ti capita in galleria o su un viadotto o che le altre gomme, per il peso in più, non schiattino anche loro come i palloncini del tirassegno.
Ma quel che mi fa più paura è la neve e il ghiaccio.
Robuschi sta sempre all’erta quando sente che arriva il cattivo tempo e s’attacca al telefono.
“Ehi, Africa, sei capace di mettere le catene? Ehi, Africa, sbrigati a passare l’Appennino che stanotte mettono brutto. Ehi, Africa…” Tutto così. Chilometri e chilometri con negli orecchi il vecchio Robuschi che gracchia la sua scienza di guidatore. Che poi, alla fine, è solo la fifa di perdere il carico. “Africa, lo sai che c’hai su cento quintali di formaggi? Sai quanti soldi ti porti?” Mica ha paura che mi faccia male… Gli dispiacerebbe più per il camion. E’ vecchio, è vero, ma fa sempre la sua parte. E adesso s’è messo in testa che vuole vendermelo.
“Cosa ne dici, Africa, di diventare un padrone?” mi ha chiesto. “Il camion diventa tuo e tu lavori per me. Ti pago a viaggio, apri la tua bella partita Iva…”
Gli ho detto che nemmeno sapevo cosa fosse e che preferivo restare così. E poi, quel camion, ormai era alla frutta.
“Cosa credevi?” ha replicato “di potertene comprare uno nuovo di fabbrica?” Visto che nicchiavo, ha cominciato a metterla sul duro: “C’è la crisi e io non posso più permettermi di avere costi fissi. E tutti ‘sti contributi! Imparate a fare da soli!”
Per farla breve mi ha praticamente costretto. Il camion glielo pago poco per volta come un mutuo che mi trattiene dallo stipendio e così addio risparmi. Il padrone dice che poi “avrò del capitale”. In pratica mi rimarrà questo catorcio quando esalerà l’ultimo respiro. Tutti mi dicono che sono stato un fesso e che mi sono tirato in casa solo spese, ma vorrei vedere loro al mio posto. La conclusione è che adesso mi ritrovo padroncino e sono “sul mercato” come tanti altri disgraziati. E con quelli come Robuschi che mettono all’asta i viaggi a chi fa il prezzo più stracciato. Certuni, pur di prendere una commessa, si accontentano di così poco che farebbero meglio a chiedere l’elemosina all’angolo della strada come fanno tanti neri come me coi fazzoletti di carta, gli accendini o le calze di cotone.
Se poi ti capita qualche guaio è un rimessa secca. Viaggia e viaggia, qualcosa si rompe. E adesso mi tocca pensare anche a quello. Se ne parla all’osteria quando si fa una sosta e si capita a tavola insieme. Per fortuna c’è ancora qualcuno con cui puoi parlare senza che ti vedano come un rivale. Perlopiù si tratta di vecchi camionisti poco più giovani di Robuschi che non hanno fatto fortuna mettendo su una ditta. Io mi chiedo se è perché sono stati più onesti o perché più coglioni. Però con loro si parla e hanno meno pregiudizi dei giovani che sono tutti schizzati o maniaci e riempiono la cabina di luci e lucine come un albero di Natale. Be’, tutti questi anziani mi hanno insegnato parecchio. Tipo che nel costo del viaggio ci devi mettere anche una quota di usura del camion perché mica va in eterno. A un certo punto devi rifare la frizione, ripassare il cambio, cambiare i semiassi, controllare i giochi dello sterzo, revisionare pompa e iniettori. Senza contare che arriva un giorno in cui il motore si sfiata del tutto e devi fermarti in officina per due settimane. E’ allora che i soldi devi averli già messi da parte prima sennò sei nella merda.
Sono cose che si imparano nel tempo: mica le sapevo io. Al mio paese si usa l’asino fin che sta in piedi e poi se ne trova un altro. Non vai certo a pensare a queste cose. Ma poi, stringi stringi, anche gli italiani mica stanno lì a calcolare. In questo paese tutto si regge sul sacrificio del singoli e sul fregarsene delle leggi. Così, questi vecchi camionisti, si mettono al volante e vanno fino allo sfinimento. Una sigaretta che pende dall’angolo della bocca, un carico di caffè da elettrizzare un cammello, e via manomettendo il tachigrafo fino a che non si schiatta di colpo come un lampeggio di fari e tutto precipita. Va bene quando si va a finire in un prato al lato della carreggiata. Però, spesso il camion vira dall’altra parte e allora succede una frittata. E’ il caso a decidere.
Proprio ieri ho visto uno di questi miei colleghi al quale si è spenta la luce di colpo. Era avanti di neanche mezzo chilometro carico di putrelle d’acciaio e già scodava col semirimorchio danzando tra la prima e la seconda corsia. Ma spesso succede se c’hai del sonno da recuperare. Era verso le 5 o le 6 del mattino, quando tutta la stanchezza della notte ti sbatte in faccia il suo cloroformio e il volante ti pare tutt’a un tratto un appiglio cui ti aggrappi per non cadere con la faccia sul cruscotto. Il guaio è che quasi sempre a quell’ora non sei mai distante dalla meta e tiri ad arrivarci. E’ così che ti freghi con le tue mani. Be’, insomma, ‘sto mio collega, dicevo, ha cominciato a scodare e, tempo nemmeno mezzo minuto, l’ho visto partire verso sinistra come una palla da bigliardo che avesse inzuccato una sponda. Il camion è rimbalzato verso lo spartitraffico di cemento e c’è come salito sopra. Ho immaginato il risveglio dell’autista nella consapevolezza della morte e nell’impotenza di evitarla. Il new jersey ha resistito per un po’, quindi si è piegato e ha ceduto sotto il peso dei trecentocinquanta quintali del bilico. Le stecche di cemento armato sono schizzate via e il camion ha fatto irruzione nella carreggiata opposta con l’impeto selvaggio delle truppe di conquista.
Ho visto le prime due macchine schiantarsi contro la fiancata della motrice facendo esplodere le gomme gemellate. Poi gli è arrivato contro un camion carico di sabbia. Le putrelle sono schizzate avanti come lance e, dopo aver attraversato la cabina, sono andate a conficcarsi contro l’altro bilico, mentre la sabbia è saltata per aria come dentro un setaccio e ha formato per alcuni istanti una nube grigio nebbia nel cielo, precipitando poi a sommergere lo scempio di lamiere e corpi dilaniati. E’ seguito un silenzio insopportabile e quando ogni energia sembrava sopita, è improvvisamente partito l’incendio con un rombo agghiacciante. Una delle macchine ha iniziato a bruciare, il serbatoio è esploso e tutto si è trasformato in un orrendo rogo. Per molti minuti si sono sentiti solo gli schianti delle gomme che scoppiavano, del metallo dilatato e poi piegato dal fuoco e infine una puzza acre di pneumatico, benzina, gasolio e di carne alla griglia. Conosco quell’odore. L’ho sentito più volte nei villaggi quando i guerriglieri o le truppe regolari incendiavano le abitazioni senza badare troppo a chi c’era dentro. Quell’odore è inconfondibile. Così come le grida di chi, intrappolato, sfrigolava alle fiamme.
Quando ci ritroviamo nelle aree di servizio, negli autogrill o nei piazzali delle fabbriche e parliamo del nostro lavoro, scopriamo che quasi tutti hanno un morto o più sulla coscienza. Non è detto che sia colpa loro. Ma che differenza fa se è colpa tua o no quando vedi un corpo schiacciato dalle tue ruote? E’ questione di sensibilità, si capisce. Tuttavia penso che anche il più grossolano dei camionisti non possa rimanere indifferente di fronte a chi resta sull’asfalto tagliato a metà o del tutto spappolato. Finire sotto le ruote vuol dire essere quasi tranciati, gonfiarsi come una rana e schizzare il sangue dal naso, dalla bocca e dalle orecchie, mentre gli occhi ti escono dalle orbite. Sull’asfalto resta una macchia grande come un letto matrimoniale e a me vengono in mente gli insetti schiacciati sul pavimento. Venire trascinati è ancora peggio. Significa essere grattugiati sull’asfalto con i muscoli, le ossa e tutto che finiscono spalmati sulla strada lasciando una striscia di centinaia di metri. Di molti non resta che mezzo corpo per il traverso o per il lungo, a seconda di come vengono presi e allora o si ritrovano senza gambe o si riducono come le mezzene nei macelli.
A nessuno di noi sfugge che prima o poi potremmo capitarci dentro il macello e che la nostra vita è un continuo rodeo in un coro di clacson e motori. Senza contare che sulla strada sei sempre solo, certe volte seduto su una fortuna. Se porti merce preziosa e fragile ti sembra di essere tu stesso più fragile. Anche se non te ne accorgi, vai più piano, diventi più prudente. E soprattutto cerchi di non fermarti mai. Un camion fermo con l’autista che dorme in cabina è un bersaglio facile. Rompono il vetro, aprono la portiera e tu non fai in tempo a svegliarti che ti ritrovi una pistola puntata. A quel punto devi solo sperare che non infieriscano. Inoltre sono nero e per certuni è come un invito. In certe zone è bene tirare sempre dritto. Viaggiare, insomma. Anche perché io mica ho un’assicurazione sui furti della merce, né dispongo dell’antirapina satellitare che dalla centrale potrebbero addirittura spegnerti il motore mentre vai. Queste sono tutte cose che costano e molti di noi non se lo possono permettere. Già faccio fatica a pagare tutte le spese e l’affitto di una casa dove non abito mai. Giorni fa sono passato da Lodi e ho preso a bordo Joanna e Michel. Al piccolo abbiamo fatto saltare la scuola materna per alcuni giorni. Deve fare qualche sacrificio anche lui per consentire a mamma e papà di vedersi. A prima vista il camion gli è piaciuto. Mi ha guardato guidare e si è appassionato alle leve, alle spie e a tutto quel via vai in autostrada. Io gli indicavo le auto sportive: Ferrari, Porsche, Maserati, Bmw e lui le guardava con quei suoi occhi grandi e stupiti che ogni volta mi fanno sciogliere. Ma i viaggi sono lunghi e dopo nemmeno centocinquanta chilometri, Michel ha cominciato a frignare e a chiedere di scendere. Anche Joanna doveva andare in bagno così mi sono fermato più volte e ho accumulato ritardo.
“Ehi! Africa, non dovevi già essere ad Ancona?” ha cominciato a urlare Robuschi. “Dove sei? Stai arrivando?” Anche se avevo appena passato Rimini sud, gli ho detto che ero già oltre Pesaro per metterlo tranquillo. In quel momento Michel s’è di nuovo messo a frignare e il vecchio l’ha sentito.
“Cosa fai? Ti porti dietro la famiglia? Africa, non siamo mica dalle tue parti. E poi ci pensi a quello che può succedere?” L’ha buttata sul patetico: il padre disgraziato che espone la famiglia al rischio. Non ho mai avuto tanta voglia di mandarlo a cagare come in quel momento. Che ipocrita! Chiaro come il sole che gli importava solo che il carico arrivasse nei tempi giusti. Per il resto potevamo schiattare tutti che non gliene sarebbe fregato un cazzo. Il fatto è che il camion non è più suo e non può rimproverarmi di farci salire chi voglio io. Così la prende alla larga. Io sarei un pazzo a far viaggiare accanto a me la famiglia con tutti i pericoli. Non devo avere nessuna distrazione, io. Devo solo guidare, a quello servo. Guidare fino allo sfinimento, dormire poco e mangiare saltuariamente. Be’, io vorrei vedere chi può pensare di passare una vita in questo modo. Dov’è scritto che io debba consumarmi per il bene della circolazione delle merci. Per portare alle fighette ingioiellate di Milano e Roma le borsette Luis Vuitton, le mutande di Coveri o l’ultima generazione del portatile della Apple? ‘Fanculo tutti signori!
A parte questo, la famiglia sul camion non ci sta per altre ragioni. Vivere giornate intere in una cabina col rumore che fa il motore e lo stress delle code, alla fine rende così nervosi che si finisce ai ferri corti. Con Joanna, dopo una giornata sulla strada, è una continua lite seguita da una pace repentina, ma di breve durata.
“Che cosa ci vengo a fare se tu puoi solo guidare?” mi dice lei.
Non ha tutti i torti. Almeno vedessimo qualche bella città, un monumento… Invece solo autostrade, interporti, aree industriali e autogrill. “Non è vita, questa” conclude Joanna.
E’ vero, ma mi fa incazzare. Me ne indichi un’altra, allora. Per fortuna, lei adesso ha trovato un lavoro a mezza giornata, solo il mattino quando il bimbo è alla materna: assiste un vecchio in casa. La pagano in nero, ma a noi va bene e un po’ di grano lo mettiamo da parte. Tutto sommato, in due ci si fa coraggio con la speranza che questa situazione cambi. Ma ho idea che quelli come me e Joanna non riusciranno a cavarsene fuori. Gli italiani ci vogliono per questi lavori e non per altro. Forse Michel, se riuscirò a dargli un’istruzione, potrà ambire a qualcosa in più. Anche per questo mi spacco la schiena e consumo la mia giovinezza in questo viaggio senza fine.
Se non altro, noi stranieri siamo rimasti gli unici a coltivare dei progetti per il futuro e a pensare al cammino delle generazioni. Gli italiani hanno smesso da tempo. Almeno i camionisti. Quelli vecchi ragionano della vita come di qualcosa che riguarda solo loro stessi e non pensano a lasciare niente a nessuno essendo perlopiù scapoli e soli. Quelli giovani guardano al lavoro solo come a un mezzo per togliersi sfizi e piccole soddisfazioni. Li sento ragionare di macchine, di computer, di telefonini, di satellitari, ma mai del loro futuro. Pensano solo a breve termine e viaggiano a vista.
Io, invece, quando penso a Michel e anche agli altri che ancora non ci sono ma forse verranno, mi consolo. Trovo una giustificazione alla mia fatica e mi sembra meno pesante quel che faccio. E’ ciò che mi fa resistere e mi riappacifica come l’oppio che si dà ai malati o ai soldati feriti. E con l’inverno che ormai è arrivato, con le tante ore di buio che ci riserva, resistere per chi guida significa non cedere al sonno. Restare svegli di notte con l’autostrada di fronte immobile e rettilinea come un fermo immagine, nel sussurro uguale del motore e la ninna nanna della cabina che ti culla con sobbalzi lievi, è un’impresa che richiede un grande sforzo mentale. E se si è giovani è ancora peggio perché non ci sono gli anni, un mal di schiena o qualche acciacco a tenerti sveglio. Un corpo giovane fa tutto con immediatezza e semplicità: mangiare, correre, amare e, appunto, dormire.
Certe volte arrivo a darmi degli schiaffi o a fermarmi mettendomi a saltare nascosto dietro i camion affinché non mi prendano per matto. E lì, mentre salto e sento ancora il mio corpo elastico malgrado le ore di guida, mi ritrovo ragazzo felice in Etiopia e mi viene da piangere. Penso spesso all’Etiopia. A mia madre e mio padre, al villaggio, al caos puzzolente di Addis Abeba dove arrivai un giorno per disputare una gara d’atletica dopo aver passato due giorni e due notti su un pulmino scassato che saltava sulle buche come un’antilope. Non mi presero tra gli atleti junior della nazionale. Persi lo sprint e arrivai solo quarto. Sul rettilineo mi passarono in tre. Il mio allenatore mi disse che se avessi svolto lavori di velocità come quelli che mi avevano battuto, avrei dato mezza pista a tutti perché ero di gran lunga il più forte. Ma la vita è fatta di casualità ed eccomi qui su questo camion a sonnecchiare per chilometri cercando di tener dritte le ruote.
Un po’ mi aiuta la radio, la musica che metto o le telefonate con Joanna, dopocena, quando Michel è a letto. Ci diamo appuntamento dalle dieci di sera in poi, quando ci capita, anche in piena notte. A volte stiamo più di un’ora, tanto il nostro contratto ci fa chiamare gratis. Lo squillo è provvidenziale: la scossa che ci vuole.
“Ti ha dato il riposo di tre giorni?” domanda Joanna.
“Sì, per fortuna” rispondo io.
“Dove sei?”
“Appena uscito da Livorno. Vengo su con la Spezia-Parma e poi staremo un po’ assieme”.
“Ho una bella novità” continua Joanna.
“Quale?”
“I figli del vecchio da cui vado al mattino, ci danno l’appartamento di fianco in uso gratuito se do un’occhiata al padre anche al pomeriggio. Loro sono sempre fuori”.
“Non pagheremo più l’affitto” ragiono, mentre ritorno perfettamente in palla.
“E potremo tirare il fiato, mettere da parte dei soldi…”
Sento il mio corpo che si rilassa sul sedile e una piacevole sensazione di sicurezza, m’invade. Afferro a due mani il volante e ascolto Joanna che mi parla a ruota libera. Il suono della sua voce mi sembra un quartetto da camera. Così, ascoltando arrivo fin quasi a Pontremoli. Il camion arranca per scavalcare l’Appennino e io mi sento bene. Quando arrivo in cima al valico, Joanna mi saluta e dice che mi attende a letto con una voce che è più di una promessa. Eccitato, passo i due chilometri della galleria del passo e mi butto giù verso la pianura padana in fondo alla quale mi aspetta mia moglie. Mi immagino casa mia, Michel che dorme, lei che mi abbraccia. E poi la nostra vita che s’acquieta, la sicurezza di una casa, la certezza di un po’ di risparmi… Ecco che scendo. L’autostrada ha curve che sembrano tornanti e più di un’auto mi lampeggia o suona. Che stia sbandando? Non ho mai avuto una sensazione così pacificante tanto che l’adrenalina mi crolla di colpo e un sorriso soddisfatto mi si stampa sulle labbra. Mi appoggio allo schienale, sento che le mani allentano la presa e forse cadono sulle ginocchia. Gli occhi si chiudono di colpo come raccontano gli scampati. E’ un attimo e l’incoscienza diventa padrona. Negli ultimi istanti di passaggio si sente ancora qualcosa. A Kenenisa è sembrato di percepire un urto leggero e poi quella sensazione di vuoto nello stomaco da decollo o da caduta. Poi non c’è più stato il tempo per svegliarsi.
Valerio Varesi


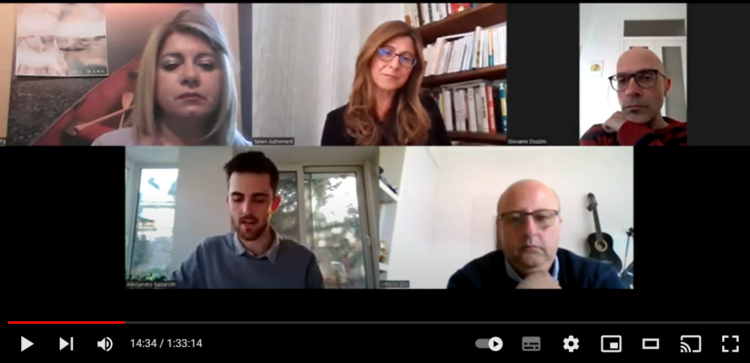

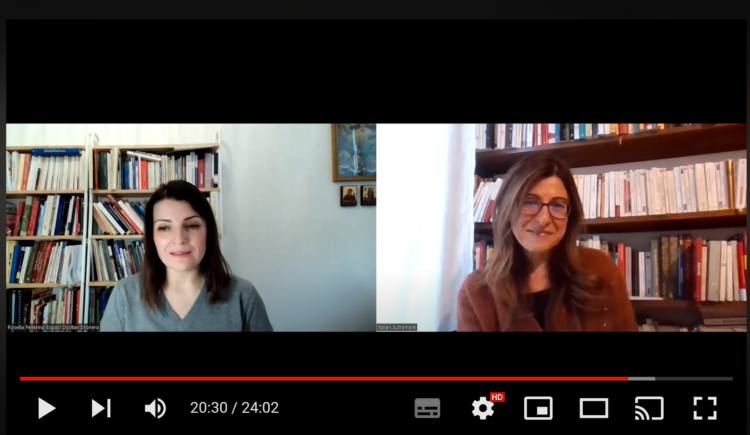
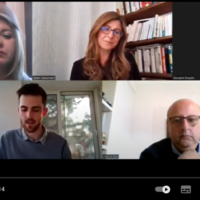

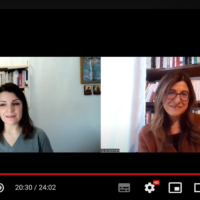

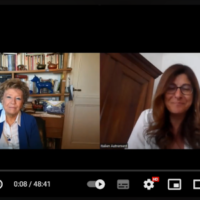








Comments
Abigail Mackintosh
I like how well-written and informative your content is. You have actually given us, your readers, brilliant information and not just filled up your blog […] Read MoreI like how well-written and informative your content is. You have actually given us, your readers, brilliant information and not just filled up your blog with flowery texts like many blogs today do. If you visit my website QH7 about Search Engine Optimization, I'm sure you can also find something for yourself. Read Less
Fabiola Viani
Una lettura che non lascia indifferenti. Un racconto di profonda umanità!