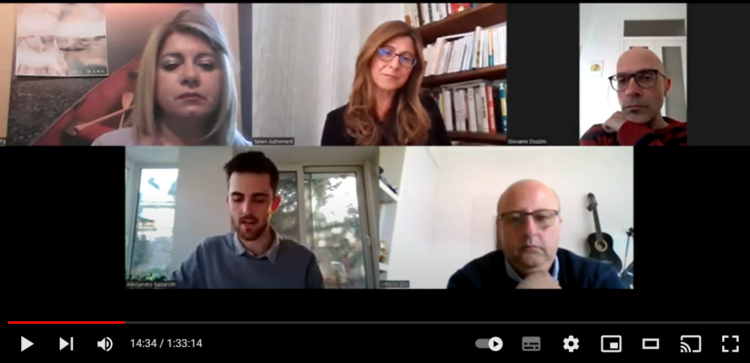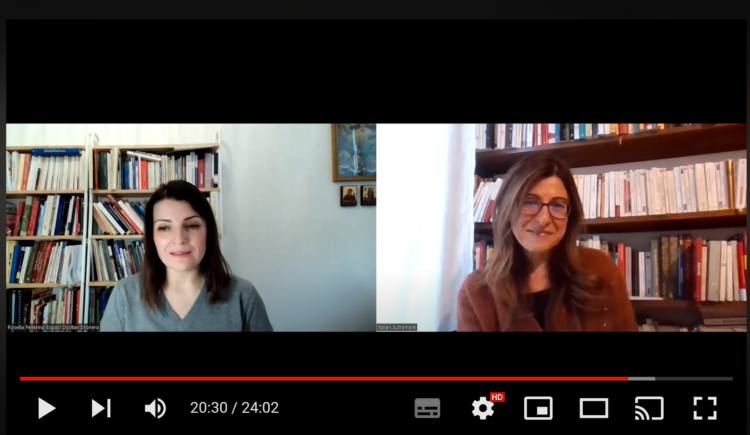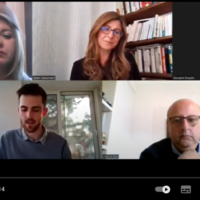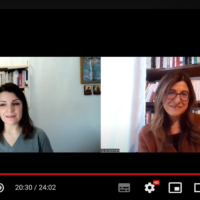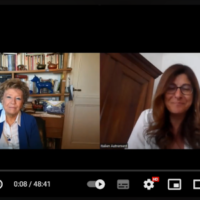Da quando ero piccola ho sempre saltellato tra italiano e croato, e ora più che mai sento il primo come un corpo estraneo e ostinato che mi vuole avvolgere, contro la mia volontà. Ma so che sarò sempre in mezzo, anche se mia madre dice che il confine tra le lingue lo decido io.
Lei si aggrappa alle parole, le mastica e le mangia appropriandosene. Lo fa in tante lingue, ogni tanto la sento mescolare il suo dialetto alle imprecazioni degli zingari irlandesi che ha conosciuto in un’altra vita. Eppure, quando parla con me si ostina a parlarmi esclusivamente in italiano, che per me è un po’ una lingua straniera, precipitata, indisponente. Io la correggo quando si esprime con quel suo accento finto-fiumano strascicato, mentre mio padre non manca di prenderla in giro: šta da? Iz Pule?[1].
Tutti gli italiani che si azzardano a pronunciare lo slavo sono automaticamente catalogabili come “istriani”, o solo dei malcapitati fuori confine massimo. A me sono bastati un paio d’anni di scuola osnovna, elementare, per comprendere il gioco sottile dei casi grammaticali: ablativo, accusativo, strumentale. Mia madre invece, da quando vive qui, si è fissata con il nominativo, così che i suoi discorsi si assorbono tutti di un protagonismo maldestro e imbarazzante: tutto è in posizione primaria, tutto agisce, nulla è agìto. Si dimentica di mettere le desinenze, oppure le sbaglia apposta per scandalizzare mio padre. Invidio il suo rapporto plastico con le lingue.
Da quando sono diventata adolescente, le conversazioni casalinghe sono buffe acrobazie, ma alla fine cedo al suo discorso da penisola, perché cerco qualcosa in quella lingua morbida e ambigua, come dentro un deep web fuori tempo massimo. Solo quando cantiamo, io e lei ci sappiamo allineare in qualsiasi idioma.

Una strada di Šibenik (Sebenico), 2015 – © Silvestar Vrljić
In ogni casa che si rispetti ci sono i muri che respirano e quelli sordi.
Ad esempio, i quadri di mio nonno stanno appesi sui muri sordi, o tupi[2], come li definisce mio padre, calcando sulla u come tutti gli abitanti della nostra capitale. Poggiano su pareti sorde perché, come dice lui, non valgono nulla e pesano poco. I muri con autentici polmoni stratificati sono invece quelli dove arrivano gli odori della cucina, capaci di trasudare goccioline di ogni tipo. Li sento sfrigolare di piacere ogni volta che mia madre prepara il suo dolce di carote o la caponata, che lei si ostina a fare anche se a mio padre non piace.
Sono del tutto certa che il muro della mia stanza stesse respirando quella notte di dieci anni fa, quando è arrivata la prima scossa. I corpi dei miei genitori sono precipitati dal letto, in mezzo ai vetri rotti, le loro dita affannate a raccogliere inutili cubetti di bicarbonato sparso sul parquet, lucidato dal padrone di casa pochi giorni prima. Ci eravamo, infatti, appena trasferiti. Ora il corridoio, con il suo intonaco sbriciolato, aveva perso il colore e sembrava un tunnel. Sembrava di essere nel rifugio antiguerra della Città Alta, ma senza i faretti natalizi che lo decorano a ogni Avvento, quando ci andiamo a passeggiare mangiando fritule[3].
Mia madre mi ha stretto forte le mani, facendomi male, e ha detto solo: ‘Qui!’ Aveva gli occhi svuotati, una specie di Madonna da videogioco. Stavo facendo un sogno, e loro ci sono piombati dentro per prendermi in braccio, ancora mezza addormentata. Mi sono sentita piccola e leggera, le ossa delle gambe strette, a farfalla. Non c’erano suoni distinti, solo odori confusi, e io sapevo che stava succedendo qualcosa di importante e di terribile.
Il mio muro sembrava esploso dalle proprie interiora, come un polmone esausto, i muscoli delle travature sconnessi, i mattoni esposti, una specie di denudamento imprevisto. Chissà se si era vergognato, di spogliarsi così davanti a noi, avevo pensato per un secondo. Ora che il suo respiro era stato interrotto, dai tubi usciva un rivolo marrone, limaccioso. Proprio belle tubature, si è lasciato scappare mio padre con una bestemmia.
Più tardi ho sentito parole miste: torba, mobitel, baterija, virus, vatrogasci.[4] L’aria si era rarefatta attorno agli occhi e al volto di mia madre. Ho iniziato a ridere convulsamente, con i capelli appiccicati alla fronte. Tutta la scena mi sembrava una specie di festa improvvisa. Allora ho pensato al mio sogno interrotto, dove eravamo al mare e i nostri corpi si erano trasformati in kitovi, le balene grandi e bianche a macchie, simili ai cetacei di un film di animazione che adoravo quando ero piccola; erano intere famiglie di cetacei che danzavano tra acqua e cielo, con una musica classica molto nobile, da festa di altri tempi.
Adesso la mia danza notturna di balene mi era rimasta in fronte, pulsava, interrotta. Davanti al muro, gli occhi di mia madre ora roteavano su di me, sul mio naso insanguinato, e aveva iniziato a pulirmi furiosamente, mentre mio padre le urlava di uscire fuori, subito.
Fuori, l’intero vicinato presidiava le fondamenta, ciascuno con la sua mascherina da isolamento. Si aspettava il predstavnik stanara[5], il presidente degli inquilini, una figura importantissima per ogni caseggiato del nostro quartiere borghese. Il nostro, non lo avevamo ancora visto. Le signore di mezza età, in camicia da notte, erano già con la loro brava sigaretta tra le labbra, occupatissime a digitare messaggi sui telefoni. Poi, a tradimento, aveva iniziato a nevicare, come non succedeva da anni. La signora Jadranka, del nostro pianerottolo, zoppicava appoggiandosi al bastone, mi diceva ma slatka moja, ne brini, to nije nista[6]…Aveva un tono gentile, nonostante l’aspetto da enorme serpente languido, con la sua giacca crema fuori stagione, messa un po’ a caso. A un certo punto aveva rinunciato a confortarmi, e si era messa a fumare a catena delle sigarette senza filtro.
Dalla notte del terremoto, siamo diventati alieni in casa. Le dita di mio padre si sono fatte piccole e nodose, quelle di mia madre hanno una ragnatela di rughe che dialoga con una tastiera nera e malmessa, dalle lettere oramai sbiadite.
Quella notte ha cambiato tutto, per lei. Le parole che un tempo preparava per gli altri, da allora non servono più, all’improvviso è diventato tutto un ‘Fammi concentrare, devo guardare qui, controllare lì, lasciami in silenzio’; lo smartphone è diventato un terzo arto, che rende monche le sue mani umane. Mio padre invece fissa il frigorifero con espressioni lunari, emettendo ogni tanto il suono di un animale ferito. Riempie la dzezva[7] con gli occhi chiusi, picchiettando attorno ai grani di caffè caduti, per metterli in fila indiana.

Una strada di Šibenik (Sebenico), 2015 – © Silvestar Vrljić
La nonna siciliana era un mantice di energia. Una volta, via webcam, sulla sua terrazza sullo Stretto mi aveva mostrato delle statue di pietra, alternate alla miriade di piante che si era procurata con l’acquisto della grande casa dove stavamo tutti d’estate. Da quando era scoppiata la pandemia, avevamo detto addio ai viaggi, e così la mia spezzettata esistenza di isolana acquisita si era ridotta a qualche videochiamata settimanale. Una delle statue era una figura di donna marina, dal volto oblungo, gli occhi diagonali, come le fate che disegnavo da piccola. Sembrava una fata anche lei, però la nonna mi aveva subito corretto: era una figura ben più importante delle mie eroine d’infanzia, perché era una potente maga mitologica, capace di apparire e scomparire sul pelo dell’acqua di Messina, per ingannare lo sguardo.
Dopo quel 20 marzo di tremori, avevo smesso di sognare gli animali, la loro voce calda era entrata in uno sciopero muto. Mi si era allungato il viso, anche, e ogni notte, inspiegabilmente, mi si formavano crosticine di sangue rappreso attorno alle narici, dove avevo ricevuto addosso le tracce polmonari del muro davanti al letto. Avevo un bel dire che non mi scavavo il naso come quando ero ancora all’asilo: mia madre sbuffava disgustata, e ogni mattina mi passava un fazzoletto umido, facendo gli occhiacci.
La scorsa notte, però, ho sognato di nuovo. Un senso di nuoto, come nella vasca grande della casa vecchia. E poi è comparsa la nonna, da sola e bella eretta, che passeggiava su una spiaggia della sua città di mare. Era avvolta in una coperta e teneva un libro in mano. Con la sua voce da insegnante canterina, mi continuava a ripetere in dialetto ‘Nnicchi ‘nnicchi chi ruba s’impicchi, come quando ero piccola e giocavamo con le dita. Mi ha tranquillizzato, quel sogno un po’ marino, e l’ho raccontato alla mamma, che da dieci anni cerca ancora di avere due braccia, invece di tre. Lei ha ammorbidito la bocca, un po’ triste, e mi ha sorriso appena in videochiamata, prima di mandarmi un bacio frettoloso e rilanciare un Refresh sullo schermo vuoto del suo ex lavoro.
Serena Todesco
Foto copertina: Isola di Mali Lošinj (Lussinpiccolo), 2017 – © Silvestar Vrljić
[1] ‘Cosa? Di Pola?’ (frase con cui i croati dell’entroterra, soprattutto Zagabria, imitano ironicamente il modo di parlare della gente dell’Istria).
[2] Sordo, ma anche nel senso di tonto, instupidito.
[3] Dolce tipico di strada, simile alle zeppole napoletane.
[4] ‘Borsa, cellulare, batteria, virus, pompieri’.
[5] ‘Capo condomino’.
[6] ‘Ma tesoro mio, non preoccuparti, non è niente’.
[7] Pentolino di metallo utilizzato per preparare il caffè alla turca.