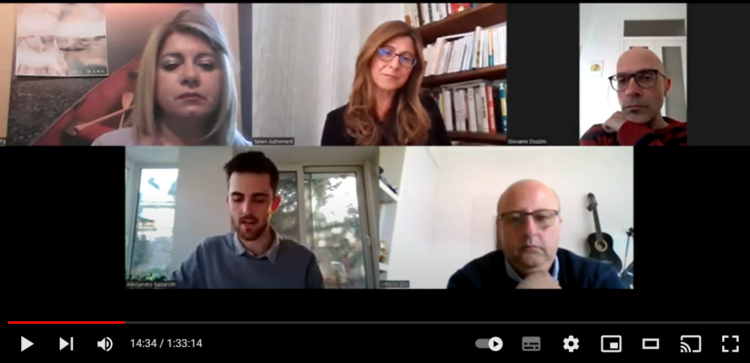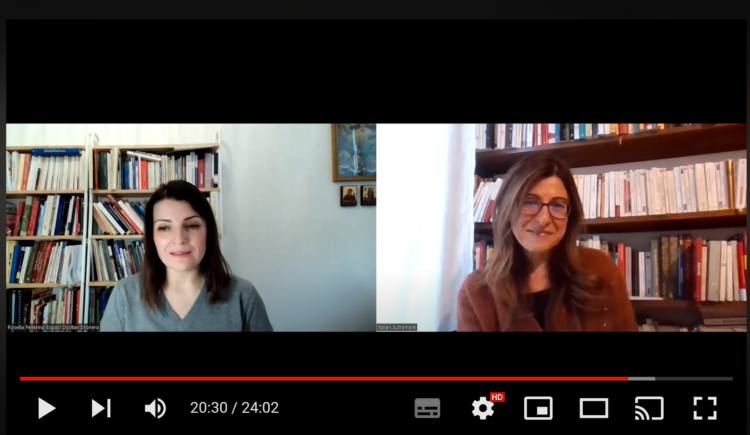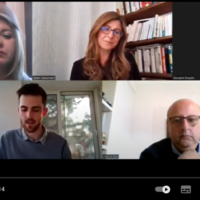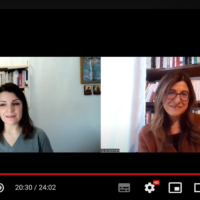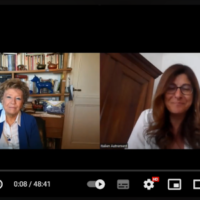Introduzione
Il racconto « Ite Missa Est » si presenta fin dal titolo, nella sua formula di congedo, come epilogo di vicende che hanno segnato la storia familiare dell’autore.
Fausto Celeghin ha infatti conosciuto da parte materna l’esodo giuliano – dalmata che, dall’8 settembre 1943 (armistizio di Cassibile) e negli anni successivi al dopoguerra, ha costretto le popolazioni italiane dell’Istria e Dalmazia a un’emigrazione forzata.
Fatto ancora più tragico, il nonno di Fausto è tra gli « infoibati » : civili italiani « scomparsi » nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre. La riesumazione dei corpi dalle foibe avverà molti anni dopo, ma di alcuni non furono mai ritrovati i corpi.[1]
Nel racconto, il ricordo percorre i confini della memoria alla ricerca di un « tempo ritrovato, » i cui miraggi illuminano il « tempo presente » della narrazione. La storia è infatti narrata attraverso gli occhi di una bambina, Norma che si trova improvvisamente a vivere la grande Storia.
Se oggi la memoria pubblica è viziata da un eccesso di nazionalismo[2], e di questo ne è prova l’attuale strumentalizzazione del giorno del ricordo[3], resta il dovere di non dimenticare, perché come afferma Marco Balzano : « Scrivere può ridare una dimensione più umana alla Storia, che invece spesso è asettica, a volte brutale, quasi sempre disumana ».[4]

Quaderni di Fausto Celeghin,
dove sono stati annotati i ricordi della madre
Liturgia della parola
Ogni domenica mattina Angiolino si mette a strillare.
«ll vestito è stretto», sbuffa indispettito e lo sgualcisce tutto, arrabbiandosi.
«I pantaloncini mi pungono» e li tira da una parte e dall’altra.
«La spilla invece mi piace» e si appunta una spilla del duce mettendo il faccione sottosopra.
«Basta Angiolino», dice la mamma, «Eh dai che non se ne può più!» e gli strappa la spilla dalla giacca.
E noi, in un gesto «Shhh…», facciamo con il dito sulle labbra.
Angiolino, il mio fratello maggiore, tutto orgoglioso e nervigno smania per la messa perché vuole farsi prete.
«Sorella, Dominus vobiscum, io diventerò soldato di Dio!».
Angiolino ha solo dodici anni e le idee non gli mancano.
Nella terra dove abitiamo, l’Istria, che non so dove si trova di preciso, è tutta una confusione che non si capisce più niente. Ci sono tante razze: i croati, gli sloveni, anche i soldati, che devono essere anche loro una razza e danno fastidio un po’ a tutti.
Adesso tocca agli italiani, dice il babbo. Un mattino presto però, quelli che sono venuti a cercarlo non erano soldati e l’hanno portato via senza neanche dargli il tempo d’infilare i pantaloni.
È da settembre che noi non ci sentiamo più a casa. Dobbiamo nascondere tutto quello che abbiamo del duce, e non far vedere che siamo italiani. Il nostro cognome è Ferenzi, ma da quando in paese girano tipi strani hanno detto che ci chiamiamo Ferenaz, che non mi piace perché non riesco a dirlo bene.
Ci avviamo in silenzio per andare in chiesa sulla strada che corre verso il paese. Prima, nessuno parlava mai di Vizinada, ma da quando ci sono dei morti e nostro padre è sparito con i Cossetto[5] e altri, il nostro paese lo conoscono tutti.
La strada che facciamo tutti i giorni per andare a scuola è lunga tre chilometri. Per un buon tratto cammina parallela al fiume Quieto, e quando allaga il prato di fronte a casa, giochiamo nell’acqua e ne usciamo ricoperti di schifose sanguisughe.
Angiolino sussulta: «Senti che rumore… Sembra una vettura! Guarda là che polverone. È un motore, è un motore e non è il dottor Lombardi».
«Chi è che c’ha un motore dopo il dottor Lombardi, xe[6] il più ricco del paese», grida entusiasta. Angiolino non sta a più nella pelle, perché lui ha le idee chiare e se non si fa prete, vuole diventare meccanico.
D’un tratto, sfreccia una motocicletta talmente vicino che ci butta con il sedere in aria. Il polverone ci colora le facce di rosso, Angiolino si rialza e corre dietro la moto: «È una Zündapp 750 dei tedeschi, motocarrozzata, 95 orari e fischia. Era uno dei nostri che guidava, l’avrà rubata a una truppa», pensa un attimo, «Forse BMW. Che motore!».
Poi si siede cavalcioni su una pietra a lato della strada e mi invita: «Monta mona[7], andiamo a fare un giro, vroom vroom andiamo via veloci fino a Pula».
Angiolino corre con un bastone dritto davanti al petto, ridendo e imitando il manubrio di una moto, e io seguendolo gli tengo dietro nonostante i suoi grandi passi.
Il sole batte su tutta la piazza, ma delle nuvole nere si muovono in lontananza. Le mille voci che si sentivano prima, le camicie nere che cantavano:
All’armi! All’armi! All’armi o Fascisti,
Terror dei comunisti.
Noi del Fascismo siamo i componenti,
la causa sosterrem fino alla morte,
e lotteremo sempre forte, forte
finché terremo il nostro sangue…[8]
sono ormai un ricordo e i capannelli di persone che si riunivano a chiacchierare sono scomparsi. Lo immagino ancora lì nostro padre, che si arriccia i baffi con la brillantina e annuisce ai discorsi dei suoi amici.
Adesso, si vedono solo due vecchie gobbe che camminano verso il sagrato recitando il rosario e due contadini di borgata zudetici[9] che giocano a morra. Noi italiani non usciamo più di casa, è meglio non farci vedere in giro, così gli altri del paese si dimenticano di noi.
Dal porticato di fronte alla chiesa ci arrivano delle voci agitate, vediamo un gruppo di uomini che urla «Dai tira forte, che viene via intero. Ora gli facciamo vedere noi, chi canta…». Strappano un cartello dal muro. Quello che abbiamo visto sfrecciare lungo la strada è sdraiato sulla motocicletta, sigaretta fra le labbra legge un libriccino, ripete la frase: «Čuvajmo bratstvo i jedins: vo, kao zjenicu oka svog ».[10]
Angiolino con gli occhi puntati sul motore dice: «Bon non xe una Zündapp 750 mona che sono, è una BMW R75».
Ci avviciniamo per curiosare, pensando di essere invisibili. L’uomo con la sigaretta si chiama Viviani e vive vicino a noi con sua nonna. Nostro padre che fa il guardaboschi, ogni tanto gli regala un prosciutto e la nonna dice che il nipote è un fannullone.
Angiolino guarda il motore «Che bestia, quanto fa?», dimenticando con chi parla.
Viviani si stiracchia «Ehi tu… italiano quanto fai di età… dodici, tredici anni?».
«Dodici. Ma dove l’hai presa la moto, e che potenza ha?».
«L’ho presa a uno che ora non gli serve più. Ti ci porto a fare un giro? Andiamo in montagna?».
«No che adesso c’è messa e io studio da prete».
«Studi da prete? E dove studi?».
«In chiesa la domenica. Imparo a memoria la messa».
Gli uomini ridono, bevono un sorso di Slivovitz[11] passandosi la bottiglia.
«E quando le chiese non ci saranno più, dove studi pretino? I preti sono la peggior razza del paese».
Il cartello si stacca dal muro portandosi dietro i calcinacci e leggo:
«Bambini, ditelo alle vostre famiglie che sono loro che cominceranno a parlare di nuovo sloveno e croato, che la nuova nazione slava sarà giusta e buona e che i fantasmi dei nostri fratelli riposeranno in pace».
Viviani spinge il pedale della moto, prende la bottiglia di liquore, sorride e se ne va.
I banchi dentro la chiesa sono divisi: maschi da una parte, femmine dall’altra. I maschi guardano le femmine, e qualcuna di loro sorride diventando tutta rossa. Io abbasso la testa e fingo di pregare, chiamo piano «Angiolino… Ehi Angiolino!». Il prete si schiarisce la voce tossendo, e mi lancia un’occhiataccia.
Dopo l’eucarestia, ci ritroviamo in piazza per attuare un piano segreto che Angiolino ha in mente da giorni, ma che a me non vuole dire. Sgattaioliamo di nuovo in chiesa, da una porta dietro il campanile entriamo in uno stanzino vicino al coro, dove tengono tutti quei trabiccoli per spargere fumo e benedizioni e sangue di Cristo.
«Son lì in quel tabernacolo, in alto».
«Ma che cosa?».
«Le ostie, mona! Monta veloce sulle mie spalle».
«Ancora un po’ e c’arrivo».
Miaooo. È Mina, la gatta del don! Si infila tra le gambe di Angiolino e ci fa rotolare per terra.
In un attimo tutti i corpi di Cristo cadono sul pavimento, con un tonfo che echeggia nella chiesa.
«Chi è là? La Mina, bestia!».
Si sentono i passi pesanti della Duša[13], che chiamano la perpetua.
«Nascondiamoci dentro le cassapanche presto», dice Angiolino.
Siamo così magri dalla fame, che ci infiliamo in silenzio in una di quelle con i vestiti del prete che odorano di chiesa.
La Duša ripete sempre che per ogni peccato c’è un peccatore, e quando vede la Mina lancia una ciabatta.
«Figlia di Satana, pelonero!».
Fa un segno della croce, che uno in più non guasta mai, borbotta tra sé e io scoppio in una muta risata perché Angiolino mi tiene tappata la bocca.
C’incamminiamo nel bosco con le tasche piene di ostie, sedendoci su una pietra a mangiarle. Sono felice, posso finalmente giocare con Angiolino. Lui non ha mai tempo, è sempre nei campi a lavorare perché, dice il babbo, le braccia non bastano mai.
«E allora? Dove andiamo?».
«Nel bosco. Lungo il fiume».
«Beh…e faremo che cosa?».
«Ti farò vedere come sono più meglio del prete a dire la messa. Ti farò la comunione».
«Ma è peccato per me».
«No, perché io sono già nella grazia di Dio».

Norma e Angiolino in una foto di classe del 1943.
Liturgia dell’Eucarestia
Entriamo nel bosco come in un mondo magico.
«Non aver paura», dice Angiolino, «sono venuto con il babbo tante volte, mi ha raccontato delle storie e di stare attento ai lupi».
«Le rocce sembrano rosicchiate», osservo con meraviglia.
«Il babbo dice che xe il posto del Carso. Le rocce se le mangia il vento e le rosica l’acqua, son tutte bucate. Là c’è un cavernon ».[14]
Mi avvicino, ma mio fratello mi tira per un braccio: «No, è pericoloso. È buio e profondo e là sotto quando soffia il vento… È come un pozzo, gli occhi si perdono nel buio e non si vede il fondo». Angiolino prende un sasso e lancia: «Ascolta». Si sente rotolare per un minuto. Poi silenzio.
Penso ai lupi delle favole, che però fanno meno paura di certi uomini. Seguo Angiolino, che lui sa la strada e proseguiamo in silenzio.
Il sentiero tira diritto. Da una parte, dopo un prato di pioppi c’è il fiume Quieto. Dall’altra un pendio e un folto bosco verso Trieste.
«È questo il posto ? » chiedo a Angiolino.
«Ecco la radura, qui sembra una chiesa… Gli alberi sono come le colonne. Là, ci sono delle pietre. Vanno bene per fare l’altare», dice convinto.
Costruiamo un piccolo altare che scricchiola. Angiolino usa un sacco di iuta smanicato portato da casa, lo mette e sembra uno spaventapasseri più che un prete. Va dietro l’altare improvvisato, ma ha uno sguardo strano.
«Manca la tovaglia per coprire l’altare, ti avevo detto di portarne una, mona!».
«Avevi detto che ci pensavi tu».
Si avvicina per spintonarmi ma una luce brilla nei suoi occhi neri: «Togliti le mutande».
Arrossisco e dico «No, perché io?».
«Perché io manco ce l’ho, non c’era più stoffa».
Mi fa pensare a quanto siamo poveri, e sento la stoffa grezza del materasso usata per fare le mutande, sfregare sulla mia farfallina, mi vergogno. Le poggio sull’altarino, mentre Angiolino prende un pezzo di brace che usa come matita e scrive: Venite Adoremus.
«Devo farti vedere una cosa» dice.
Dalla sacca tira fuori un crocifisso di legno e lo poggia tra noi e l’altarino «L’ho fatto da me. Intagliato con la roncola. Guarda qua c’è Gesù».
Un corpo storto, intagliato nel legno e con lo sguardo verso il basso ci guarda con tristezza.
Prende il crocefisso e comincia: «Figliuoli benvenuti nella casa del Signore», e dopo un bel pezzo che ripete la messa dice solenne «Adesso farò l’eucarestia, inginocchiati».
Chino la testa verso terra, e penso che un giorno avrò un fratello prete che mi proteggerà.
Mentre la sua mano mi dà l’ostia, il bosco si muove con il vento e alcuni sassolini rotolano vicino all’altare. L’acqua del fiume si agita, sento un brutto odore di marcio. Un rumore di stivali che pestano il fango e puzzo di Slivoviz.
«Eccolo qui il nostro pretino».
Sentiamo una voce dal bosco e il puzzo di Slivoviz più vicino.
«Bravo», dice un uomo nascosto dal verde delle frasche, «ti eserciti a fare il prete? L’esercito popolare non ha bisogno di preti, vuole combattenti e tu hai l’età giusta ».
Da un rumore dietro di noi, capiamo che sono più uomini.
Viviani, uscendo dal bosco strappa l’ostia di mano a mio fratello, poi con un rumore secco rompe il crocifisso in due parti.
«Ehi, bastardo» urla Angiolino tutto rosso.
«Zitto» lo canzona Viviani, colpendolo con uno schiaffo.
«No, vi prego! », balbetto impietrita dalla paura.
«Oh sì invece. Verrà con noi, e imparerà a servire un’altra causa, quella dell’odio per chi ci ha rubato la terra. Ritieniti fortunato, farai anche un giro sulla motocarrozzata».
L’uomo prima di andarsene mezzo storto tira un calcio al nostro altarino e crolla tutto: i nostri giochi, il fiume, i pensieri.
Liturgia della morte
Verso Pula il cielo sembra molto arrabbiato, sta per scoppiare il temporale. Angiolino è prigioniero dentro la veste di iuta. Si allontana sulle spalle di Viviani. La riva è piena di impronte e i ruscelletti d’acqua scendono verso la radura formando una pozza davanti ai miei piedi. Per la prima volta in vita mia, prego «Madona picinina fime una bona putina. Se da esi bona tegnime con vui, e se da esi cativa cioleme con vui in paradiso. Mi Gesù e Maria».[15]
Corro dietro quegli uomini lungo il pendio. I loro passi sono così veloci che mi distanziano senza sforzo. Quando arrivano in cima li perdo. Silenzio, le mie lacrime cadono nei solchi della terra.
«Waffen fallen lassen und hande hoch!».[16]
Sollevo la testa verso la collina. L’acqua scorre e la pioggia si mischia alle mie lacrime.
Tedeschi!
Comincio a correre, il fiatone mi brucia la gola, vedo di nuovo Viviani che urla ai suoi: « Siamo in campo aperto. Dietro i massi. Tu a sinistra! ».
I loro fucili non sparano neanche un colpo. Basta una mitragliata e tutti e tre crollano a terra come burattini. Per un attimo il buio mi porta lontano, poi ho il coraggio di alzarmi e farmi vedere: « Angiolino!!!! », urlo a squarciagola. Corro verso quei corpi e i tedeschi mi vedono e capiscono che è finita e che sono una bambina.
Ha smesso di piovere. Sotto i corpi il sangue che bagna la terra. Quel sangue che correndo a valle diventa trasparente.
I tedeschi spostano il cadavere con le facce tese e sotto il corpo di Viviani: Angiolino, mio fratello!
La sua mano insanguinata si apre e il volto intagliato di Gesù cade a terra.
Ite Missa Est.
Epilogo: Norma
Il frastuono che si sente la domenica mattina non ci lascia dormire. A Santa Caterina[17] c’è un gran subbuglio. Dalla finestra il signor Denicich urla: « Non ci hanno dato le case per fare il gran premio di Monza! ». I Denicich protestano sempre, forse non ricordano i tempi duri e il girovagare nei campi profughi dal nord al sud d’Italia. A Torino finalmente abbiamo una vita.
Dal balcone del mio palazzo, ho visto poco fa una motocicletta sfrecciare nella campagna qui intorno, in mezzo alle pecore. Da qui la città è ancora lontana, ma cresce a macchia d’olio e presto arriverà a toccare i confini del quartiere e ne faremo parte.
Mi vesto in fretta e scendo le scale. Entro in chiesa quasi urlando « Angiolino, c’è tutto il quartiere che protesta, non se ne può più! ».
Spunta da dietro la colonna dov’era nascosto ad accendere un cero. Mi guarda. È così alto che sembra ancora più magro. Le guance scavate dalle notti passate a studiare meccanica e a fumare troppo.
« Disturbate tutto il quartiere con … con quella Zündapp! ».
Mentre accende un altro cero risponde: « È una BMW, come te lo devo dire. Ho fatto il diavolo a quattro per farla arrivare qui. Io e don Giampaolo la mettiamo in sesto per partecipare alla sfilata del 25 aprile ». Lo guardo: ha una tuta che ha perso il colore talmente è unta di olio, le mani affusolate dal lavoro di fino, un cacciavite che spunta dalla tasca.
« Digli di portare pazienza, lavoro durante la settimana. La prossima volta cambio la marmitta così non fa rumore. Saluto don Giampaolo, mettiamo il motore al coperto e vengo ».

Ragazzi e pecore alle Case Rosse,
Villaggio di Santa Caterina, Torino, 1956
Archivio Privato Marino Marussi.
Sono sempre in ritardo. Non è un mio difetto. È la grande città in cui viviamo ad essere in anticipo. Anche Il fine settimana la vita scorre frenetica. Mentre passeggi ti dicono « Signorina, permesso che c’ho pressa neh ». Il tram balbetta sulle rotaie, cigola, sbuffa, arranca.
« Angiolino, ricordi dov’è? ».
« Xe qua, due fermate. E non chiamarmi Angiolino ».
« Due fermate », mi risponde l’autista col suo accento del nord.
Questa vita mi ha portato qui ed è da qui che riparto. La mia immagine riflessa nelle vetrine mi restituisce una giovinezza che non è perduta in Istria nel dolore, ma è ritrovata qui, in una vita in via di assestamento. Le mie scarpe sono splendide, quelle lucide per le grandi occasioni, il vestito di seta e gli orecchini della mamma.
Lo guardo con tenerezza « Ho comperato due biglietti per lo spettacolo di Nilla Pizzi così ci svaghiamo un po’. Ne hai bisogno, sei sempre dietro ai motori, mona ».
« Ora son qui sorella, con te ».
« E non mi chiamare sorella ».
« E tu non chiamarmi Angiolino ».
Il tram arriva di fronte al teatro. Si aprono le porte. Entriamo confusi, le luci, la folla.
L’orchestra suona: Vola Colomba.[18]
Dio del Ciel se fossi una colomba
Vorrei volar laggiù dov’è il mio amor,
Che inginocchiato a San Giusto
Prega con l’animo mesto:
Fa che il mio amore torni
Ma torni presto
Fummo felici uniti e ci han divisi
Ci sorrideva il sole, il cielo, il mar
Noi lasciavamo il cantiere
Lieti del nostro lavoro
E il campanon din don
Ci faceva il coro
Vola, colomba bianca, vola
Diglielo tu
Che tornerò

Norma a sinistra |

Angiolino nella sua officina negli anni ‘80
|
Autore Fausto Celeghin
Curatrice : Fabiola Viani
Il racconto è letto ad alta voce da Walter Fano.
[1] https://digilander.libero.it/lefoibe/infoibati.htm#tata
[2] Guadagnacci L.,2021, Eric Gobetti. E allora le foibe?, Altreconomia, online : https://altreconomia.it/eric-gobetti-e-allora-le-foibe/
[3] Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ».
Fonte Wikipedia
[4] Quarti M., 2018, “Una storia è sempre lingua, voce”. Marco Balzano si racconta, Il Libraio, online : https://www.illibraio.it/news/dautore/marco-balzano-intervista-774055/
[5] Norma Cossetto, talvolta menzionata erroneamente come Norma Corsetto (Visinada, 17 maggio 1920 – Antignana, 4 o 5 ottobre 1943), fu una studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.
Fonte Wikipedia
[6] La terza persona del verbo essere “è”, in veneto si scrive “xe”: si pronuncia come una s sonora.
[7] Mona : in dialetto veneto, organo genitale femminile. Nell’accezione usata qui dai bambini ha significato di « stupido, cretino ».
[8] Inno ufficiale dei fascisti.
[9] Zudetici : abitanti di una borgata vicino a Vizinada, in provincia di Pola ai tempi del racconto.
[10] Čuvajmo bratstvo i jedins:vo, kao zjenicu oka svog »
(Proteggiamo la Fratellanza e l’Unità, come la pupilla del nostro occhio), fu il motto della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia; indicava il sentimento che univa i popoli della Federazione, lo spirito laico, interetnico e tollerante sulla base del quale, secondo Tito, andava rifondata la Jugoslavia. Fu coniato da Josip Broz Tito nel 1941, all’inizio del movimento partigiano.
Fonte Wikipedia
[11] Slivovitz è un distillato di prugne popolare in tutta l’Europa centrale, dalla gradazione tra i 40 e i 45C.
[12] Un manifesto del periodo della italianizzazione fascista della minoranza slava in Italia fatto dai fascisti italiani. Fonte Wikipedia
[13] Duša : in croato « anima ».
[14] Cavernon : termine usato per « foiba » in Sgorlon C., Foiba grande, Mondadori,1992.
[15] « Madonna piccina fa di me una brava bambina. Se sarò buona tenetemi con voi se sarò cattiva prendetemi con voi in paradiso. Mio Gesù e Maria ».
[16] « Gettate le armi e mani in alto !».
[17] Villaggio di Santa Caterina : Nel 1952 un programma nazionale prevede l’assegnazione ai profughi istriani del 15% degli alloggi edificati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari su finanziamento dello Stato. A Torino, nel 1954, inizia la costruzione, ultimata nel 1955, del Villaggio di Santa Caterina a Lucento tra via Pirano e via Parenzo.
Fonte : Museo di Torino, online : https://www.museotorino.it/view/s/9e2b67ead76a45e7b2c6315e6658b714
[18] « Vola Colomba » è una canzone del maestro Carlo Concina e il poeta Bixio Cherubini. Vola Colomba vinse il Festival di Sanremo del 1952 nell’interpretazione di Nilla Pizzi. La canzone, che ebbe un enorme successo, trattava proprio del ritorno di Trieste all’Italia. Bene evidenti nel testo sono riferimenti al capoluogo della Venezia Giulia: « … inginocchiato a San Giusto » (la basilica cattedrale di San Giusto, principale edificio religioso cattolico della città di Trieste, sulla sommità dell’omonimo colle che domina la città); « noi lasciavamo il cantiere » (Trieste era sede di cantieri navali); « il mio vecio » (il padre nel dialetto veneto). Fonte : Wikipedia