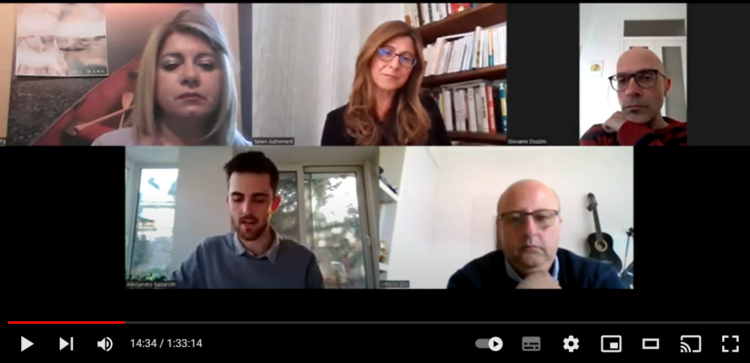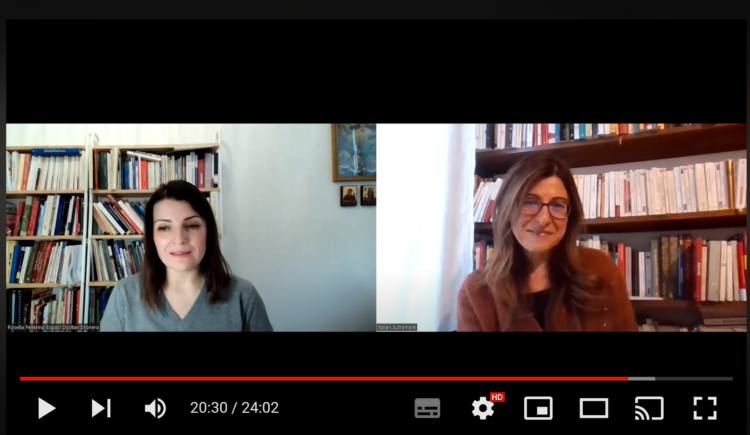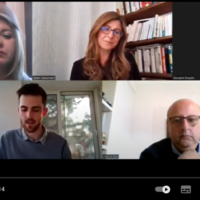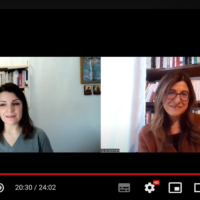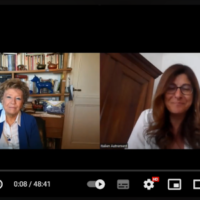A marzo di quest’anno, Diego Marani è diventato il nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.
Nato a Tresigallo in Emilia Romagna, ha studiato prima al liceo classico Ariosto di Ferrara e poi presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per traduttori e interpreti di Trieste. Nel 1985 ha cominciato a lavorare come traduttore per il Consiglio dell’Unione Europea e, nel 2006, è entrato a far parte della Direzione Generale Cultura della Commissione Europea.
Da anni collabora con alcuni giornali tra cui il Sole 24 Ore e, nel 2020, il ministro della cultura Dario Franceschini gli ha affidato il compito di presidente del Centro per il libro e la lettura.
È autore di numerosi romanzi tradotti in più di 15 lingue, alcuni dei quali vincitori di importanti premi. Nel 2021 è ritornato in libreria con “La città celeste” edito da La nave di teseo, un romanzo di formazione ambientato a Trieste, città crocicchio di lingue e culture diverse.
Attento alla tematica dell’identità e dell’appartenenza, Diego Marani che, nel 1995, ha inventato per gioco l’europanto, attraverso i suoi scritti ci invita a guardare verso nuovi mondi e nuove culture senza remore e senza paure perché è accettando le differenze, anche quelle linguistiche, che si riesce a conoscere meglio se stessi.
Alla nostra rivista ha concesso questa intervista che vi proponiamo.

Istituto Italiano di Cultura di Parigi
Prima del suo recente incarico di direttore dell’istituto italiano di cultura era già stato in Francia, esattamente a Parigi, come studente alla Sorbona, negli anni ottanta. Che effetto le ha fatto tornare a vivere in questa città?
In tutti questi anni ho frequentato spesso Parigi come turista. Da Bruxelles il viaggio è breve. Ma arrivarci di nuovo per viverci è stato diverso. Inevitabile il paragone fra lo studente squattrinato che ero e il direttore del più prestigioso istituto italiano di cultura che sono diventato. Del mio soggiorno negli anni Ottanta ricordo fortemente due cose: il funerale di Sartre e il Resto U di Mabillon. Il primo perché vi partecipai sentendolo come un evento storico. Il secondo perché non mangiai mai più così male in vita mia. Parigi allora era tutta una scoperta per me. Una metropoli sconfinata in cui però era facile vivere. Ricordo che tutto era accessibile, si poteva entrare a lezioni e conferenze alla Sorbona senza controlli, si potevano avvicinare persone importanti con facilità. Era un’epoca in cui quando si andava all’estero ci si sentiva davvero spaesati. La Francia era un paese al tempo stesso lontano e vicino. I francesi ci conoscevano poco, spesso solo attraverso i luoghi comuni. Ricordo un numero di L’Express dedicato all’Italia che titolava in copertina richiamando Galileo: “Pourtant elle tourne!” Oggi i francesi ci conoscono meglio anche se certi luoghi comuni e certe loro interpretazioni della nostra realtà sono duri a morire. Parigi è al tempo stesso più vicina, più vivace, più ricca ma anche più complessa da vivere. O forse è solo una questione di età. A vent’anni tutto è meraviglia e scoperta. A sessanta il peso dell’esperienza ci rende forse più lucidi ma ci toglie ogni incanto.
Gli istituti di cultura – organismi del Ministero degli Affari Esteri – possono essere considerati da più punti di vista. A me piace definirli luoghi di incontro e di scambio non solo fra chi ama il nostro paese, ma anche fra culture diverse. Condivide questa definizione e se si, cosa pensa di fare per favorire tali scambi?
Sulla porta del mio ufficio c’è scritto “Istituto italiano di cultura” e non “Istituto di cultura italiana”. È quindi proprio così che io intendo il suo ruolo. Un punto d’incontro, un luogo di scambio e di dialogo fra la cultura italiana e quella francese con ogni diramazione aperta ad altre culture ancora. Nel mio programma voglio portare avanti questo approccio e presentare realtà italiane in una prospettiva di dialogo e di incontro con corrispettivi francesi.
Di Lei si scrive spesso che è ferrarese e un po’ lo è, visto che ha studiato in questa bellissima città. Tuttavia, il borgo che le ha dato i natali è Tresigallo, frazione di Tresignana, in provincia di Ferrara. Quanto influirà il suo essere nato in provincia, nel ruolo di direttore di un istituto di cultura. Mi spiego meglio. In Francia, finalmente, si parlerà un po’ di più dei piccoli centri italiani, ricchissimi di cultura, che sono tantissimi da nord a sud?
Proprio perché sono cresciuto in provincia, conosco la problematica dei territori marginali, spesso ricchi tanto quanto le nostre città ma dimenticati dai circuiti turistici. I centri minori, così ingiustamente chiamati, hanno la debolezza di essere sparsi in territori vasti e non concentrati in un’unica realtà cittadina. Una criticità che vive anche la Francia con la sua provincia eternamente lontana da Parigi. Voglio agire per correggere questo disequilibrio nei due sensi: portare più Italia minore in Francia e portarla anche fuori da Parigi, nei territori che sono di competenza dell’Istituto.
Parliamo adesso di lingua e cominciamo con una sua invenzione risalente agli anni novanta e che ha, a dir poco, dell’incredibile : l’europanto, un idioma costituito da tutte le lingue d’Europa. Com’è nata questa idea di mettere assieme tante lingue e che ruolo potrebbe avere questa sua invenzione oggi in cui, in piena crisi sanitaria, abbiamo assistito ad un proliferare di termini inglesi?
L’europanto è una creazione del 1994, quando cominciai a scrivere piccole cronache in questa lingua gioco su giornali belgi e svizzeri. L’idea è semplice e quasi banale: le lingue si mescolano, si sono sempre mescolate. Il mio gioco sistematizza questo miscuglio sfruttando la comprensibilità intrinseca di molte parole che ormai non appartengono più a una lingua soltanto, come ad esempio pizza, mamma, bundesbank, coiffeur, penalty e tante altre parole che la modernità ci porta. Questo vocabolario, organizzato in una struttura grammaticale vagamente inglese, che ormai conosciamo tutti un poco, diventa comprensibile. Questo è l’europanto, in fondo praticato da sempre dai bagnini delle nostre spiagge con i turisti stranieri. Il mio gioco non si propone però come lingua universale. Io non credo nelle lingue universali perché la molteplicità dell’esperienza umana non può stare in una lingua soltanto. Anzi proprio a questo ha l’ambizione di educare il mio gioco: comprendere l’importanza della diversità linguistica e saperla valorizzare imparando le lingue vere. Rendersi conto che le lingue non appartengono a accademie o a governi ma alla gente che le parla. Le lingue ci hanno a lungo diviso perché pretendono di definire la nostra identità e appartenenza, nell’ottica dello Stato nazionale che tanta parte ha avuto nelle tragedie del Novecento. Liberarle da quest’onere e renderle un patrimonio condivisibile è un passo importante verso un’Europa dei popoli e non dei governi. Capire la lingua dell’altro è l’antidoto all’incomprensione, alla paura, alla diffidenza e la ricetta giusta per la coesione e la costruzione di un futuro comune.
Dal libro « Las adventures des Inspector Cabillot »
Aquello augusto postmeridio, Cabillot was in seine officio un crossverba in europanto solvente. Out del window, under eine unhabitual sun splendente, la city suffoqued van calor. Zweideca vertical: « Esse greco, esse blanco und se mange », quatro litteras. Cabillot was nicht zo bravo in crossverbas. Seine boss le obliged crossverbas te make ut el cervello in exercizio te keep, aber aquello postmeridio inspector Cabillot was mucho somnolento. Wat esse greco, esse blanco und se mange? tinqued. May esse el glace cream? No, dat esse italiano aber greco nicht. Cabillot slowemente closed los eyos und sich endormed op seine buro. Der telefono ringante presto lo rewakened. « Hallo cocco! Cabillot parlante! » Tracce N.3/97 « Aqui Capitan What! Come subito in meine officio! » « Yesvohl, mein capitan! » responded Cabillot out van der door sich envolante. Capitan What was muchissimo nervoso der map des Europas op el muro regardante und seine computero excitatissimo allumante. « Cabillot! Nos habe esto messagio on el computero gefinden! Regarde alstubitte! ».
Vorrei continuare a parlare di lingue e nello specifico dei dialetti. Per molto tempo quelli italiani sono stati assimilati all’emigrazione e alla miseria di chi era costretto ad andare via dal nostro paese per costruirsi una vita migliore. Oggi, grazie al lavoro di studiosi e linguisti, i dialetti cominciano ad essere rivalutati e considerati per il loro giusto valore. L’Istituto Italiano di Cultura ha dei progetti per contribuire al loro riconoscimento?
I dialetti italiani sono la prova esistente del nostro multilinguismo, che dovremmo essere capaci di praticare imparando anche altre lingue europee. L’italiano è abituato alla diversità linguistica e trova naturale vivere in un contesto dove dialetto e lingua nazionale convivono ma sembra incapace della stessa adattabilità quando si tratta di parlare lingue straniere. Nel mio programma di attività darò spazio anche alle lingue locali e soprattutto alle lingue delle minoranze che si esprimono nel nostro paese e che sono una parte della nostra cultura.
Trieste e Bruxelles sono due città di confine e crocevia di culture, ciascuna a suo modo. In queste città Lei vi ha studiato e lavorato prima di arrivare a Parigi, capitale cosmopolita dove convivono , profondamente radicate nel tessuto sociale, etnie e culture diverse. Cosa si può e cosa si deve fare oggi per mantenere vive queste diversità senza perdere la propria identità?
A me piace pensare all’identità come a qualcosa di mobile e non ad uno stampo immutabile in cui veniamo al mondo. L’Italia in cui sono nato non è la stessa di oggi ma è sempre Italia. La mia italianità nel corso della mia esperienza lavorativa e di vita si è nutrita di tantissima diversità senza mai perdere la sua natura profonda. Non dobbiamo avere paura di cambiare perché il cambiamento è connaturato nell’esperienza umana. Non ci sarà mai neppure un momento nella nostra vita in cui saremo privi di identità. L’identità è qualcosa che si coltiva, e a più fonti si nutre, più è vivace e capace di trovarsi un futuro.
Diego Marani è un uomo dalle molteplici identità : scrittore, giornalista, linguista, editorialista, traduttore e anche romanziere. “La bicicletta incantata”, “L’amico delle donne” , “Il compagno di scuola” “L’ultimo dei Vostiachi” e “La nuova grammatica finlandese” sono solo alcuni titoli dei suoi romanzi. Pensando alla sua vita mi viene in mente una frase di James Joyce che tra l’altro ha vissuto, come Lei, nella bella Trieste “la cosa più importante non è cosa scriviamo, ma come scriviamo. Lo scrittore moderno deve essere prima di tutto un avventuriero”. Lei condivide questo pensiero?
Lo scrittore autentico è sempre un avventuriero perché scrivere è creare mondi, costruire personaggi che vivranno anche dopo di noi, se siamo capaci di scrivere opere durature. Non si torna indietro dai mondi in cui ci si inoltra scrivendo e quel che si inventa finisce per esistere davvero, per incalzarci ad ogni momento. Scrivere è esplorare ma l’esploratore non sa mai quel che trova e quando lo ha trovato non può rimetterlo al proprio posto. Diventa parte di noi, dobbiamo farci i conti. Chi scrive sa che apre una porta da cui può entrare anche quello che non cerca.





Intervista di Stefania Graziano-Glockner