Vi ho mai parlato dello zio Pepin?
Immaginate un uomo sulla sessantina, basso, tarchiato, capelli grigi, con un cappello sempre in testa, come quello di Jacques Prevert; un uomo che non ha niente da fare tutto il giorno ma che è sempre di corsa, incontenibile, appassionato, traboccante di energia e di eccitazione per qualsiasi cosa faccia, fosse anche soltanto quella di comprare il giornale del mattino. Immaginate, inoltre, uomo nato e cresciuto in un piccolo villaggio del nord Italia, ai piedi delle Dolomiti, che si sposa in giovane età e con la moglie Arista si trasferisce in Francia per cercar fortuna nella zona mineraria di Morbihan, a nord di Nantes. Un individuo che assomiglia ai personaggi del naturalismo francese, uno di quei minatori ricoperti di fuliggine, prestanti e friabili allo stesso tempo, una fragile statua a modello per il Germinal di Zola che con la sua profonda esperienza potrebbe perfino permettersi di correggere i sentimenti di un Chaval e meglio declinare le sofferenze di un Lantier. Immaginate, infine, un instancabile parlatore, un oratore nato, uno di quegli individui capaci di conversare con chiunque si fermi ad attraversare la strada. Questo è lo zio Pepin.
Andai a trovarlo nel ’94 o nel ’95 – oggi non ricordo più con precisione l’anno del nostro momentaneo trasferimento in Francia – e pertanto all’epoca avevo sei o sette anni. Abitava in una torre alta quindici piani e interamente ricoperta di cemento armato, una torre che si innalzava alla periferia di Vannes, e per un bambino come me, abituato alle stalle e agli ovili, la sommità del condominio coincideva con la punta del cielo.
Se chiedevi informazioni sul Miramas Palace – tale era ed è tuttora il nome dello stabilimento – tutti ti dicevano subito che si trattava di una torre creuset, assolutamente, impeccabilmente creuset, che come ho scoperto molto più tardi significa “crogiolo”. In effetti, bastava guardare distrattamente l’aspetto della facciata est della torre per capire l’origine del nome.
Al primo piano abitava la famiglia Brahim, tunisina di provenienza e di tradizione, che da due generazioni si era stanziata all’interno del condominio. Mi ricordo che il sig. Nadir guidava una vecchia Renault 5 di colore rosso e portava sempre con sé un maglione di lana, anche quando ci si scioglieva dal caldo.
Al secondo piano c’era una famiglia di indiani, i signori Hirandani. A me sembravano molto buffi, sicché ogni volta che salivamo al nostro appartamento io volevo sempre fermarmi a salutare. Lui era un signore sulla cinquantina, con le gambe sottili e una pancia enorme, grandi baffi neri e delle scarpe a punta molto bizzarre; lei, la signora Sharmila, indossava sempre abiti lunghi e sgargianti, e ogni volta che mi vedeva mi regalava un jalebi, un dolce di zucchero e sciroppo che cucinava per placare la nostalgia della terra natia.
Noi occupavamo il terzo piano. Con noi abitava, naturalmente, la zia Arista. Il terzo piano era quello degli italiani, dato che nell’appartamento accanto al nostro abitava una famiglia di genovesi, i signori Traverso, anch’essi migranti in cerca di fortuna.
Quando arrivai a casa dello zio Pepin mi stupii a scoprire che, dopo tanti anni trascorsi in Francia, gli zii parlavano ancora tra di loro il dialetto d’origine, quello delle valli di montagna del nord Italia, e questo mi faceva sentire a casa nonostante avessi affrontato un lungo e stremante viaggio in treno. Il dialetto usciva spontaneo soprattutto la sera, quando lo zio Pepin si innervosiva ed esclamava: « Quando che lè ora de magnar non te la vede pì!», che tradotto significa che la zia s’inventava dei mestieri casalinghi sempre all’ora di cena, come fare il bucato o mettere ordine nelle credenze. Lei diventava creativa quando si versava la minestra sul piatto. «Arista l’Artista! », scherzava lo zio. Un’artista nata, ma soltanto durante i pasti, e questo mandava lo zio Pepin su tutte le furie, così iniziava a imprecare in tutte le lingue del palazzo, gli uscivano dotti accostamenti inter-religiosi e li rimescolava tutti con rabbiosa fantasia. Inventava vocaboli, modellava neologismi, forgiava parole, e tutto per un breve ritardo della zia Arista.
Scoprii che durante i primi mesi che seguirono il loro approdo in Francia, lo zio non sapeva ancora proferire una parola in francese, ma poiché è sempre stato uno spirito socievole, non ha mai esitato a introdursi nelle conversazioni altrui. S’intrometteva con educazione allo scopo di poter conoscere e familiarizzare con la gente del quartiere, così a volte lo zio finiva invischiato in qualche dibattito politico o in qualche conversazione sportiva, difficile da sostenere per chiunque non parlasse l’idioma locale. Era chiaro a tutti che non riusciva a seguire il discorso, ma lui si mostrava concentrato e interessato, eccome! E per partecipare in modo credibile alla conversazione, lui ogni tanto gettava uno sbuffo qua e là, era tutto un « Ulala!… wouf… c’est fou!… ulala!… c’est magnifique!». Ed era furbo il vecchio! Alternava gli ulalà ai wouf a seconda del tono della voce degli interlocutori: se i signori erano preoccupati, eccoti servito un bel wouf, magari accompagnato da uno sguardo a terra spento e sconsolato; per contro, quando invece saliva il ritmo e l’esaltazione nel discorso, eccoti che ti stupiva con un puntuale ulalà, con un grande sorriso e una pacca sulla spalla. « È tutta una questione di tempismo!», mi raccontava lo zio Pepin.
Col passare del tempo lo zio imparò il francese, se non altro per poter progredire al lavoro e portare a casa uno stipendio più dignitoso. Ma il desiderio di parlare sempre con tutti estese gli orizzonti delle sue conoscenze linguistiche, sicché dopo circa un anno sapeva salutare in tutte le lingue rappresentate all’interno del Miramas Palace. Ogni mattino, quando si scendeva a comprare il pane, era una grande festa di ossequi e convenevoli, un namastè di qua, un salam-aleikum di là; aveva imparato anche l’inglese, e per giunta con l’accento indiano, allo scopo di poter meglio discutere con il signor Hirandani del piano di sotto. Un bel pasticcio linguistico era lo zio Pepin.
L’estate che arrivai alla torre di cemento io non capivo il francese, sicché necessitavo di una traduzione ogni volta che si incontravano le persone del condominio. Senza esitazione alcuna, lo zio vestì con entusiasmo i panni dell’interprete. Transitava con agilità dal francese al dialetto delle montagne, dribblava con destrezza le insidie della trasposizione linguistica e poi, di nuovo, con uno slalom adattava l’argot al francese, di reverso, con astuzia. Questo compito lo elettrizzava.
«Ogni traduzione racchiude in sé una piccola creazione», era solito dire lo zio Pepin con fierezza. E come dargli torto! Col passare dei giorni lo zio si trasformò sempre più in inventore, in un Archimede della fonetica, perché più mi diventavano familiari alcuni termini francesi e più lui smetteva di trasporli e cominciava ad amalgamarli all’italiano, li inseriva spontaneamente nel nostro dialetto creando una nuova lingua sconosciuta al resto del mondo. Quando parlava, fuoriusciva dalle sue labbra un cocktail di glottologia, un composto di grammatiche, e con quale fantasia! Se uscivo con il sole di mezzogiorno alto in cielo, mi diceva: « Meti su la casquette ! », ricordandomi di indossare il cappellino per proteggermi dai raggi di calore; e quando la sera bisognava scendere in strada, con la spazzatura da gettare via, eccolo che mi impartiva l’ordine: «Bisogna portar do la poubelle !».
Accostava il dialetto d’origine con alcuni termini francesi, li associava, li accoppiava, e il risultato era una montagna di strane frasi rimescolate e frullate, delle preposizioni a testa in giù che avevo bisogno di tradurre nuovamente nella mia testa per poterle decifrare.
Arista lo stuzzicava con ironia: «Tu parli l’italiacane!». Anche lei inventava definizioni e categorie, a forza di assorbire la fantasia dello zio Pepin. Lo prendeva in giro soltanto, non si esprimeva mai con cattiveria o invidia. Eppure lo zio era fiero della sua immaginazione e del suo estro creativo, perché per lui la cosa più importante nella vita era capire le persone e mescolarsi con esse.
Ancora oggi utilizzo alcune espressioni dello zio Pepin. La spazzatura è rimasta la poubelle, il cappellino la casquette. Ancora oggi mi capita, a volte, di rimescolare inconsapevolmente gli idiomi, di aggregare dialetti e vocaboli solo apparentemente distanti, e quando succede mi scappa un sorriso e provo un po’ di nostalgia per quella torre di cemento che conteneva l’India e l’Oriente e lo zio Pepin, che con le sue stravaganze linguistiche sapeva ricoprire di musica una povertà sempre in festa.
Marco Bortoluzzi


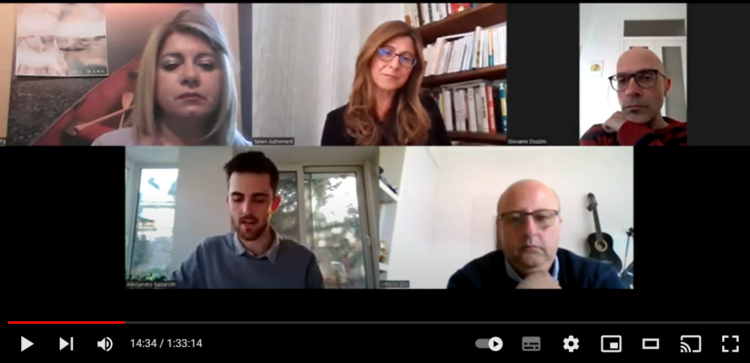

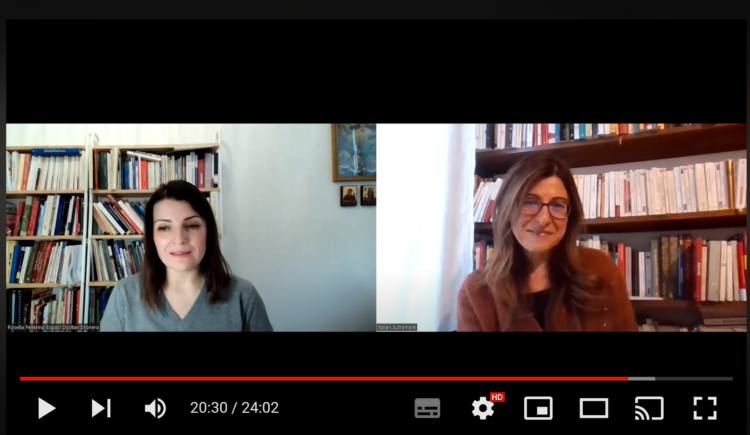
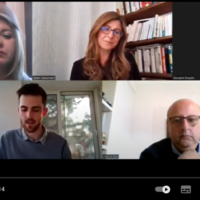

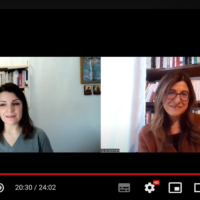

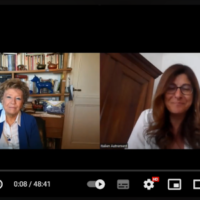








Comments
jasmin e joelle
bellissimo prof!!!!!!
Nicoletta
Meraviglioso... complimenti