Non so cosa mi abbia spinto in questo quartiere che non conosco. Fino a poche ore fa, pensavo che sarei rientrato: avrei fatto le solite cose, inviato due o tre messaggi, fatto un giro su Facebook, preso in mano un libro prima di addormentarmi. Oppure avrei ascoltato una musica nuova, con le cuffie quelle che ti avvolgono le orecchie, con cui ti godi ogni singola, preziosa vibrazione. Invece cammino a vuoto da almeno un’ora ormai, sotto la luce fioca dei lampioncini che appena schiariscono la pietra nuda delle calli. Non porto mai orologi e il cellulare sta sepolto nella tasca, batteria scarica. Dovrei portare con me un caricabatterie, ogni volta me lo dico, che non tiene più la carica e che dovrei pensarci al caricabatterie, la mattina. Poi mi dimentico e le ultime ore del giorno le passo sconnesso. Arrivato ad un vicolo cieco, mi arrendo all’evidenza: mi sono perso. Proprio quando quel “perso”, scarica elettrica fatta pensiero, mi attraversa il cervello, tutto d’un tratto si fanno sentire (reduci da un ascolto prolungato che le ha sedimentate nella memoria) le prime note del Pelleas et Mélisande di Debussy. “Je ne pourrai plus sortir de cette forêt”: Golaud, uscito da un castello leggendario per cacciare, si ritrova prigioniero di un’immensa foresta, allegoria dell’intricato labirinto emozionale che pervade tutta l’opera. Poco importano il dove e il quando per questa storia d’amore e di morte: la grande forza di Pelleas (libretto di Maeterlinck) sta nella capacità di sostenere fino alla fine una tensione implacabile che ci obbliga a fare i conti con l’oscurità, l’incomunicabilità e le pulsioni più inammissibili dell’animo umano, in un tempo sovrastorico perché è il tempo di ogni vita umana. Perdersi a Venezia è un’esperienza che mescola piacere e angoscia: la città ti tiene per mano, eppure percorrere quel dedalo di calli così simili e così diverse una dall’altra, la sensazione di ritrovarsi al punto di partenza o di imbattersi in una barriera d’acqua senz’altra possibilità che quella di ritornare sui propri passi, questa perdita di punti di riferimento sconvolge la propria interiorità (pur sapendo che si tratta di un terrain de jeu in cui ci si lascia perdere, la fiducia riposta proprio in quella mano tesa dalla città). La foresta di Golaud diventa allora labirinto di pietra: gli alberi fitti sono pareti strette o lunghi sotoporteghi sotto i quali devo chinarmi per passare oltre. Addentrarsi nelle proprie ombre, inghiottiti da una bellezza metamorfica: Venezia è anche questo.
Lontano il campanile di san Marco suona i rintocchi della mezzanotte (un suono grave, di campane possenti, come di fiaba). Non è rimasto nessuno, ma lo strisciare dell’acqua color smeraldo che abita i canali non lascia mai l’ultima parola al silenzio; paziente e appena tremolante, l’acqua, sinuoso basilisco visita instancabile il ventre della città. Mi sono perso, ma nessuno mi aspetta. Venezia è un grande animale marino: compatto e coperto di scaglie lucenti visto dal finestrino dell’aeroplano, frammentato e sorprendente in ogni piccolo angolo quando cammini nelle sue interiora fatte di pietra, vetro ed acqua. Mi accade qualcosa di insolito in mezzo a quelle labirintiche viscere: mi vedo dall’esterno, muovermi come un animaletto, in un curioso andirivieni. Per andare dove? Dov’è che si va, di preciso, nella vita? Vedo qualche luce accesa. C’è ancora un’osteria aperta, i tavolini già accavallati per la notte ma il barista, che asciuga svogliatamente qualche stoviglia, discute con un cliente che ha buttato un borsone stropicciato sotto lo sgabello. Nello stanzone decrepito, pieno di poster e quadretti non allineati, chiedo una birra anch’io. Andiamo subito d’accordo, in quella felice solidarietà che può dare un bicchiere nel cuore della notte. Il barista, un hipster tatuato col viso buono avvolto in un grembiule blu, il cliente, un uomo sui cinquant’anni, piuttosto tarchiato, con gli occhi grandi e il viso scolpito dal sole, io col look del viaggiatore alla buona (grossomodo, ho indossato quel che di pulito restava nel mio zaino): curiosa, improvvisata trinità. Si parla di schei, e di donne: ma come spesso accade sono solo i prodromi; poi, rotto il ghiaccio, si possono tentare anche i massimi sistemi. “Quanta mona ghe xe en giro, fioi” canticchia il barista da dietro il bancone, mentre l’uomo sullo sgabello si rivela essere un elettricista che lavora in terraferma (in terraferma, bellissimo!) e che deve però lasciare tutte le mattine il cane alla madre, che abita a campo San Stin, nel sestiere di San Polo; è stufo di fare i viaggi. Non riesco mai a replicare, in quello che si configura presto come un monologo (in veneziano stretto): nel pomeriggio la figlia gli ha chiesto tremila euro per andare all’università, ma lui quei soldi non li ha, perché sono separati e deve già pagare un sacco di cose. Li chieda a sua madre i soldi, che non le dà mai niente. “Sua figlia deve assolutamente poter iscriversi se è quello che vuol fare” riesco a dirgli, ma mi sento subito a disagio. Mentre parla mi fissa con i suoi grandi occhi torvi, come se da un momento all’altro stesse per rimproverarmi qualcosa. Non so bene perché, ma mi sento colpevole di ascoltare la sua storia. “Delle donne, proprio non voglio più saperne”, rincalza poi il barista, che mentre parla fa girare lo spritz come si fa coi vini pregiati. Io gli faccio capire che vorrei saperne di più, tento anche, complice l’alcool, un accento veneziano che mi riesce malissimo. Anche lui reduce da un divorzio, solo che la moglie gli ha preso, dice, tutto: soldi, casa, macchina, persino i figli se non fosse stato per l’avvocato. “Quello che non ti uccide ti fortifica”, la sua morale, che scandisce lentamente, in italiano, quasi per accentuarne la solennità, una verità, la sua verità. Questo sono le osterie: piccoli fari nella notte, dove chi è perso nella vita forse non si trova, ma trova compagnia. Di quella compagnia che fa bene, che nasce spesso dalle ceneri della miseria, perché all’osteria ci vai coi tuoi problemi ma nessuno ti giudica. Problemi che sono fondamentalmente gli stessi da quando esiste l’umanità. “Mi gò più gusto andar all’Osteria / che no xe, co xe festa, andar a Messa” scriveva il settecentesco Zorzi Baffo, che quando non si occupava degli affari della Serenissima ricercava proprio quella preziosa, forse vitale compagnia che solo l’osteria poteva offrirgli. E chi se ne frega della Verità: ognuno porta la sua, come ognuno porta i suoi problemi, restano solo storie e individui nello spazio in bilico tra la notte e il giorno. Mentre i due parlano tra loro, Jep Gambardella, in un impeccabile completo nero, mi sussurra a due centimetri dall’orecchio il suo cinico ma sublime monologo finale: “Finisce sempre così, con la morte. Prima però c’è stata la vita, nascosta sotto i bla, bla, bla, bla, bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore: il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile. Tutto sepolto nella coperta dell’imbarazzo dello stare al mondo”.
Più tardi, rimessomi in viaggio nel ventre della città-foresta, ripenso a quella storia incredibile del matrimonio di Venezia col mare. Durante la festa della Sensa, dell’Ascensione, il doge dal bucintoro gettava un anello in mare, per confermare e sacralizzare lo sposalizio di Venezia con le acque. Desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique dominii. La frase rituale veniva pronunciata mentre l’anello sprofondava nelle acque. Il rito, tentativo di una comunità di esorcizzare la paura, processo catalizzato proprio dallo straordinario (che trascende l’ordinario) che metteva in scena il rituale. Oltre i domini della Repubblica, là dove il sole sorge stavano, minacciosi e imprevedibili, i Turchi. Ecco perché per tenere saldo il “perpetuo dominio” era necessario sposare il mare, ingraziarselo. Quella stessa paura, forse, Molière la esorcizzava con le risate nel suo Bourgeois Gentilhomme: la buffa cerimonia dei Turchi, caricaturali fino all’osso e disumanizzati, di cui si irridono, seppur bonariamente, la lingua e le usanze. La paura dell’alterità, il terrore del nemico: sentimento ancestrale che però teneva facilmente insieme una popolazione e proteggeva lo status quo dell’oligarchia veneziana. Ad Antonio Vivaldi era stato commissionato un oratorio, Juditha Triumphans, in onore della battaglia decisiva del 1716 che aveva scacciato i Turchi da Corfù. Trombe, tamburi, coro e grande orchestra, ma nell’inconscio collettivo la minaccia era sempre alle porte, come un’ombra che incombeva sui sogni di patrizi e poveracci. Ma, penso ancora, se l’angoscia è anche una componente della pulsione erotica, se cioè, come scriveva Bataille, attrae ciò che inconsciamente spaventa perché sconosciuto, allora Venezia è terribilmente seduttrice. Venezia vestita d’Oriente, impreziosita in ogni sua parte dal gotico direttamente ispirato all’arte islamica, quel gotico che arrivò proprio con le crociate e che è diventato il simbolo della città. Venezia erotizza il nemico, lo vuole vicino in sensualissimi boudoirs, in decorati salotti e nell’intimità dei casini dove si gioca e si invitano le prostitute. Sono soprattutto i numerosissimi, sfarzosi balconi con rosoni e archi trilobati a incarnare quel gioco straordinario di grazia e leggerezza, miracolo di un’arte che seduce perché simbolo di un’alterità temuta e ricercata insieme.
Venezia, “sexe femelle de l’Europe” come la definì Apollinaire? Forse piuttosto magnifica trasposizione urbana del corpo transessuale, seguendo la lezione di Paul B. Preciado, quando scrive, con la profondità che pervade sempre i suoi scritti, che la città “si eleva ininterrottamente di fronte alla propria impossibilità di esistere” ma compie questo sforzo, e in questo sta racchiuso il suo fascino, “non con la forza, ma attraverso un’esaltazione poetica della propria fragilità”. Venezia, magnifico travestito (trans-vestitus, vestito oltre, frutto di un trapasso, di un continuo e fluido compromesso). “Se Venezia non avesse il ponte, l’Europa sarebbe un’isola” cantava il poeta Mario Stefani. Poco importa che le sue strade principali siano calpestate dai piedi del mondo. Si trovano sempre angoli in cui Venezia-Narciso, eternamente confrontata col proprio riflesso, permette anche a noi di vedere le nostre vite specchiate nelle sue acque eterne. Anche di solitudine si tratta, penso mentre sbuco improvvisamente sul Canal Grande, di fronte alla stazione ferroviaria, accanto alla cupola verde di San Simeon Piccolo. Ritrovo lì un gruppetto di ragazzi che forse tornano da una festa; la loro allegria, così spontanea e dirompente, mi riporta definitivamente al punto da cui tutto era cominciato, prima di perdermi, al di qua del sogno. La foresta finisce, ricomincia il tempo. Ma qualcosa è cambiato: sopra le acque di Venezia, adesso si vedono le stelle.
Bruno Rattini


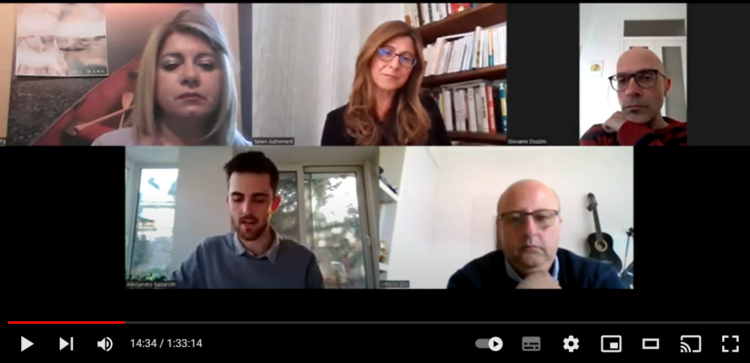

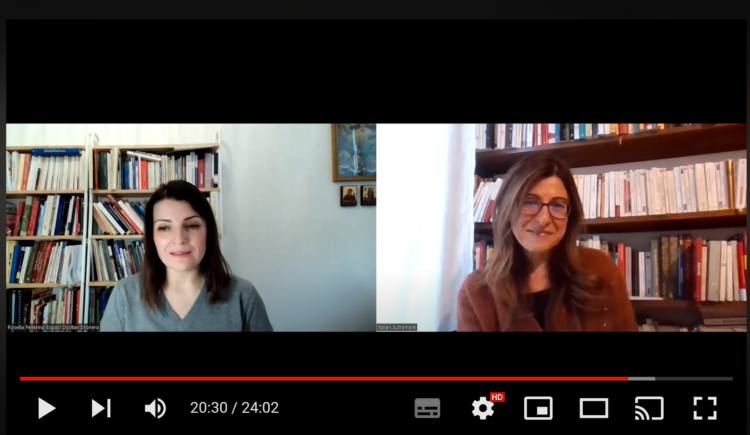
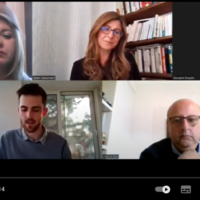

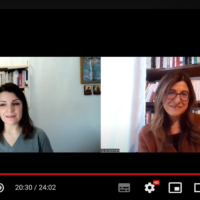

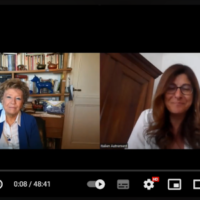








Comments
GARAICOECHEA
Merci pour cette belle plume, qui donne envie d'aller au-delà des masques en retrouvant le plaisir de se perdre.