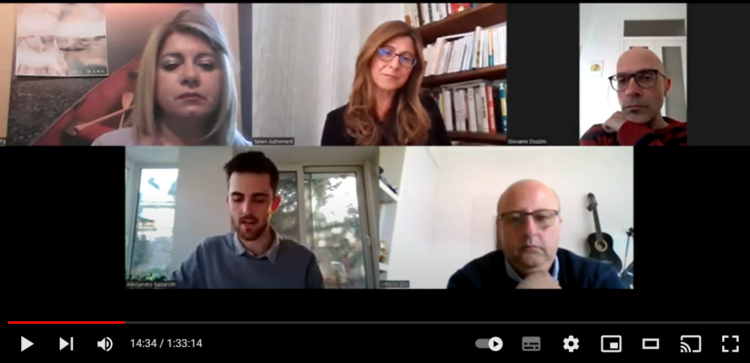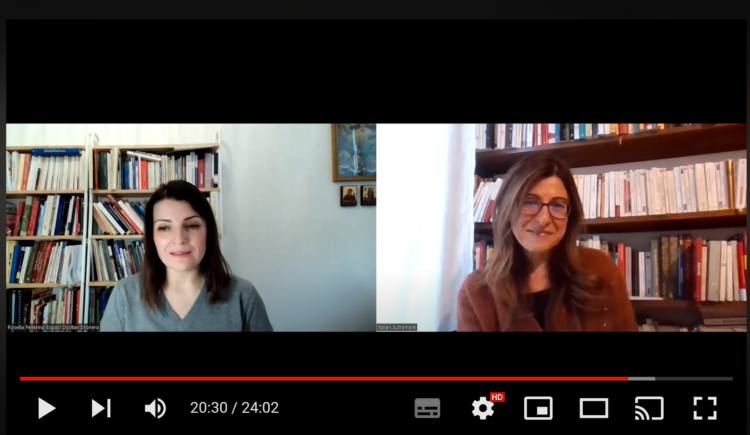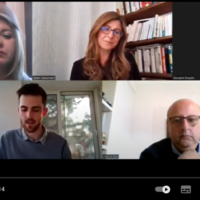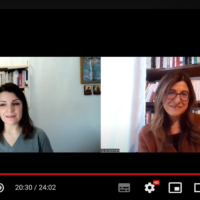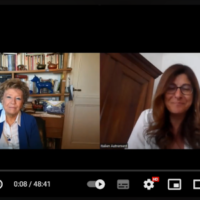Tradurre è spesso un inganno, un imbroglio che comincia sin dal liceo, quando si dice agli allievi di “mettere in ordine” i periodi in latino prima di tradurli, come se il latino fosse una lingua disordinata. Ogni lingua ha la sua logica intrinseca, perché chi l’ha escogitata, per poter comunicare, non lo ha fatto seguendo un ragionamento capace di superare le barriere dell’ego, che spesso ostacola la comprensione tra gli esseri umani. Partendo da questo assunto, la via più corretta sembrerebbe quella di lasciar perdere le traduzioni e leggere un brano, in qualunque lingua sia scritto, alfabeto permettendo, come se stessimo leggendo uno spartito di musica. È pur vero che non tutti conoscono la musica, ma poniamo per un momento che siamo tutti capaci di leggere uno spartito di Mozart: a nessuno verrebbe in mente di tradurlo in un linguaggio diverso da quello musicale. La parola è pur sempre un suono; una poesia, per esempio, ha un suo ritmo, una sua logica formale e musicale, pertanto occorre sempre fare i conti con tutto ciò, quando si cerca di leggere dei versi.
Un altro errore della scuola odierna, almeno in Italia, è quello di non far sentire quasi mai, salvo casi rari di docenti illuminati, il ritmo che pervade le pagine della letteratura mondiale, quindi il primo approccio non è la lettura e l’ascolto della musica delle parole, ma la loro traduzione, la loro “comprensione”, attraverso le famigerate parafrasi. È bene ricordare che chi scrive non usa solo parole, ma anche ritmo e suono, colori e vibrazioni e non c’è “verso” di comprendere una poesia se non si tiene conto anche di questo. Nessuno si sognerebbe di fare la “parafrasi” di una strofa del Concerto numero 3 per pianoforte e orchestra di Beethoven, fermando l’esecuzione a ogni strofa per tradurla in linguaggio coevo. Prima ascoltare, chiudere gli occhi e cogliere il ritmo, l’armonia, la logica del brano e la forza delle emozioni, poi, e solo poi, tradurre e interpretare. Stessa cosa dovrebbe accadere per la poesia e la letteratura.
Resta un problema: la logica di una lingua non è la medesima di un’altra. Conoscere l’italiano, per esempio, non vuol dire solo esprimersi correttamente in questa lingua, ricordare tanti vocaboli e costrutti grammaticali, ma è riuscire a fare vibrare armonicamente le parole ed essere in grado, quantomeno, di non creare stonature.
Nell’atto quindi di tradurre una poesia, per esempio, dallo spagnolo all’italiano, o viceversa, il requisito principale di un traduttore è che non sia sordo alla musica di quella lingua, alla sua armonia, al suo ritmo, alla sua intrinseca logica millenaria, giusta o sbagliata che sia, giacché frutto di stratificazioni, violenze, sogni, soprusi e bellezza. La lingua di un popolo è espressione dell’inconscio collettivo, che si permette determinate cose e se ne vieta altre. Ogni lingua è il risultato di questa evoluzione psicologica e sociale, quindi non esistono due “idiomi” sovrapponibili, tutt’al più possono essere complementari. Ergo, padroneggiare più idiomi consente di simboleggiare qualcosa che la propria lingua madre impedisce di dire e pensare. Sì, perché non possiamo dire ciò che non siamo in grado di pensare, ciò che l’inconscio ci impedisce di pensare.
Leggere letteratura in altre lingue, vuol dire concedersi nuove riflessioni. Per tale ragione è difficile imparare una lingua la cui logica potrebbe scardinare una nostra personale barriera inconscia.
Dinanzi a tutto questo complesso sistema psicodinamico, è facile comprendere quanto possa essere arduo, se non impossibile, tradurre qualcosa da una lingua all’altra, ed ecco perché, una traduzione, col passare del tempo, risulta obsoleta, al contrario dell’originale. Neruda, per esempio, letto in spagnolo è eterno, le sue trasposizioni in Italiano, o in qualsiasi altra lingua, vanno invece riviste continuamente: a lungo andare risultano datate. Le dinamiche inconsce di un paese mutano, come la sua lingua, quindi occorre adeguare le traduzioni dei classici stranieri, che nella vecchia forma non parlano più, giacché manca in esse il radicamento inconscio che invece pervade l’originale nella sua propria lingua.
Da questo discorso sembrerebbe emergere un atteggiamento ostile alla traduzione, ma non è così, anzi: tradurre è un gesto quotidiano che noi mettiamo in atto in ogni singolo istante in cui parliamo con qualcuno, anche con la nostra stessa madre. È vero che la lingua di un paese ha una sua logica intrinseca intraducibile, ma è pur vero che ogni soggetto pensante e parlante possiede delle strutture logiche proprie, figlie delle dinamiche socio-culturali che le hanno determinate. Occorre pertanto tradurre sempre in altra lingua, quella del nostro inconscio, ciò che le orecchie catturano. Tenendo anche nel dovuto conto le inevitabili incomprensioni, generate nel momento in cui le nostre barriere non accettano costrutti che possono ferirci, o toccare “note sommerse” da tempo. Ciò che è dentro di noi è un universo per la maggior parte inesplorato e ogni nuova parola che apprendiamo, in qualunque lingua, può diventare la chiave per aprire una di quelle porte chiuse da decenni. Come scrive Elias Canetti ne La provincia dell’uomo: “Se gli uomini avessero solo il più lieve e vago sospetto di ciò che vive e si agita in loro, si ritrarrebbero inorriditi da molte parole e modi di dire come da un veleno” (Elias Canetti, Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1972, tr. it. di Furio Jesi: La provincia dell’uomo, Adelphi, Milano, 1978, p. 23.)
Tradurre è una necessità umana inconsapevole, perché figlia del desiderio di semplificare e comprendere, di trovare la strada più breve verso lo svelamento del vero e, allo stesso tempo, una scorciatoia che ci consenta di non passare per quelle province estreme dove abbiamo relegato i nostri fantasmi.
Tra le note di una poesia, per esempio, si nascondono silenzi che solo un buon lettore può cogliere e rendere in un’altra lingua; giacché un verso, come una partitura musicale, è fatto di pieni e vuoti, di note e pause, di parole e silenzi. Coloro che si impegnano a tradurre non possono fare a meno di inoltrarsi negli anfratti tra una parola e l’altra, tra una frase e l’altra.
A volte basta confrontare due traduzioni diverse di uno stesso testo, per rendersi conto di quando siano lontane l’una dall’altra, in termini di ritmo e armonia. Questo è frustrante, perché ciò che salta alla coscienza è la domanda: “Chissà come suona nella lingua dell’autore”. È sufficiente leggere un testo anche in una lingua che non si conosce, per afferrarne la consonanza e il fascino. Faremo un riferimento a un’esperienza di chi scrive: nella traduzione, l’unica esistente in italiano, dei versi del poeta basco Jabier Betisa Delgado Morales, si è tentato di fare questa operazione di ascolto per mantenere, grazie anche al sostegno dell’autore – il quale parla perfettamente le due lingue, ma che scrive solo in castigliano – il ritmo e i silenzi. Non si è pensato di restare fedeli solo al significato, ma soprattutto di conservare la forza ritmica del significante e dello spazio tra un verso e l’altro, risicato a volte, ma abissale in altre circostanze.
Le poesie di Jabier Delgado sono raccolte nel volume Lasciami cadere, edito da Città del Sole edizioni. Già il titolo ha inteso sottolineare questo aspetto formale della traduzione: lasciare che il ritmo cadesse dove era necessario, indipendentemente dalla parola – la quale può e deve trovare un corrispondente -, ma che non fosse a tal punto vincolante da dissipare i silenzi e gli accenti del poetare.
In questa ottica, tradurre assume il senso più alto e nobile di interpretazione inconscia, perché ciò che è necessario non si perda. In una traduzione serve questa spinta interiore, capace di toccare nel lettore, qualsiasi sia la sua madrelingua, le medesime corde.
Il battito del cuore dell’interprete di Leopardi, per esempio, deve essere il medesimo, in qualunque forma le sue poesie siano rese. Se non si riesce a realizzare questo, non si è fatta una buona traduzione. Spesso, i tempi dei traduttori, a causa del mercato vorace, non consentono di soffermarsi così a lungo su questo aspetto, ed ecco che subentrano i fraintendimenti e i danni a discapito dell’arte.
Chi pratica questa professione ha una grande responsabilità: non può tradurre chi non conosce i limiti del proprio mondo interiore e non sia in grado di identificare i propri fantasmi.
Il dolore provato da Delgado per la perdita della donna amata nei bombardamenti di Guernica del 26 aprile del 1937 può trovare corrispondenza in un traduttore che ha paura di affrontare un personale dolore per la perdita della persona amata?
C’è un confine tra chi scrive e chi traduce, dato dalla visione del mondo di entrambi. Non tutti possono tradurre tutto! Trasporre qualcosa è un’operazione indispensabile che parte dal conoscere se stessi e termina nel desiderio umano di scoprire il mondo attraverso i suoi straordinari dettagli.
Francesco Idotta