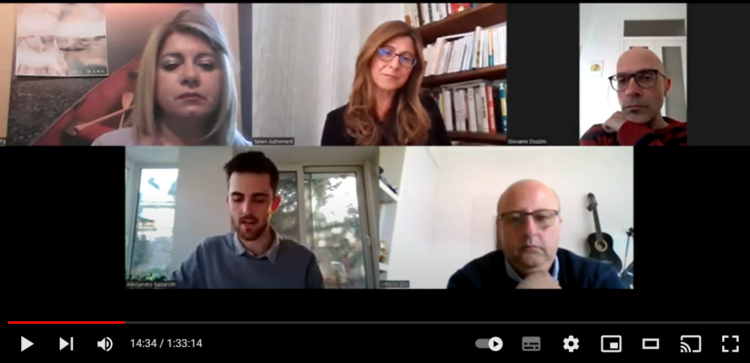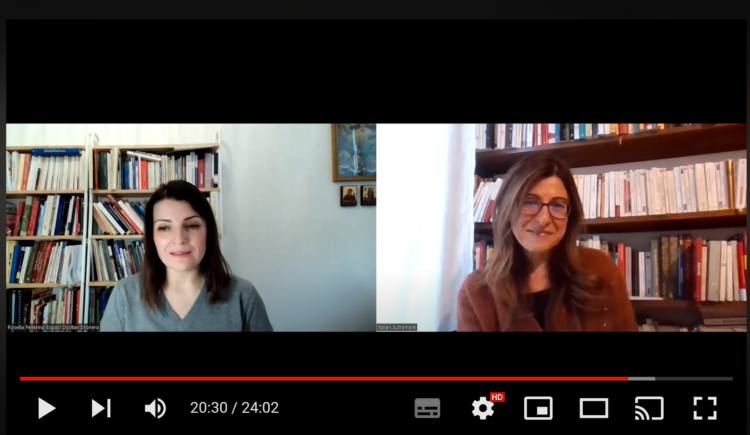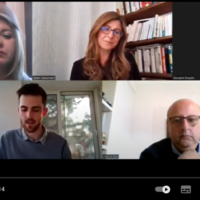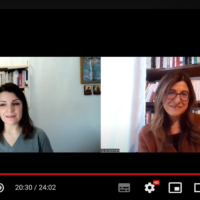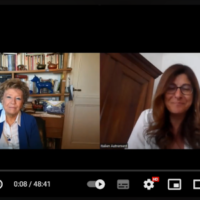Quando ero bambina la favola di Pinocchio era quella che meno prediligevo. Non c’erano mamme, bambine, donne, nemmeno lo straccio di una principessa da salvare. Solo maschi che dicevano bugie e combinavano monellerie, come solo i maschi sapevano fare—pensavo—con il naso che mostruosamente cresceva e rimpiccioliva, grilli saccenti, marionette parlanti, un orco burattinaio, il gatto e la volpe traffichini e straccioni. Solo la fata turchina si salvava ma anche lei era poco credibile, fuori posto su quello sfondo di menzogna e miseria. Compariva poco, dispensava magia, medicine e buoni consigli ma, insomma, non riusciva a riconciliarmi con quell’universo a me assai poco congeniale. Sarà pure che la scuola mi piaceva molto e il teatro dei burattini meno, per cui proprio non capivo il senso del tradimento di Pinocchio. Gli sta bene, pensavo, che Mangiafuoco minacci di gettarlo sulle braci per cuocere il montone.
E che dire del Gatto e della Volpe? Come potevo perdonare a Pinocchio di essersi fatto abbindolare da due sconosciuti (con cui i bambini non dovrebbero fermarsi a parlare) che blaterano di alberi di monete d’oro? Insomma non c’era verso. Quella storia proprio non la digerivo, nemmeno nella versione animata di Walt Disney e meno che meno nella celebrata versione televisiva di Comencini del 1972 che andava avanti per sei puntate e di conseguenza prolungava l’agonia.
Crescendo poi, cominciai a provare fastidio per le allusioni falliche implicite nel tropo della crescita del naso. L’idea che la mancanza di disciplina linguistica e comportamentale—la bugia—fosse comparabile ad uno scarso controllo della libido confermava ancora una volta come la favola fosse il prodotto di un’immaginazione patriarcale, tutta coniugata al maschile. E tuttavia, fu proprio la questione del naso a cambiare lentamente le coordinate del mio approccio alla storia, quando mi imbattei in quella che la studiosa Georgia Panteli identifica come uno degli archetipi dell’invenzione di Collodi, e cioè la novella di Slawkenbergius: lunga digressione che il reverendo Laurence Sterne incastona nel romanzo umoristico Tristram Shandy, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1759-1767). In quel testo divertente e dissacratore si racconta la storia di Don Diego, un forestiero che semina scompiglio senza precedenti quando arriva nel villaggio di Slawkenbergius a causa del suo naso di proporzioni eccezionali. Nonostante il contrappunto ironico della voce narrativa, che tenta di fugare qualsiasi dubbio riguardo al significato letterale della parola “naso”, la novella continua a inanellare un doppio senso dopo l’altro. Dunque, la funzione modellizzante che la novella sterniana poteva aver avuto sul Pinocchio di Collodi mi spinse a riconsiderare l’umorismo del testo, la sua dimensione ludica e trasgressiva che certamente non sfugge allo sguardo di un lettore adulto.
L’altra svolta nel mio rapporto con il mito del burattino-bambino è avvenuta quando ho cominciato a interrogarmi sulle ragioni della sua associazione con l’idea di italianità, riflessione importantissima per tutti gli espatriati italiani. E questo ha significato anche ricostruire la storia editoriale del testo.
Così ho scoperto che prima di essere pubblicato in volume nel 1883, Pinocchio era uscito a puntate su “Il Giornale per i bambini” tra il 7 luglio 1881 e il 25 gennaio 1883. Fu proprio il grande successo della pubblicazione seriale a convincere Collodi dell’opportunità di continuare la storia dopo il capitolo VIII, nel quale Pinocchio era finito impiccato al Campo dei Miracoli a seguito della frode del Gatto e della Volpe. Sarebbe stato un finale pedagogico e piuttosto noir se Collodi non avesse deciso di resuscitare il burattino il quale, in fin dei conti, dato il suo “buon cuore” —qualità condivisa con il babbo Geppetto—non meritava affatto quel destino.
A Pinocchio viene dunque concessa la possibilità di continuare le sue avventure e, soprattutto, di riabilitarsi, tornare a scuola, salvare Geppetto, diventare un “eroe”. Ma che cosa significava essere un eroe nel 1883? Se il secolo rivoluzionario era ormai agli sgoccioli, e le varie guerre d’indipendenza avevano portato all’Unità d’Italia nel 1861, restava però da completare il vero processo di unificazione: “Fatta l’Italia, bisogna fare gli Italiani”, secondo la famosa formula attribuita a Massimo D’Azeglio. Era questa la nuova missione civile.
In Pinocchio la retorica del “buon cuore” si coniugava con il dovere patriottico all’istruzione che avrebbe potuto risolvere il problema del regionalismo, del plurilinguismo, della disgregazione. Nel 1877 la legge Coppino aveva appunto prolungato la durata della scuola elementare dai quattro ai cinque anni, rendendo obbligatorio il primo triennio. Come osserva Stefano Jossa in Un paese senza eroi, “Pinocchio risultava perfetto per esprimere un ideale nazionale fondato su pochi e semplici valori etici e familiari. E fu effettivamente utilizzato come eroe nazionale da gran parte della retorica patriottica e nazionalista di stampo fascista” (p. 160).
Ma ben presto ci si rese conto che Pinocchio poteva funzionare anche da modello negativo, o da antieroe, data la sua attitudine alla furberia, alla mancanza di disciplina, alla monelleria. Per non parlare del fatto che l’assenza di una genitrice nella storia del burattino rischiava di compromettere il grande mito eteronormativo e riproduttivo del ventennio. Di conseguenza la stessa cultura fascista tentò di remargli contro, senza grande successo peraltro.
Insomma, come dice ancora Jossa: “anche se è stato l’eroe letterario italiano che più di ogni altro è andato vicino ad essere consacrato eroe nazionale, la sua complessità e la sua ricchezza lo hanno per fortuna salvato da un infelice destino simbolico” (p. 164).
Venendo ora, finalmente, al Pinocchio di Matteo Garrone del 2019, il mio lungo preambolo serve da cornice per indicare quello che non c’è, a mio parere, nell’adattamento cinematografico di Garrone, ovvero l’umorismo e la misura eroica.

Se il Gatto e la Volpe, interpretati dai mitici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nell’adattamento di Comencini, erano indubbiamente portatori di una dimensione comica, diventano invece, nella pur magistrale performance di Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, i cantori di un universo truffaldino e affamato. La scena rabelaisiana del pasto all’osteria in cui i due compari trascinano Pinocchio prima di condurlo al Campo dei Miracoli, è un susseguirsi di primi piani con cibo semi-masticato tracimante dalle bocche sgraziate, grugniti animaleschi e occhi sgranati. Più che di comicità si può parlare, per i due personaggi reinventati da Garrone, di grottesca tragicommedia che alla fine del film vira decisamente verso il tragico, nella penosa scena del Gatto cieco che avanza a tentoni e cade, vanificando l’ultimo tentativo della Volpe di imbrogliare l’ormai rinsavito Pinocchio.
Viene alla mente il famoso “sentimento del contrario” di cui parla Pirandello, per il quale l’umorismo si sprigiona a ridosso di un’impressione comica quando su di essa si innesta la riflessione. La ragione per cui questo non capita nel caso del Gatto e della Volpe garroniani è perché i personaggi esistono, agli occhi dello spettatore, in uno stato di perfetta liminalità umano-animale che produce spaesamento. Sono esseri umani le cui azioni sono motivate da bisogni reali—la fame, la miseria—o esseri ibridi che popolano un universo fiabesco?
Ma del resto è proprio la capacità di mescolare l’umano e il non-umano vegetale ed animale a costituire la grande forza di questo Pinocchio garroniano che conferma l’abilità del regista de Il racconto dei racconti (2015), ma soprattutto di Dogman (2018), di abitare i confini del reale da un punto di vista non antropocentrico e, perché no, postumano.
E allora la traduzione del libro di Collodi che è stata detta filologica, perché immensamente più fedele delle precedenti alla lettera del testo originario, rinvia senz’altro a quel momento storico in cui, all’indomani della diffusione delle teorie darwiniane nella seconda metà dell’Ottocento, l’umano perdeva la propria centralità al cospetto delle altre specie e cominciava a prendere forma quella mentalità ecologica che con le dovute correzioni arriva fino ai giorni nostri.
Si spiega così la scelta di un Pinocchio meticolosamente truccato dal pluripremiato Mark Coulier che ostenta sul viso e sul corpo i solchi delle venature del legno. Una scelta iper-realista, si è detto, affinché l’attore Federico Ielapi somigli effettivamente a un burattino. Questo è vero, purché ci si metta d’accordo sul tipo di realismo perseguito da Garrone che intende mettere in evidenza, e non nascondere, le tracce dell’innesto umano-vegetale. Lo stesso si può dire a proposito degli altri personaggi antropomorfi—la spettacolare Lumaca (Maria Pia Timo), i già citati Gatto e Volpe, il Corvo (Massimiliano Gallo), il Grillo Parlante (splendidamente interpretato da Davide Marotta), per citarne alcuni—che sono convincenti proprio perché di umano conservano solo il prodigio della parola ma che altrimenti potrebbero essere perfetti cyborg.
Ci troviamo dunque in presenza di un realismo “agenziale”, quello che la filosofa Karen Barad ci propone nel segno di un perpetuo divenire dei fenomeni, per cui gli umani, gli animali e la natura non hanno un’identità essenziale che preceda il loro interagire con gli altri esseri viventi, con tutto ciò che esiste. Ecco perché nella versione di Garrone il ceppo di legno, che Mastro Ciliegia con sollievo cede a Geppetto affinché il magnifico Roberto Benigni ne estragga il più bel burattino che si sia mai visto, è privo di voce. Perché quel legno non è già umano ma lo diviene, grazie all’amorevole processo creativo dello stupito falegname.
Allo stesso modo, la scena della metamorfosi di Pinocchio e Lucignolo (Alessio Di Domenicantonio) nel paese dei balocchi ha senso proprio a partire dal bruegeliano sfondo campestre, senza giostre luccicanti e colorate ma con grandi distese di fieno, tiro alla fune e giochi d’acqua. Pare quasi un passaggio obbligato, infatti, la trasformazione dei bambini in ciuchi dopo che in quel paesaggio si sono rotolati, fra la polvere dei campi e la paglia delle stalle dove giacciono la notte. È l’effetto di un’interazione simbiotica con quella realtà naturale.
Venendo poi alla fata turchina, che Garrone ci offre nella versione bambina di Alda Baldari Calabria e adulta di Marine Vacth, se da un lato la sua solida presenza e convincente interpretazione come compagna di gioco, prima, e madrina amorevole, poi, certamente porta un po’ di equilibrio di genere alla storia tutta al maschile, d’altro canto inserisce anche una nota goticheggiante nel film. Pure in questo caso si tratta di una fedele trascrizione del testo originario. Nel capitolo XV, infatti, Collodi mette in scena la fata presentandola come una bambina “con il viso bianco come un’immagine di cera, (…) con gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto”. Questa presenza spettrale e, ancora una volta, liminale, dice di essere morta “senza muover punto le labbra (…) con una vocina che pareva venisse dall’altro mondo”. Non a caso la fata di Garrone ha un colorito azzurrino che tende al grigiastro, i capelli non proprio turchesi ma di un colore incerto tra verde e azzurro chiaro. Pare essere emersa dalle brume dei Racconti fantastici di Iginio Ugo Tarchetti più che dalla penna di uno scrittore di storie per bambini. Ma proprio per questo, nel segno di un attenuarsi dei confini tra tutto ciò che esiste—nel flusso ininterrotto di umano-non-umano, natura-cultura, vita-morte— possiamo davvero credere che il bacio della fata revenant doni fattezze umane al ligneo Pinocchio.
Che cosa resta infine della componente eroica, nazionalista e fascistoide di Pinocchio nell’adattamento garroniano? Molto poco direi, a parte il mito degli italiani “brava gente”.
Non possiamo far altro che parteggiare per Lucignolo e Pinocchio quando i due marinano la derelitta scuola di campagna e il suo poco autorevole maestro dalla voce garrula, straccione come il povero Geppetto ma molto meno compassionevole di lui viste le crudeli bacchettate che dispensa alla schiera di monelli. Siamo orgogliosi, è vero, quando Pinocchio inaspettatamente infila la risposta giusta ad un astruso problema matematico e ci rallegriamo per pochi secondi all’idea che la ricompensa di quella sua dedizione sarà l’imminente trasformazione in essere umano. Dico pochi secondi perché siamo consapevoli che il finale è già scritto: il burattino dovrà superare altre durissime prove prima di meritare quel rito di passaggio.
La conquista della cultura e dell’italianità, idea con cui Garrone sembra titillare lo spettatore proponendo una vasta gamma di personaggi portatori di alterità che parlano con l’accento napoletano—il saltimbanco del teatro dei burattini, l’oste che offre da mangiare a Geppetto, il grillo parlante—si rivela in realtà un depistaggio. Non sarà l’istruzione scolastica impartita a Pinocchio nel toscanissimo borgo della Val di Chiana, dove il film è ambientato, a salvare Geppetto. Sarà piuttosto il duro lavoro nei campi cui il burattino si sottopone per guadagnare qualche soldo e guarire il babbo malato dopo averlo salvato dalla pancia del pescecane. Nel “buon cuore” di Pinocchio, insomma, pare consistere il suo eroismo, che eroismo non è, alla fin fine, ma solo umanità.
Un ultimo cenno bisogna farlo alla straordinaria fotografia del film (di Nicolaj Brüel), con l’alternarsi di una oleosa luce calda dei buoni sentimenti—soprattutto nelle scene iniziali ma anche nelle riprese che vedono Pinocchio appartarsi con Lucignolo in fuga dalla scuola—e di una luce metallica, grigia e invernale che appartiene invece ai campi lunghi, alle scene spettrali nel bosco, alle tempeste in mare, ma anche alla casa prodigiosa della fata turchina. Lo stile di Garrone pare allora mescolare a tratti il gotico padano di Pupi Avati e quello celtico di The Wicker Man di Robin Hardy, anche se lo sguardo ecologico e ibridante gli consente di superare i limiti dell’horror misterico per additare una realtà possibile ai confini dell’umano.
Enrica Maria Ferrara