Il giorno che nacque Giulia si erano scaricati gli orologi. Era presto, ed ebbe paura di fare tardi. Così si mise a nascere.
È a terra e c’è una pozza viscida intorno a lei. Gli occhi sono sigillati, come quando ti svegli la mattina e hai un po’ di raffreddore. Oppure non ti sei struccata la sera prima e hai pianto, però avevi il mascara e la matita; così tutto il pasticcio di lacrime e trucco si è ingolfato tra le palpebre.
Fa pressione con i polpastrelli, tirando la pelle della palpebra destra verso l’alto. Sente la tenera fessura degli occhi che cede e poi la voce risuonare ferita. La coglie di sorpresa, uscendo tutta insieme da stomaco e polmoni: un grido acuto.
Il dolore nella cavità oculare è stato intenso. Troppa luce. Il suo corpo si è ribellato, ha urlato.
Cerca di lavorare a poco a poco, piano piano. Prende un po’ del liquido vischioso che sente sparso intorno a lei. Procede a tentoni, la mano tesa verso l’umido, leggermente esitante perché non sa cosa sia la sostanza di cui è circondata. Non è solo a terra ma addosso, su gambe, pancia, anche. La stessa roba è spalmata sulla faccia.
Mentre tocca la pozza con disgusto, un pensiero rapido le guizza nel cervello: “Sono nuda”.
E poi, un altro pensiero che si fa domanda: “Perché sono nuda?”.
Cerca di ricordare ma non trova niente. Non ha memoria che preceda il momento in cui ha provato a svegliarsi. E allora dove ha preso l’idea del raffreddore? E quella del trucco che si impasta con le lacrime? Si concentra, pesca, fruga, ma non trova niente.
Però che strano! Se tocca il liquido denso e si sofferma sul suo spessore, sulla maggiore o minore acquosità, un fremito la attraversa leggero: parte dall’alluce e arriva fino alla cima della testa, lungo la scriminatura dei capelli. E dentro il fremito c’è un’immagine colorata del passato.
La poltiglia di farina lattea che sua mamma le dava quand’era piccina per svezzarla. Doveva essere densa così, o forse un po’ di più. Se tocca di nuovo il lago colloso del suo corpo, le pare di sentire l’odore di quel riso appiccicoso.
—Ne andavi pazza! Non finivi nemmeno la prima cucchiaiata che già me ne chiedevi un’altra!
—E come te la chiedevo?
—Sgambettavi e ti torcevi, cercavi di prendere il cucchiaio. Non avevi neanche ingoiato e già ne volevi ancora!
—Sarà stato il senso di pienezza…
—Cioè?
—E cioè, deve essere bello sentire di avere lo stomaco pieno dopo mesi e mesi che uno ha bevuto solo latte, latte, latte.
—Eh, soprattutto per te che il latte lo vomitavi sempre! Lo volevi e poi lo vomitavi. E piangevi tutta la notte per la fame che avevi!
Quante volte l’aveva sentita quella storia: il vomito, il latte, le notti insonni, la farina lattea, tanta fame. Così tanta che era diventata una bella bimba grassottella, con gambette, guanciotte, rotoli e rotoli di pancia.
Prova a muoversi e sente la pozza sotto di lei spostarsi. Una lieve onda di umore le sfiora la coscia. Sussulta, con un gridolino che sembra una risata. Ancora non ha aperto gli occhi dopo essere stata investita dalla lama di luce. Ci prova di nuovo e fa attenzione a tenerli puntati in basso, dove immagina che ci sia l’ombra.
Disserra l’occhio destro e poi il sinistro. Un millimetro di spazio per accogliere il mondo di fuori.
È in una posa stramba, a metà tra il seduto e lo sdraiato, come se si fosse messa a sedere a gambe incrociate e poi si fosse incurvata in diagonale verso il ginocchio destro, restando con metà del corpo accartocciato sotto. La faccia è a poca distanza da terra ma non è schiacciata contro il suolo, è rivolta all’infuori seguendo la torsione del busto. Insomma è in una specie di posizione fetale da seduta. E quando schiude le palpebre, in teoria dovrebbe vedere tutto da sotto in su ma ostinatamente ancora cerca l’oscurità, puntando gli occhi in basso.
Neppure così c’è sollievo: frammenti di materia argentea aggrediscono la retina, come luce riflessa da uno specchio.
Pensa che a questo punto non abbia senso rimanere premuta al suolo. Non c’è nessun beneficio per lo sguardo e comincia pure a sentirsi un po’ scomoda. Dolcemente si solleva, raccoglie i suoi arti da terra come fossero petali caduti. Con cura ed affetto. Nell’alzarsi avverte un cambiamento di temperatura perché adesso il torace e i seni scoperti sono esposti al contatto dell’aria. Si abbraccia piano e massaggia la pelle degli avambracci, delle spalle, delle scapole, fin dove arrivano le dita. L’effetto è quello di quando ti metti la crema idratante dopo la doccia. Solo che la crema si assorbe e si asciuga mentre la sostanza oleosa che Giulia ha addosso rimane lì e non va da nessuna parte.
È seduta in posizione del loto. Gambe e piedi sono intrecciati a disegnare angoli acuti impossibili e il dorso dei piedi, che luccica anche lui senza vergogna di muco bava umore, affonda attento al centro della coscia.
Intinge i polpastrelli nel liquido e si chiede chi le avrà mai insegnato a stare così, annodata e serena.
Vede una spiaggia dorata ed è mattino presto. Ci sono lei —Giulia—e due uomini, uno bianco e l’altro molto scuro. Uno giovane, con aria da cagnolone buono, alto e massiccio; l’altro di mezza età, secco e nodoso, con la faccia da maestro, un sorriso che abbraccia lei e l’altro uomo, la sabbia sotto di loro, il mare dietro di lui, che luccica, luccica, nel bagliore dell’alba.
Mike e Giulia sono seduti davanti all’uomo orientale, tutti e due seminudi, in costume da bagno, ma questo non sembra preoccuparli.
Giulia si sofferma sul suo aspetto. Ha i capelli lunghissimi. Non è mai stata così magra. Il viso è più maturo. Giurerebbe che è più grande, è cresciuta.
È grande, è cresciuta. Quanti anni ha?
—You are ageless… siete senza età.
Dice l’uomo secco.
—Sgombrate la vostra mente dal peso del passato e dalle preoccupazioni del futuro. Siete qui ora. Pensate all’ora… Focus on the moment.
“E come facciamo?”, si chiede la donna seduta sulla spiaggia.
Il pensiero rimbomba fino all’altra donna che si è appena svegliata nella polpa molle.
—Come facciamo? —, chiede la Giulia magra con la faccia matura. Ma la domanda fioca si perde nel boato del suono pronunciato dal maestro che la guarda, incoraggiante.
—OOOOoommmmmmmmmmmmm!
Non ha mai udito niente di così potente. È una vocale semi-cantata che parte dal fondo della pancia, dalla base della spina dorsale, e continua costante, avvolgente e rovinosa come un buco nero. Lentamente il senso di pericolo si smorza man mano che il suono si assottiglia, infrangendosi contro il muro nasale della emme. Dal basso all’alto, percorrendo tutto il corpo, il monosillabo rompe il silenzio, sovrasta maestoso il mormorare delle onde all’alba.
—OOOOOOooooooommmmmmmmmmmmmm.
Ancora più potente: le voci sono due, quella dell’uomo secco e quella di Mike. Fra poco Giulia dovrà unirsi a loro ma resiste per qualche minuto. Si lascia cullare dal senso di vuoto che proverà quando comincerà a precipitare.
—Focus on the OM to focus on the moment… Concentrandoti sull’OM, ti concentri sul presente.
Lei ridacchia. È imbarazzata. Vorrebbe credere a quello che dice il maestro, vorrebbe lasciarsi tutto alle spalle. Il passato le pesa addosso come un macigno.
—Swami—, dice Mike.
Swami lo guarda e annuisce. Mike intona l’OM e allora ci prova anche lei, ci si butta dentro nel buco, senza pensarci, senza chiedersi nulla, sperando di arrivare tutta d’un pezzo.
All’inizio non succede niente. Canta e basta. Respira e basta. Canta e respira. Respira e canta. Va avanti così per quella che sembra un’eternità, alternando momenti di solo respiro, durante i quali Swami recita dei brani mezzi cantati e mezzi parlati in una lingua sconosciuta, e momenti in cui invoca di nuovo il vuoto del presente emettendo l’alto grido dell’OM.
 « Laura & Paula in an interior (The lockdown & breakdown series) » © nerosunero (Mario Sughi)
« Laura & Paula in an interior (The lockdown & breakdown series) » © nerosunero (Mario Sughi)
Ed è proprio durante una delle pause, quando respira e basta, che succede.
Entra in una stanza, si vede entrare in una stanza. È nella sua infanzia. È una bambina.
You are ageless… siete senza età. Così aveva detto Swami.
È ad una festa di capodanno, è molto tardi, suo padre abbraccia una donna che non è sua madre.
You are ageless… siete senza età.
Qualcuno la scuote. Sussulta. Non si muove. La bambina nella stanza si muove e va a cercare mamma, gira per la stanza e non la trova.
Qualcuno la scuote ancora. Giulia sente il respiro che si fa leggero e ansimante. Sente il rumore del suo respiro. La porta della stanza si chiude. Apre gli occhi. A fianco a lei c’è Swami che la scruta con aria preoccupata e fiera. Le chiede di descrivergli che cosa ha visto. Lei gli dice del passato, della stanza e del ricordo. Gli dice che non aveva alcuna memoria di quello che ha visto ma sa che è successo.
—You have gone through the first door. There are another nine waiting for you… Sei passata dalla prima porta. Ce ne sono altre nove che ti aspettano.
Altre nove? Sente un vago senso di soffocamento. E che ci sarà alla fine? Che cosa troverà?
Meglio chiudere tutto, scappare via, buttare la chiave.
—How old are you? How old were you in your vision?… Quanti anni hai? Quanti anni avevi nella tua visione?
Gli risponde che ha ventinove anni e che nella visione ne aveva cinque o sei.
A Swami piace la risposta di Giulia. Le sorride ma lei è inquieta. All’improvviso la sua calma si sgretola, non riesce più a stare ferma. Non sa cosa le succeda. Chiude gli occhi, cercando di recuperare il senso di serenità che la pervadeva qualche minuto prima.
Quando li riapre —o almeno ci prova— è nella terra abbagliante, dove la luce ti ferisce lo sguardo e il corpo è coperto di umore. È sola, con la schiena dritta come un fuso, le gambe ancora piegate a disegnare spigoli improbabili.
Qualcosa l’ha disturbata ed è tornata indietro, come da un lungo viaggio. È stata quella risposta: « ho ventinove anni ». È sicura di non averne tanti, è più giovane, ma per quanto cerchi di strizzarsi la coscienza ed attivare la memoria, non c’è niente lì dentro. Aria compressa in una scatola vuota.
Chi è poi lei, veramente? È quel corpo nudo, fluido, bagnato di luce? È il miscuglio di lembi di passato e sprazzi di futuro intravisti tutte le volte che tocca la pozza che la cinge?
—Bisogna che qualcuno mi dica io chi sono.
Si guarda intorno con gli occhi semichiusi per arginare l’assedio della luce. Non c’è nessuno. Finalmente si snoda dalla posizione del loto, sospirando di sollievo per aver ritrovato l’uso degli arti. Un formicolio risale lungo i nervi e getta scariche di piacere tra la schiena e l’inguine.
Stira prima le gambe poi le braccia tendendole verso l’alto. Per la prima volta si accorge che non ha freddo, e mentre succede percepisce una lieve pressione fra collo e omeri. Si sporge a guardare verso destra, con una leggera torsione, e allora la vede: una coperta rosso vino, soffice, calda come il suo colore. In parte pende dalla spalla destra e in parte è afflosciata in un mucchio. Luccica di umore anche lei. In mezzo a tutto quel bagliore monocromo in cui a stento si riescono a distinguere le forme, la macchia di colore le sembra all’improvviso bellissima. Sente un moto di emozione violenta: il colore rosso le fa venire voglia di mangiare, ballare, nuotare, ridere, fare l’amore. È così felice che sente lacrime premere dal retro dei suoi occhi. Ed è proprio quel rigurgito di passione che aiuta a lubrificare la fessura tra le palpebre e le permette di spalancare finalmente gli occhi.
È nella terra della luce, circondata da masse senz’ombra che si riflettono nella distesa d’acqua eburnea intorno. Non è lei sola a grondare umori, è tutto il mondo. Poi però realizza che niente è davvero liquido. Le sembra tale perché è lucido e riflette tutto il resto. Guarda il suolo davanti ed emette come un guaito. C’è un’altra Giulia, vestita di tutto punto, che la guarda con orrore, i capelli umidi attaccati alla testa, il roseo della pelle solcato da luccichii.
Un grande specchio, il mondo: e lei nuda al centro.
Riprende lo sforzo di ricordare come ha fatto ad arrivare lì, tenta di evocare altre facce che non siano quelle di sua mamma che le dava la farina lattea, o Swami e Mike che faranno yoga con lei in un futuro più o meno prossimo. Cercando di non farsi distrarre dalla sua immagine vestita allo specchio, si alza in piedi e si mette a camminare. Fa aderire la coperta rossa al corpo nudo, più per evitare di guardarlo che per il freddo.
Benché adesso si veda tutta intera, nessuna memoria è associata a quella pancia, ai capelli lunghi e scuri, agli occhi grandi, il seno tondo, i fianchi alti. È come se fosse il corpo di un’altra. Si riconosce, sì: sa di essere lei. Ma per quello che l’immagine le suggerisce – lo zero totale, il buco nero, lo scatolone vuoto – potrebbe anche essere un’altra, una sconosciuta.
Cammina piano, attenta a non scivolare sul pavimento che ha la consistenza del ghiaccio.
Cammina per ore, nomade, nel paesaggio lunare. Ogni tanto si ferma e ci sono porte che sbattono.
Slam!
La spiaggia è lontanissima. Oppure è lei ad essere minuscola? Nuota nel mare agitato. C’è corrente, si è sfilata una pinna. Qualcosa la tira sotto. Ingoia sabbia e sale, sabbia e sale. Vuole gridare ma ha l’acqua in bocca. Il mare gliela spinge in gola, gliela tappa con la sabbia. Sotto è buio. Dov’è mamma? Un cavallone la sperona verso il largo. Sotto è buio. Adesso sente solo voci.
—Giuliaaa!
Qualcuno la chiama ma lei non può rispondere.
—Giulia, pesciolino, dove sei?
Il telo da mare in cui la avvolgono è rosso vino, soffice soffice. Mamma la culla piano. Se fosse rimasta più a lungo in acqua avrebbe eiettato branchie, secreto muchi lucenti nel tessuto di scaglie grigioazzurre. Avrebbe nuotato felice, per sempre, con una pinna sola.
Slam!
Cammina per ore, finché un addensarsi dell’aria, come una spessa nube di vapore, la attira verso di sé, rompendo la monotonia, il senso di vertigine, dello specchio nitido e compatto. Giulia procede spedita, come se sapesse dove andare, come se quel luogo fosse già noto a qualche cellula del suo cervello che si rifiuta di venire a coscienza. Si fa spazio nella nebbia sottile che ha consistenza di velo: una cortina, una tenda forse. Una portafinestra, infatti.

« Nudo con coperta rossa » © Emma Del Vecchio
Con cautela entra in uno spazio perfetto, di cui riconosce la mappa, anche se non si sofferma su nessun particolare. Sa di trovarsi in un luogo familiare, un luogo suo, ma lo sguardo non registra niente a parte il confine tra quel luogo e il mondo che si estende oltre l’apertura dalla quale è entrata. Sul perimetro della stanza ci sono finestre su tre lati e una portafinestra sul quarto. La luce scorre incessante e rimbalza da una parete di vetro all’altra.
« Vengo da qui », pensa, « questa è casa; forse ci sarà qualcuno che mi aiuterà a ricordare ».
Si volta verso destra e vede una sedia imbottita accostata ad una scrivania dove riposa un parallelepipedo di plastica grigia con delle lettere disegnate sopra.
« Non è una macchina da scrivere ».
C’è un tasto che dice on: lo preme. Contemporaneamente si accorge di uno schermo davanti a lei che somiglia a una TV. Si illumina di trattini bianchi lattiginosi che pulsano piano, come se avessero una vita dentro. Compare una data: 12 agosto 1981.
Giulia fissa un trattino che ha un triangolino accanto e cerca di capire cosa sia. E mentre lo fissa, sfiora le lettere grigie dei tasti di plastica e vede altre lettere disegnarsi sullo schermo nero. Un gocciolio biancastro si sparge sul televisore e la sua testa si riempie di immagini colorate, come quando era stesa sul lago di latte fuori e toccava il liquido untuoso sparso addosso e intorno a lei.
Un pensiero selvatico la afferra e sgrana gli occhi, li lascia guizzare rapidi dall’umore del suo corpo alla luce fluida dello schermo, due volte, tre volte, dieci, venti.
Mezza ipnotizzata, posa le mani sui tasti e le lascia partire, come se sapessero dove andare.
Giorni, mesi, anni si mettono a scorrere davanti ai suoi occhi in un fotomontaggio continuo.
Una magia del corpo che distilla luce dal suo muco, e quella luce tradotta dalla macchina diventa la sua storia dimenticata.
“Ecco chi sono. Finalmente ci sono. Mi sono trovata. Dentro lo schermo. Sono io”.
Enrica Maria Ferrara
Foto di copertina: « Visioni invivibili » © Federica Cerami


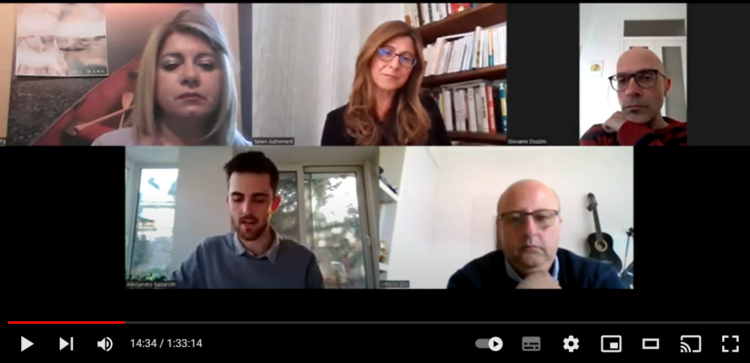

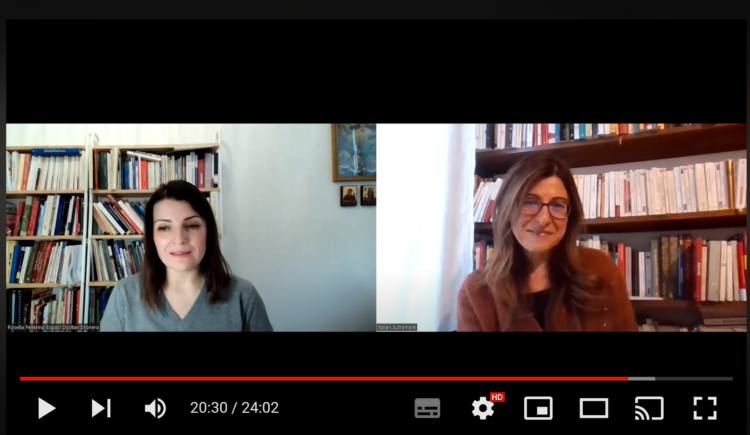
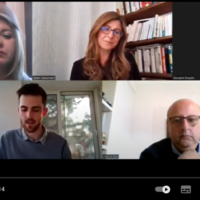

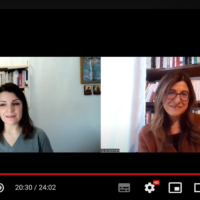

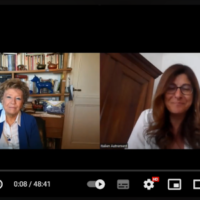








Comments
Almeda Kleiber
My site QH9 covers a lot of topics about Car Purchase and I thought we could greatly benefit from each other. Awesome posts by the […] Read MoreMy site QH9 covers a lot of topics about Car Purchase and I thought we could greatly benefit from each other. Awesome posts by the way! Read Less
Massimo
Quando si legge per la prima volta una scrittrice (lo si fa anche per i maschi) ci si domanda quale altro o altra può, […] Read MoreQuando si legge per la prima volta una scrittrice (lo si fa anche per i maschi) ci si domanda quale altro o altra può, in qualcosa, somigliargli. Io ho pensato sia all'autore che a un suo libro: Michael Ende e "lo specchio nello specchio". Quando una cosa a inizio nel momento in cui si scaricano gli orologi la cosa si fa molto interessante, addirittura troppo, ma ce lo si ricorda per tutta la lettura e così illumina tutto il narrato. Nella storia c'è quello che facciamo continuamente, anche nelle cose più quotidiane, ma a volte ci sfugge anche davanti a uno specchio, e questo racconto ti mette davanti a questo fatto, ti fa essere curioso di come va a finire, e dice una cosa assoluta: vai sempre a finire dentro di te anche quando sei sicuro di essere altrove. Grazie Enrica Read Less