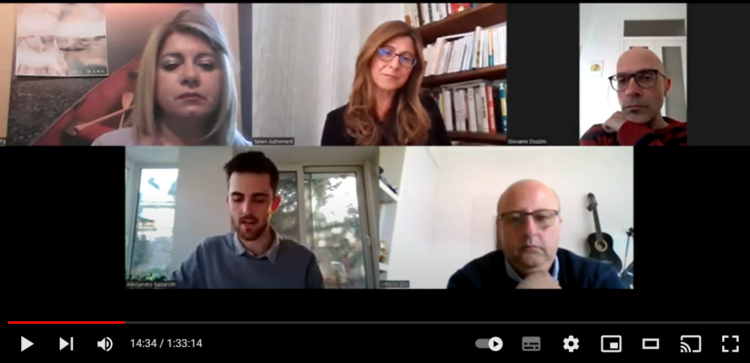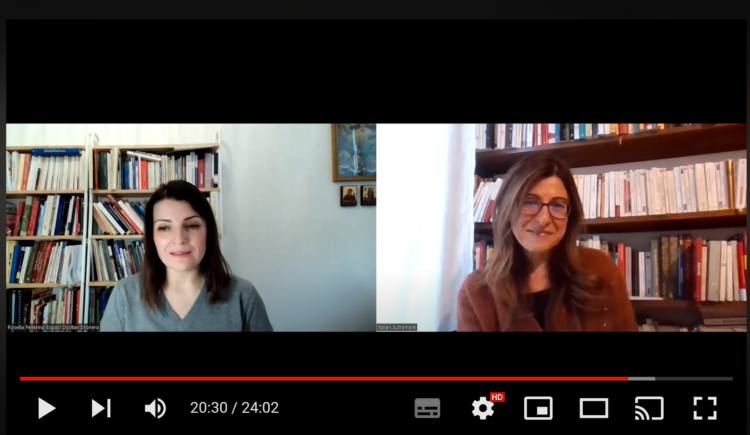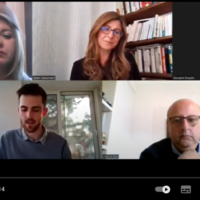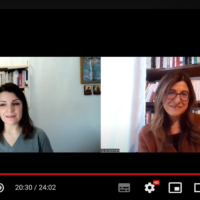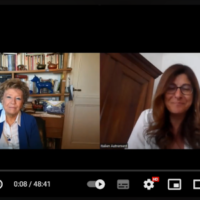120 km da est a ovest, 2500 km di terrazzamenti, 850 ettari di vigneto, un vitigno dal nome difficile e sconosciuto ai più, una storia millenaria, come spesso accade in Italia. Ecco, questo è il mio habitat, riassume brevemente Andrea all’affascinante turista alla quale, insieme ai rudimenti dello sci, vorrebbe trasmettere l’essenza del suo mondo.
Ma perché, poi? Come molti, è ospite della valle per una settimana bianca low-cost alla fine di febbraio.
Ogni volta Andrea si rende conto di quanto, durante la stagione turistica, due universi siano a stretto contatto, senza mai vedersi veramente.
E di come tutti siano prigionieri di stereotipi difficili da scardinare. Lui, per esempio, il maestro di sci. Un po’ come il bagnino della costa romagnola, no? Aitante, sportivo, abbronzato, con quel fascino un po’ rustico che colpisce le donne, le quali più che impegnarsi sulle piste da sci, rivaleggiano la sera in discoteca contendendosi le sue attenzioni.
Che poi ci sarebbe poco da lamentarsi. Non per Andrea, maestro di sci, ed enologo. Vero rappresentante di questa terra, la Valtellina, connubio secolare di montagna e viticoltura; eroica, come la definiscono adesso.
Lei, Virginia, romana, poco più che trentenne, non immagina tutto questo. La storia, quella vista sui libri di scuola, parla della sua città, non delle montagne; forse ricorda qualcosa riguardo Annibale e gli elefanti, più un’immagine sul sussidiario che altro.
Guarda stranita quest’uomo, poco più adulto di lei quanto ad età, ma con una pacatezza e una solidità interiore che non riconosce nei suoi coetanei in città.
E così lo ascolta, in questo suo racconto, in cui le parole fluiscono descrivendo un mondo a lei totalmente sconosciuto.
Bormio, Madesimo, Livigno, non sono solo luoghi per sciatori della domenica, che nei fine settimana invernali si incolonnano sulla statale 38 per raggiungere le mete sciistiche. I turisti, concentrati sull’obiettivo, si perdono il viaggio, il paesaggio, l’incredibile scenografia che si dipana alla loro sinistra, eredità di una popolazione che ha fatto del vivere in quota un’arte.
Risalgono al IX secolo, in pieno Medioevo, le prime testimonianze del binomio Valtellina – viticoltura. Probabilmente, come ovunque in Italia, la vite e il vino erano esperienza quotidiana da molto tempo prima. Ma qui è diverso. La vite, in questa valle che si allunga da est a ovest, cresce dove, prima dell’intervento antropico, c’era la nuda roccia. Non un terreno più o meno vocato. Solo roccia.
Sente, Virginia, un termine ostico, enfiteusi. Il significato glielo spiega Andrea, in poche semplici parole, come suo solito. Perdendosi un po’ nei suoi brillanti occhi blu precisa che si tratta di un contratto di affitto di durata indeterminata, con pagamento in natura e una particolarità.
La pausa, un po’ teatrale in verità, serve ad Andrea per riprendere il filo del discorso.
Il canone d’affitto non cambiava al mutare del valore del fondo; pertanto il conduttore beneficiava della maggiore produttività derivata dall’eventuale miglioramento fondiario. Questa clausola lo stimolava a intraprendere lavori onerosi come la costruzione dei terrazzi sui quali far prosperare la vite. Il lavoro necessario per rendere fertile la nuda roccia, in caso di cessazione del rapporto, veniva ricompensato in misura del miglioramento apportato.
Le parole risuonano nell’aria fresca della sera, e Andrea rivede gli antichi abitanti della valle costruire il proprio futuro e preservare il presente. Coltivare in quota, proteggeva i raccolti dalle rappresaglie dei barbari che scorrazzavano nel fondo valle e dalle piene improvvise dell’Adda.
Il versante dedicato alla viticoltura è esclusivamente quello Retico, posto a nord, più esposto al sole grazie alla minore altezza delle cime del lato Orobico, la cui quota massima raggiunge i 3050 m con il Pizzo Coca – pochi rispetto al Bernina che supera i 4000 m. Anche la composizione pedologica è diversa: il versante settentrionale, formatosi dalla disgregazione delle rocce, è sabbioso e povero di sostanza organica, e per questo motivo i muretti a secco, una volta costruiti interamente a mano, sono riempiti della fertile terra portata in quota dal fondo valle. Oggi, parte del lavoro viene eseguito con l’ausilio dell’elicottero; un lavoro ancora difficile e dai costi altissimi.
Virginia, presa dal racconto, lo fissa rapita, percependo una forza e una fierezza che annientano il ricordo dei timidi balbettii dei suoi amici, impiegati nell’apparentemente dorato mondo del marketing.
Chiavennasca, il suono duro della parola la riporta alla realtà. Sembra quasi una parola scurrile. No, si tratta del nome del vitigno del posto.
Lo interrompe, ricorda un cartellone pubblicitario intravisto arrivando, un hashtag che definiva il vitigno valtellinese “Nebbiolo delle Alpi”, e le era sembrato un approccio giovane, facile…
Nota un leggero tremito nelle iridi blu del ragazzo. Non è così semplice, ribatte.
«Qui siamo molto fieri delle nostre tradizioni, della unicità dei nostri prodotti. Chiamare il nostro vitigno Nebbiolo vuol dire allentare il legame con il territorio; una buona strategia di marketing, forse, soprattutto nei confronti di chi ci conosce poco. Ma per noi è e sarà sempre Chiavennasca, un nome dall’etimo incerto, dalle molte interpretazioni. Quella più accreditata, da queste parti lo fa discendere da un termine italianizzato del dialetto di Sondrio “ciù vinasca”, ossia uva più vinosa, maggiormente adatta alla trasformazione in vino. Il termine sembra fosse già utilizzato sin dall’undicesimo secolo, ma sistematicamente, in documenti scritti, solo dal 1600.
Una tradizione antica, quella del vino, non solo per autoconsumo come in molte altre parti d’Italia, ma, soprattutto, e qui l’orgoglio riemerge prepotentemente nella calda voce di Andrea, quale prodotto di qualità da esportare.
Il dominio dei Visconti e degli Sforza nella valle diede nei secoli XIV e XV un notevole impulso alla viticoltura, ma è sotto il dominio dei Grigioni (1512-1797) che il vino prodotto da uva Chiavennasca venne sempre più apprezzato presso le corti del Centro e Nord Europa. La buona acidità e il notevole tenore alcolico lo preservavano durante il trasporto, i cui tempi vennero notevolmente ridotti grazie all’apertura di una nuova via commerciale attraverso il passo del Bernina.
L’entrata della Valtellina nella Repubblica Cisalpina capovolse radicalmente lo scenario; il mercato di riferimento divenne Milano che richiese sempre maggiore quantità di prodotto a scapito, talvolta, della qualità.
Oggi, la viticoltura in Valtellina è definita eroica, ma cosa significa? Grandi sforzi, enormi sacrifici, meccanizzazione impossibile, tutto da fare rigorosamente a mano in luoghi impervi. Ti domanderai chi ce lo fa fare.
Visto dall’esterno, dal punto di vista di chi vive in città, forse non ne vale la pena. Ma noi vogliamo salvaguardare e conservare il nostro territorio e soprattutto farlo conoscere, anche attraverso i profumi dei nostri vini. Sono profumi e sapori unici e inimitabili, che possono scaturire solo da queste rocce, sapientemente domate dal lavoro dell’uomo nel corso dei secoli».
Nel calice si sprigiona un profumo soave e ammaliante di frutti rossi, ribes e mirtillo; un fresco, interminabile sorso invade la bocca. Un vino austero, ammorbidito da note di prugne mature e spezie dolci.
Virginia scorge l’etichetta, legge “Inferno”, Andrea anticipa la domanda. Si tratta della più piccola delle sotto denominazioni del Valtellina Superiore DOCG il cui nome, molto verosimilmente, deriva dall’asperità dei suoi piccoli terrazzamenti vitati.
Ogni piccolo appezzamento di terreno racconta le fatiche di uomini e donne che hanno creato la viticoltura in Valtellina, opera unica e testimonianza della cultura alpina riconosciuta anche dall’UNESCO, che nel novembre 2018, ha dichiarato l’arte dei muretti a secco “Patrimonio Immateriale dell’Umanità”.
Maria Grazia Pennino