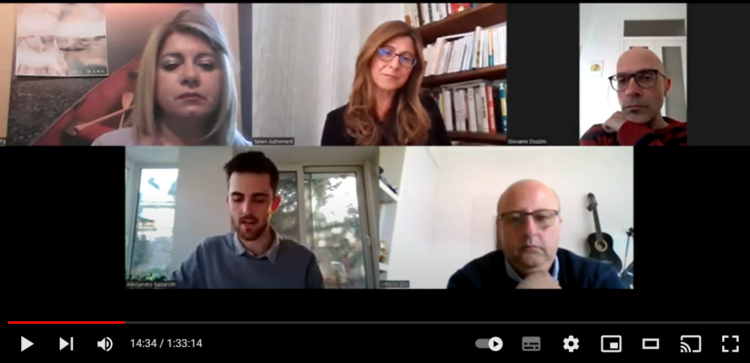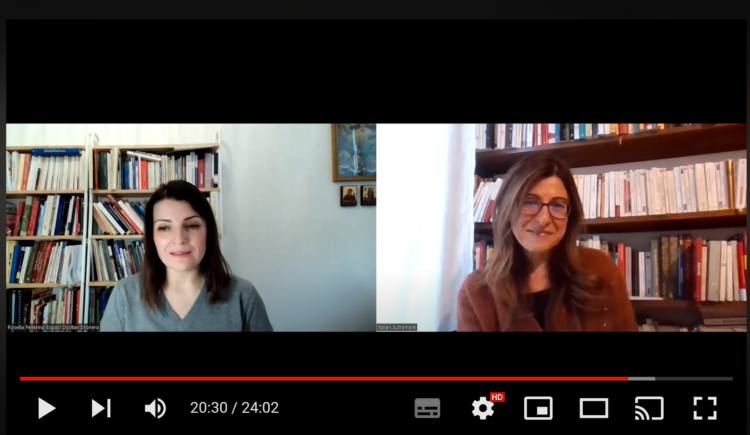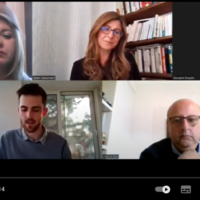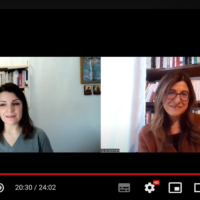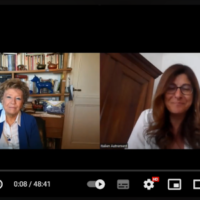Abbiamo intervistato il Maestro Giampaolo Pretto, Primo Flauto dell’Orchestra Nazionale della RAI, solista e direttore d’orchestra. Giampaolo Pretto, dal 1986 primo flauto dell’Orchestra Rai, da quasi quarant’anni è tra i protagonisti della scena artistica italiana e internazionale nei ruoli di solista, camerista e direttore d’orchestra: da sempre si misura con un repertorio che spazia dal barocco alle avanguardie. Ha inciso decine di cd, tra cui spiccano l’integrale di Mozart con la European Union Chamber Orchestra, i brandeburghesi per Amadeus, il Concerto di Petrassi col Maggio Musicale Fiorentino, quello di Fedele con la Nazionale Rai, il Concierto Pastoral di Rodrigo con la Filarmonica di Torino, l’integrale debussiana per Warner. Ha tenuto gremite masterclass in flauto e musica da camera per primarie istituzioni quali il MusicaRivaFestival, l’Accademia Perosi, l’Accademia Chigiana e la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2000 al 2018 è stato docente dell’Orchestra Giovanile Italiana e dal 2016 è direttore principale dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Ha diretto e dirige regolarmente anche altre primarie Istituzioni italiane e internazionali come l’Orchestra di Padova, la Haydn di Bolzano, il Petruzzelli di Bari, la Wuhan Philarmonic, la Toscanini di Parma.
Fondatore del Quintetto Bibiena, gruppo di fiati premiato all’ARD di Monaco 1993, si diploma anche in composizione al Conservatorio di Torino e studia direzione con Piero Bellugi. Nel centenario della morte di Debussy la casa editrice Durand ha pubblicato la sua trascrizione per quintetto della seconda Sonata. Nel 2014 fonda il Dils, scuola flautistica basata sul suo libro Dentro Il Suono, adottato da migliaia di studenti e docenti dal 2013 a oggi. Assegnatario di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il “Barison” nel 1987, il “Siebaneck-Abbiati” nel 2003 (col Quintetto Bibiena), il «G.F. Pressenda» nel 2008, è stato oggetto di due ritratti monografici su Sky Classica.
M° Pretto, lei, sin dalla giovinezza, ha ricoperto anni il ruolo di Primo Flauto dell’Orchestra Nazionale della Rai e, nel contempo, ha svolto attività solistica, di concertista, sia in Italia sia all’estero, collaborando con le più prestigiose orchestre del mondo. Sono oltre dieci anni, inoltre, che si dedica anche alla direzione orchestrale. Ci racconta brevemente la storia della sua carriera musicale?
Iniziai nei primi anni settanta gli studi musicali in una banda di provincia, come molti miei colleghi strumentisti a fiato. Le bande nel nostro Paese hanno spesso rivestito la funzione di incubatori del talento. A dieci anni entrai al Conservatorio di Verona e undici anni più tardi, dopo diverse esperienze analoghe, approdai alla professione stabile nel ruolo di primo flauto alla Rai di Milano. Nel 1994 passai nella Sinfonica Nazionale Rai a Torino. Ho ormai alle spalle quasi quarant’anni di professione: il primo concerto in ambito professionale risale al 1981, avevo sedici anni. Sono stato fortunato, ho avuto il privilegio di potermi cimentare nella musica da camera così come nel solismo, ma tenendo come riferimento costante l’orchestra. Fare musica attraverso il mio strumento ha rappresentato per trent’anni lo scopo principale della mia vita, che ho anteposto a qualsiasi altro aspetto dell’esistenza: la direzione d’orchestra, che pratico da tempi più recenti, ha solo cambiato il mezzo con cui esprimermi. Recentemente un mio allievo, riferendosi all’impegno necessario per arrivare al professionismo nella musica classica, se n’è uscito con una frase che mi ha colpito: “fare musica è un po’ come andar preti”! Si riferiva ovviamente al sacro fuoco vocazionale che noi musicisti spesso nutriamo nei confronti della nostra scelta e al lavoro arduo che ne consegue.
Riferendoci al suo percorso recente, in cui ha intensificato notevolmente la sua attività direttoriale possiamo parlare di un’evoluzione naturale o di una scelta, forse a lungo ponderata? Quali sono, nel caso di un musicista di ampia esperienza, i presupposti necessari per virare, in modo onesto e professionale, verso la direzione orchestrale?
Nel mio caso si è trattato davvero di un’evoluzione naturale. Vivere per decenni all’interno di grandi compagini sinfoniche, respirarne l’aria, provare il carico emozionale di innumerevoli esecuzioni dal vivo, ha sviluppato pian piano dentro di me l’esigenza o forse, di nuovo, la vocazione, di vivere un’ esperienza così straordinaria anche dal podio. Mi sono scoperto, fin dall’inizio e in misura sempre crescente, ad analizzare e osservare ogni minimo gesto dei direttori (spesso eccellenti) che mi trovavo davanti; tant’è che spesso memorizzavo velocemente la mia parte pur di non distogliere gli occhi dal podio per minuti interi. Questo credo abbia alimentato la mia curiosità e allenato quell’ occhio clinico del professionista d’orchestra che sa valutare in base a una lunga esperienza ciò che in un direttore funziona e perché. Naturalmente ho sempre cercato di osservare con la stessa attenzione anche ciò che non funziona, ciò che “non” bisogna fare. Con queste premesse devo riconoscere che, fin dall’inzio, salire sul podio è stato per me un passaggio naturale ed emozionante al tempo stesso, che mi ha fatto subito sentire a mio agio. Tale passaggio esistenziale è simile, in fondo, a quello di molti attori che dopo aver recitato in decine di film sentono il desiderio di passare dietro la macchina da presa. Naturalmente sentire questa esigenza non basta di per sé a creare un direttore, così come aver suonato per anni in orchestra non è di per sé la garanzia di saperci fare. Si deve integrare questa piattaforma arricchendola di ogni possibile nozione: prima di permettere a me stesso di salire di fronte a un’orchestra professionale, per esempio, ho ritenuto doveroso e necessario prendere un diploma in composizione. Le partiture sono creazioni molto complesse, e affrontarle senza una robusta preparazione teorica a mio parere non è onesto: per capire il compositore bisogna cercare di mettersi nei suoi panni e ripercorrerne con tutti i mezzi possibili ragionamenti e scelte. Al tempo stesso però si tratta anche di un mestiere molto pratico, che richiede ore di esperienza diretta sul campo, un po’ come guidare: non basta capire la teoria, bisogna fare tanta strada imparando dai propri errori. In questo ho avuto il privilegio di lavorare per anni su centinaia di partiture come istruttore dell’Orchestra Giovanile Italiana a Fiesole. Si è trattato di un apprendimento collettivo, io da loro e loro da me. Indimenticabile e, nel mio caso, decisivo per poter affrontare questa nuova professione senza sentirmi inadeguato.
La musica è un linguaggio universale, forse il più diretto ed incisivo in termini percettivi, emotivi. In termini di performance, un sostantivo oggi molto di moda, quali differenze esistono tra la responsibilità del solista e quelle del direttore?
Dal punto di vista del linguaggio utilizzato nessuna: si tratta di fare arrivare un messaggio, spesso complesso e alto, scritto in una lingua accessibile solo ed unicamente nella transitorietà del fenomeno sonoro. A differenza delle arti visive o della letteratura, la Musica vive secondo tempi e modi dettati dall’interprete e non personalizzabili da ciascuno secondo la propria sensibilità. Il violinista suona uno strumento, il direttore suona l’orchestra. La musica dal vivo funziona come il Teatro: degli attori leggono un testo dopo averlo sviscerato in profondità. Gli attori sono i musicisti d’orchestra e il regista è il direttore. La prima parte del lavoro di entrambi consiste nelle prove e nella “concertazione”, momenti affrontati dal regista o dal direttore con lo stesso scopo: fare in modo che tutti diano il meglio e che vi sia una coerenza interpretativa di cui egli è l’ultimo responsabile. Il direttore ha in più il compito di guidare la performance vera e propria in tempo reale, differentemente dal regista che se ne può anche andare: e in questo consiste la sua maggiore responsabilità rispetto al musicista-attore. La performance è un atto unico, irripetibile e inemendabile che non si può correggere lungo la rotta. Un direttore deve racchiudere in sé la profondità di visione del regista e il controllo dei riflessi di un pilota: mandare l’orchestra per aria è davvero un rischio da evitare a qualsiasi costo e richiede preparazione e sangue freddo. Questo forse è qualcosa che spesso sfugge agli spettatori meno addentro al fenomeno musicale, i quali pensano che un direttore si limiti a “decorare” con qualche gesto aulico qualcosa che esisterebbe comunque. No, non è decisamente così. Ciò che è visibile di un direttore non è che la punta di un iceberg, cui viene atttribuito mediamente troppo valore, spesso anche dai musicisti stessi. Ciò che fa davvero la differenza è il decollo della qualità del lavoro dalla prima prova al concerto, qualità di cui il direttore dev’essere garante.
Tornando alla sua carriera solistica, lei ha recentemente (2017) inciso l’opera omnia di Claude Debussy per Flauto. Ci racconta il suo rapporto con questo autore – tra i contemporanei, uno dei più prolifici per ciò che riguarda questo strumento – e la sua lettura?
Debussy è uno dei santi del mio Pantheon laico. Si tratta non solo di un genio assoluto e universalmente riconosciuto, ma di uno dei più grandi testimoni creativi di uno snodo storico-poetico tra i più decisivi della civiltà occidentale: quel passaggio tra il tardo ottocento e il secolo nuovo che ha prodotto una delle più alte concentrazioni di capolavori mai viste in ambito artistico. Ogni sua nota, ogni suo colore sono in grado di evocare paesaggi e mondi di varietà estrema. Debussy amava molto il flauto, forse perché è uno strumento la cui peculiarità poetica, in virtù della sua esilità, sta in ciò che suggerisce piuttosto che in ciò che afferma esplicitamente. Per questo ho deciso di intitolare il mio album “Ouïr la lumière”, ovvero “udire la luce”, riprendendo una sinestesia che Mallarmè attribuisce alla musica di Debussy. Avevo un bisogno quasi fisico di realizzare quest’incisione: si tratta di un omaggio scaturito dal cuore e dalla ragione, frutto di un lavoro di affinamento strumentale e musicale (contiene anche mie trascrizioni) durato quasi un decennio.
In termini di cross-medialità, esistono, tra la musica e la narrativa – sia essa prosa o poesia – alcune caratteristiche strutturali comuni: la metrica, il ritmo, il climax, le assonanze, le dissonanze, i vuoti, le assenze, il silenzio, le frasi. Qual è il suo rapporto con la letteratura? E, nello specifico, con l’Opera, con il binomio musica e libretto?
Debussy stesso ha definito la Musica come “il silenzio che sta tra una nota e l’altra”. Penso che la Musica sia letteratura sotto altra forma, e che come la letteratura si proponga di parlare dell’Uomo all’Uomo. Partendo dalla fine della domanda, di cui condivido in pieno il senso, ho imparato strada facendo che anche la musica cosidetta “pura”, ovvero strumentale senza supporto testuale, dispone di un libretto non scritto e di una sceneggiatura rigorosa, spesso direttamente proporzionale alla sua qualità intrinseca, quale ne sia l’epoca o lo stile, e che talvolta trascende anche la forma. Effettivamente la metrica, l’alternanza di pieni e vuoti, i colpi di scena imrovvisi, il carico e scarico di tensioni sono molto simili a ciò che troviamo nei grandi poemi o romanzi. Spesso perciò affronto lo studio delle partiture più complesse così come leggerei un testo letterario, andando alla ricerca della struttura narrativa, di quell’architettura che tutto sottende e che si può e si deve portare alla luce. Penso anche che assimilare saldamente queste linee portanti sia cruciale per poter comunicare a chi ascolta l’opera nella sua interezza. È ovvio che si ascolta con molta più attenzione ed empatia chi, nel flusso della parola, sembra condurci lungo un filo mentale rigoroso e chiaro. Altrettanto a mio avviso significa interpretare un testo, parlato o suonato che sia. Bisogna farlo proprio e condividerlo ricreando artificialmente, grazie a una tecnica acquisita col cesello di anni, la freschezza della massima spontaneaneità, come se lo si stesse improvvisando. Come dicevo sopra, credo che recitazione e interpretazione musicale siano nella sostanza la stessa cosa: nell’Opera questa analogia è solo più evidente, essendo la musica avvitata saldamente alla trama e al linguaggio di un libretto, quello sì, fatto anche di parole.
La musica è considerata una forma espressiva asemantica, in quanto priva di un rapporto diretto tra il significante, la parte percepibile del segno (la nota, la frase musicale) ed il significato, il concetto cui tale nota è associata. Svuotata da ogni sovrastruttura concettuale, resta l’arte più diretta ed efficace, in termini di comunicazione. Come si pone, chi la esegue, nei confronti di questa potenza illimitata? Quanto, l’esecutore, è amplificatore di questa forza e, al contrario, quanto può esserne modulatore, riduttore?
Non mi sento del tutto d’accordo sul fatto che la Musica sia asemantica. Il segno infatti, non consiste solo nell’altezza e durata delle note, ma anche in tutta una serie di indicazioni agogiche e articolative, di suggerimenti emozionali ed interpretativi che si sono fatti via via più accurati nel corso di centinaia di anni di evoluzione della scrittura musicale. Se uno strumentista lo desidera può assegnare alla frase che sta eseguendo un carattere dolce, o aggressivo, o perentorio, o intimo (tutte indicazioni tracciabili in molte partiture); o ancora può dotare le note di una serie di pronunce, che arrivano molto chiaramente all’ascoltatore più attento, tramite l’uso di accenti, appoggi, fermate, sforzati e mille altri piccoli dettagli che costituiscono l’armamentario di un professionista. Tutto ciò trasforma il segno in un evento sonoro chiaro e tangibile, denso di significato, che arriva al pubblico sia sul piano emotivo che intellettuale al lume della forma percepita nel suo dipanarsi. Il fatto che tutto ciò non sia ottenuto attraverso l’uso della parola vera e propria rende il linguaggio musicale universale e fruibile dalle più diverse culture: nella maggior parte dei casi persone che non potrebbero capirsi se parlassero tra loro arrivano a intendersi perfettamente attraverso i propri strumenti musicali. Si tratta di un’esperienza che io stesso ho vissuto molte volte. Personalmente mi pongo nei confronti della forza della musica come un “conduttore” (non è un caso che in inglese direttore si dica proprio conductor), ovvero come il tramite necessario tra la ricchezza testuale dei capolavori che eseguo e la loro conversione in suoni capaci di arrivare in modo chiaro, ricco di dettagli e sfumature a chi ascolta. Ciò avviene in modo tanto più aperto e profondo quanto noi interpreti facciamo appello alla capacità di percezione e all’ intelligenza del pubblico: dandogli la possibilità per l’appunto di intus-legere, cioè arrivare a leggere dentro ciò che sente.
L’interprete, in questo senso, ha certamente un grande potere, e può modulare o caratterizzare la forza d’impatto di questa comunicazione: a patto di essere quasi ossessionato beneficamente dalla necessità di comunicare il testo, e di possedere tutte le tecniche più raffinate per fare scattare l’adesione di un ascolto profondo sul piano emotivo e intellettuale.
Intervista realizzata da Corrado Passi